Appunti e riassunto di Letteratura Italiana di Baldassari, UNIMI
Documento dall'Università degli Studi di Milano (unimi) su Appunti, Slide e riassunto del libro Antologia della letteratura italiana, Baldassari. Il Pdf offre un riassunto dettagliato dell'"Antologia della letteratura italiana" di Baldassari, utile per lo studio universitario di Letteratura, coprendo autori come Machiavelli, Guicciardini e Ariosto.
Ver más38 páginas
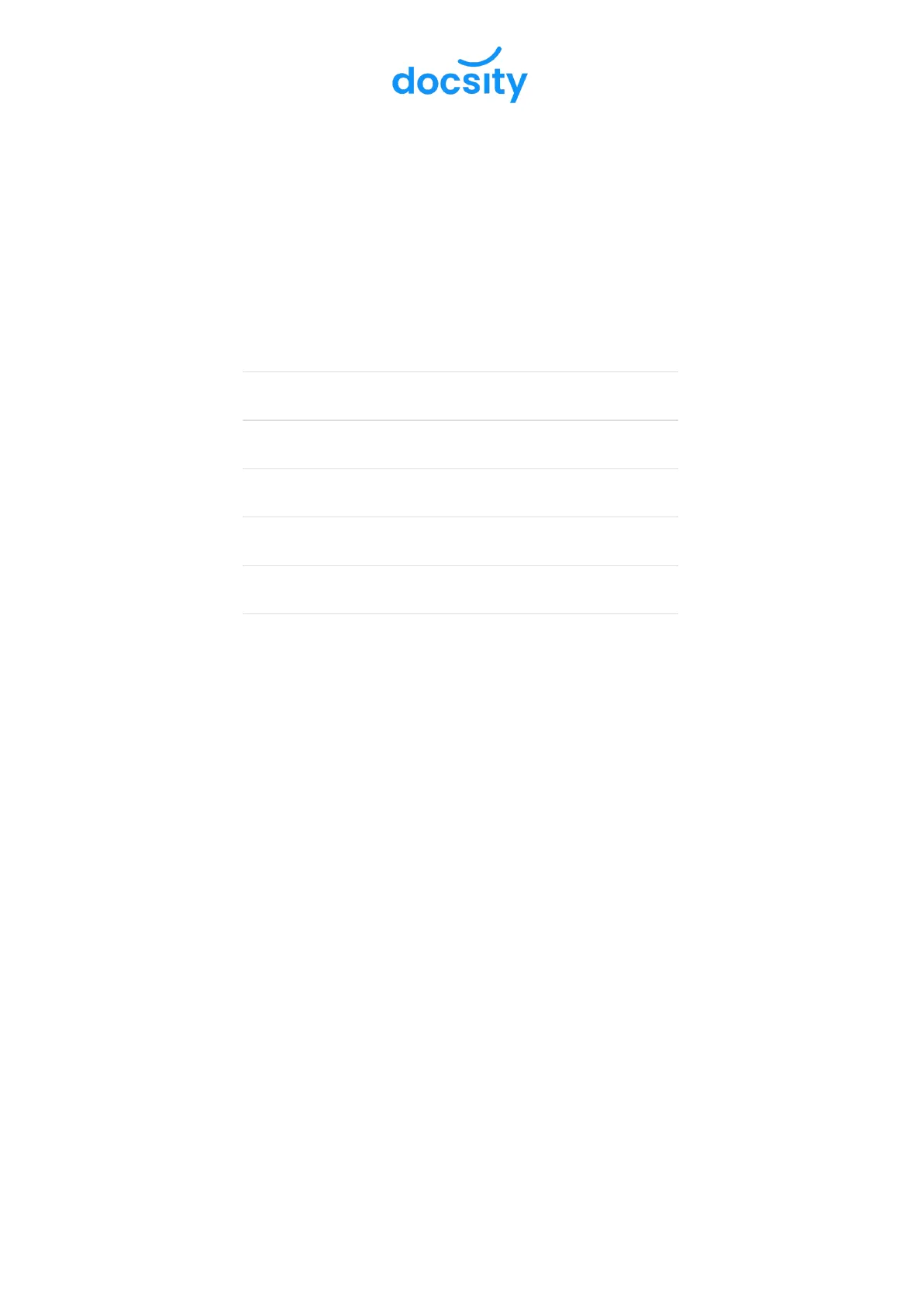

Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
docsity
Appunti, Slide e riassunto del libro Antologia della letteratura italiana, Baldassari Letteratura Italiana Università degli Studi di Milano (UNIMI) 37 pag. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: mia-ghezzi (mia.ghezzi@icstarra.edu.it)
Letteratura Italiana
Antologia della letteratura italiana: dalla Scuola poetica siciliana ad Alessandro Manzoni, Baldassari-Barucci Manuale di letteratura italiana medievale e moderna, Casadei-Santagata Appunti delle lezioni Document shared on www.docsity.com Downloaded by: mia-ghezzi (mia.ghezzi@icstarra.edu.it) Document shared on www.docsity.com Downloaded by: mia-ghezzi (mia.ghezzi@icstarra.edu.it)
La Poesia del '200
Il termine Dolce Stil Novo deriva dalla Divina Commedia di Dante Alighieri e indica un nuovo stile poetico divisibile in tre movimenti principali: la Scuola Siciliana (es. Giacomo da Lentini), i Siculo-Toscani ed il Dolce Stilnovo. Tali ripartizioni non sono così nette e precise, bensì indicano un periodo letterario frastagliato e complesso. Secondo ipotesi recenti, alcune testimonianze di poesia volgare italiana risalgono al IX-X secolo, come testimonia il ritrovamento di un testo in volgare di carattere amoroso. La poesia era breve e accompagnata dal suono della lira.
La Scuola Siciliana
La nascita della tradizione letteraria italiana è difficile da individuare: spesso il Cantico di San Francesco viene definito il primo testo in prosa, mentre l'inizio di una produzione poetica estesa e autonoma si identifica nella Scuola Siciliana. Molti dei primi autori appartenevano all'ambito giuridico del Meridione (come Latini o Guinizzelli), di conseguenza molti dei primi documenti in lingua italiana provengono dall'ambito notarile, come nei Memoriali Bolognesi, i quali utilizzavano versi poetici ai margini per rendere più difficile la contraffazione di documenti da parte di falsari e criminali. La Scuola nasce nel Sud Italia grazie alla figura del Re di Sicilia e Sacro Romano Imperatore Federico II di Svevia, uomo di grande dialogo culturale, che nella sua corte itinerante ospita una produzione letteraria in volgare siciliano nobile incentrata sul tema laico dell'amore: vi sono anche testi scritti da Federico stesso dall'attribuzione dubbia. Ci si interroga sulla sua possibile partecipazione e se sia stato un vero e proprio promotore di questa tradizione poetica, creando un progetto culturale alternativo a quello della Chiesa. La letteratura diviene lo strumento di affermazione di una élite politico-culturale, che utilizza la poesia lirica, anticamente accompagnata dalla lira, ma che si distingue dall'epica in quanto non destinata primariamente al racconto, di breve o media lunghezza, associata all'espressione di pensieri e sentimenti. Nella modernità, la lirica si identifica come lo spazio dedicato alla libera espressione di emozioni o sentimenti intimi dell'autore, diverse da quelle del Medioevo. I poeti della Scuola si sfidavano spesso in tenzoni, duelli di testi fra poeti: il dialogo è la parola chiave della letteratura e l'amore era l'argomento maggiormente discusso, ritenuto un qualcosa di esterno all'individuo, il quale cerca di oggettivare un processo visto come fisico e fisiologico dall'uomo del Medioevo e vissuto individualmente nel proprio intimo. L'amore dello Stilnovo, definito anche cortese da un filologo francese dell'800, Gaston Paris, indica l'ideologia connessa all'amore nelle corti della Francia del Sud medioevale. Anche nei rapporti amorosi si riflettono i rapporti politici, con una metafora sul vassallaggio: l'amante è qualcuno che si sottomette ad una dama di rango superiore, al di fuori del matrimonio, in un rapporto di amore irrealizzabile. L'amante ha la possibilità di ricevere una ricompensa ridotta a minimi cenni di riconoscimento da parte della donna amata. Nelle opere del '200, troviamo spesso la figura dei maldicenti, ossia coloro che tentano di insinuare discordie tra i due amanti. La tradizione dell'amor cortese nasce dai trovatori, poeti provenzali diffusi nella Francia Meridionale e nell'Italia Settentrionale: i poeti siciliani trasportano questa tradizione nel loro contesto, generando due fenomeni ben evidenti. Si ha, infatti, un trasferimento da una realtà caratterizzata da corti ad un'isola fortemente centralizzata, tralasciando il tema politico per concentrarsi completamente su quello amoroso. I poeti siciliani compongono la poesia sopra la lettura, senza l'apporto musicale, tipico della tradizione provenzale. L'elemento più innovativo della Scuola Siciliana è l'invenzione del sonetto, attribuita a Giacomo da' Lentini: 14 versi con una distribuzione preordinata dal punto di vista metrico (due quartine e due terzine in ABAB CDCD). Di questo periodo si ha una decimazione dei manoscritti, dovuta anche alla forte presenza del latino e da una frammentarietà territoriale.
I Siculo-Toscani e Guittone d'Arezzo
L'approdo della poesia è favorito dalla presenza di personaggi rilevanti e dalla corte federiciana. Il nome del movimento indica una continuità tra l'esperienza siciliana e quella toscana, ma caratterizzata da un cambiamento radicale a livello sociale: il passaggio dalla centralizzazione della Sicilia alla frammentazione, quasi un ritorno all'Italia dei comuni. Gli autori si occupano di politica e si riapre la possibilità di una nuova tematica per le poesie, diversa dall'amore. I problemi insorgono quando i testi vengono tradotti da un dialetto all'altro, generando imperfezioni tra le parole in rima. Nel 1265, trentenne, entra nella confraternita laica denominata dei Frati Gaudenti, impegnata nella fazione guelfa di vari comuni dell'Italia Centrale, Guittone d'Arezzo attua un cambiamento all'interno della sua produzione letteraria, passando da una di tipo cortese ad una moralistica e religiosa. Possiamo definirlo l'idolo polemico di Dante e, tramite quest'ultimo, possiamo ricostruire alcune parti della storia letteraria del '200 italiano: per Dante, Guittone era un modello ingombrante, avendo scritto di temi diversi da quello amoroso, con uno stile poetico artificioso e complesso e con un volgare troppo municipale. Nella poesia occitana si riconoscono due linee fondamentali: il trobar leu (lieve, comprensibile, gradevole all'ascolto); il trobar clus (asprezze verbali e un virtuosismo oscuro ed enigmatico). Dante, nel suo De Vulgari Eloquentia (1304-1305), accusa Guittone di artificiosità e di municipalismo nel suo scrivere, preferendo una lingua ed uno stile capaci di ampliare il raggio di Document shared on www.docsity.com Downloaded by: mia-ghezzi (mia.ghezzi@icstarra.edu.it) conoscenza su più aree della penisola. La prima parte della produzione di Guittone è basata sulla visione negativa dell'amore, una malattia dalla quale bisogna guarire. Nella seconda parte, critica la finzione cortese, dimostrando come tutto ciò celi l'unico e solo desiderio di possesso fisico.
Il Dolce Stil Novo e Guido Guinizzelli
Nella Storia della Letteratura Italiana di Francesco De Sanctis (1870), egli utilizza, dalla sua prospettiva di uomo del Risorgimento e di Ministro dell'istruzione dell'Italia unitaria, l'espressione Dolce Stil Novo per designare una tendenza della poetica fiorentina negli anni '80 del '200, diffusa ed attiva fino all'inizio del '300, (utilizzato anche nel Canto XXIV 49-63 del Purgatorio di Dante), un gruppo di poeti, legati da amicizia e stima letteraria, impegnati nella letteratura in volgare. In questo canto, Dante racconta la sua esperienza poetica precedente alla scrittura della Commedia e, tra i protagonisti, troviamo Bonagiunta Orbicciani, poeta di Lucca, situato del girone dei Golosi. Nel dialogo tra i due poeti viene citato il componimento Donne ch'avete intelletto d'amore, spartiacque nella concezione dell'amore di Dante, inserita nel testo giovanile Vita Nova. L'amor cortese vassallatico ed irrealizzabile si distacca dal bisogno di un riconoscimento da parte dell'amata e diviene quasi autosufficiente. Il poeta è appagato anche solo dalla possibilità di amare la donna (Nove Rime). Dante risponde con profonda modestia, caratteristica che lo accompagna durante tutto il suo viaggio infernale, affermando che la sua poesia prende nota solo di ciò che Amor gli dice. Bonagiunta utilizza espressioni tipicamente lucchesi per sottolineare la sua poetica, stesso impedimento che lo accomuna con Guittone: in questa occasione compare la formula di Dolce Stil Novo all'interno della Commedia, come simbolo di novità, della quale la dolcezza n'è il fulcro, riguardante un gruppo di poeti. Il lessico utilizzato è il trobar leu. Lo Stilnovo si individua come un'avanguardia poetica, caratterizzata da una concezione tradizionale dell'amore e del rapporto con la donna amata/signora feudale, rivendicando innovazione e identificandosi in un'élite letteraria, alla ricerca di una raffinatezza dello spirito che renda possibile la percezione dell'Amore come esperienza di vita più elevata, raffinatezza, nobiltà di cuore. Dante rivendica la sua poesia come una fedele adesione a una rappresentazione più alta dell'amore. Ciò fa del poeta uno scriba dei e dell'amore un concetto trascendente. Muta la visione della donna, che da signora feudale diviene donna-angelo, esplorata nel dettaglio da Dante, in grado di atterrire l'uomo e risultare irraggiungibile. Per il suo stile, lo Stilnovo è quindi classificabile nel trobar leu: il dettato dell'amore è dolce e chiaro e tali caratteristiche sono segno di un grande sforzo poetico. Nella figura di Guinizzelli possiamo individuare un capostipite del movimento stilnovista: Dante lo incontra nei canti XXV e XXVI dell'Inferno nel girone dei lussuriosi, insieme ad Arnaut Daniel, e lo definisce un padre per sé, i suoi compagni e la loro poesia. Infatti, Guinizzelli è l'autore di un corpus poetico di 20 testi: tra questi troviamo il Manifesto del Dolce Stil Novo, una canzone divisa in strofe, dette stanze, di egual misura e schema metrico, composte da due sezioni, fronte e sirma, divise da un collegamento detto chiave e solitamente divise a loro volta (fronte diviso in due piedi): la canzone è, infine, chiusa con un congedo. I poeti del Dolce Stil Novo non sono contrari alla nobiltà di ceto, ma ritengono che essa non sia sufficiente. La nobiltà, nel mondo comunale del '200, è difficile da definire: non esiste una codificazione dei titoli o un sovrano che li attribuisce. Nell'XI canto del Purgatorio, Dante incontra i superbi e, paragonando Cavalcanti e Guinizzelli a due aquilotti, afferma che qualcuno caccerà l'uno e l'altro dal nido.
Guido Guinizzelli, Al Cor Gentil Rempaira Sempre Amor
Guinizzelli compone secondi i modelli siciliani e agisce da precursore per lo Stilnovo fiorentino. Il concetto fondamentale della canzone è duplice: la vera nobiltà risiede nel cuore e il suo possesso è un presupposto essenziale per provare amore; quest'ultimo non può essere tale senza nobiltà di cuore. Nella I stanza, Guinizzelli dimostra l'impossibilità di amare qualcuno senza nobiltà di cuore, attraverso una serie di similitudini, derivanti dalla filosofia aristotelica del tempo (uccello-dimora naturale, sole-luce, calore-fuoco). Nella II stanza, il poeta afferma che, affinché il cuore possa ricevere l'amore, questo necessita l'intervento della natura. (lapidari= pietre: sole: stella= cuore: natura: donna). Nella III stanza vengono ribaditi i concetti già espressi, aggiungendo un esempio negativo. Nella IV stanza, la nobiltà di schiatta non è sufficiente per ricevere amore. Nella V stanza si ha il paragone tra la donna e Dio, tra l'amante e l'intelligenza angelica. L'amante deve obbedire fedelmente alla donna amata, tanto da risultare omologo all'intelligenza celeste, che comprende il volere di Dio e obbedisce al suo volere. Nell'ultima stanza, il poeta si interroga su quanto sia lecito paragonare la donna a Dio. Nella sua opera Vita Nova, Dante afferma che amore e nobiltà di cuore coincidono, come il sommo dittatore Guinizzelli aveva già affermato.
Guido Cavalcanti
Viene ritenuto un filosofo. Tenta di dare un significato dell'amore nella sua opera Donna me paga, nella quale utilizza una terminologia filosofica e scientifica. Analizza e scompone alcuni fenomeni interiori. Cavalcanti insiste su immagini che rimandano alla guerra e al processo (giudizio, condanna, tortura). Individua, nella sofferenza estrema e nell'annientamento di tutte le facoltà, il fine dell'amore. Nell'opera Tu m'hai si piena, afferma che la donna ha riempito la sua mente di dolore, a tal punto che l'anima vorrebbe distaccarsi dal corpo, e sospira nel tentativo di Document shared on www.docsity.com Downloaded by: mia-ghezzi (mia.ghezzi@icstarra.edu.it)