Educazione e formazione: pedagogia e scienze dell'educazione per l'università
Documento da Università su Educazione e formazione. Il Pdf, un Pdf di Psicologia, analizza i concetti di educazione e formazione, le loro relazioni e differenze, con un focus sulla pedagogia e le scienze dell'educazione.
Ver más17 páginas

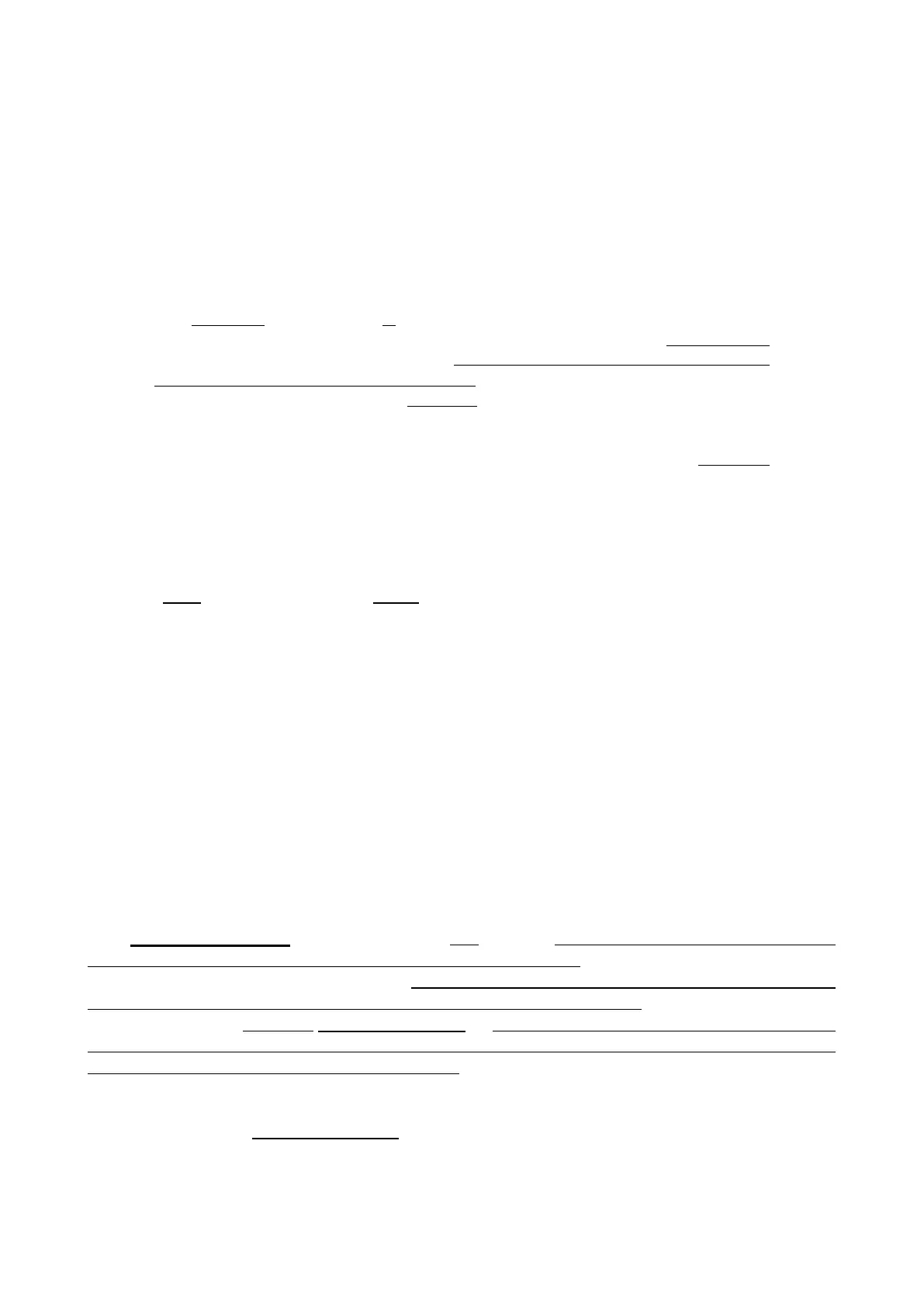
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Introduzione
La pedagogia e le «scienze dell'educazione e/o della formazione». Per un paradigma epistemologico
Secondo Aristotele: le stesse «cose» della realtà naturale ed umana, guardate da punti di vista differen- ti, diventano «oggetto di studio» di «scienze» differenti, indagate con metodi e concettualità linguisti- camente differenti.
Per Evandro Agazzi, invece:
Il concetto di verità non è mai assoluto, ma relativo: una proposizione quasi mai è vera o falsa simpliciter, ma vera o falsa di un certo universo d'oggetti, per cui la domanda stessa circa la sua verità non risulta formulata completamente finché non si dica di quali oggetti essa deve risultare vera. In pratica, quindi, la verità è sempre una verità entro una teoria, perché solo entro questa si danno degli oggetti.
Di conseguenza, ciascuna disciplina scientifica si presenta come un discorso che intenzio- na la realtà sotto un "certo punto di vista", ossia proponendosi di indagarne soltanto certi aspetti o qualità; in ragione di ciò essa seleziona un certo numero circoscritto di "predica- ti" e, al fine di avere successo nel suo sforzo referenziale, li associa ad alcune operazioni standardizzate, che possiamo chiamare indifferentemente "criteri di oggettivazione" oppu- re "criteri di protocollarità o di referenzialità".
Il termine «scienza» (in queste pagine) è sempre inteso nel senso greco di episteme e latino di scientia: un predicare, grazie al logos, dell'oggetto di studio eletto, un sapere certo ed affidabile relativo alle proprietà che lo identificano e lo contraddistinguono, e tutto ciò grazie ad un coerente met-hòdos di indagine (meta-, dopo, dietro, oltre, e hòdos, via, cammino) e ad una sempre più sistematica forma- lizzazione linguistico-concettuale.
Oggi, sappiamo bene due cose:
- La certezza e l'affidabilità scientifiche di un sapere relativo a qualsiasi, particolare oggetto di studio non dipendono dall'impiego né degli stessi metodi, né dello stesso linguaggio perché - come direbbe Galileo - un conto è dover spiegare «come si vadia al cielo», un altro «come vadia il cielo».
- Inoltre, nessuna legge «scientifica» può e potrà mai rivendicare un'assolutezza incondiziona- ta, nemmeno a livello statistico.
Analogia e verità «scientifiche»
Tutte queste consapevolezze erano già presenti nella filosofia di Aristotele, secondo cui: il sostantivo «scienza» e l'aggettivo «scientifico», con i significati di verità che evocano, si dovevano predicare in molti modi. A seconda, dunque, degli oggetti, dei metodi e dei linguaggi che ogni «scienza» seleziona e con cui si esprime per referenziare anche le medesime «cose» del mondo e della vita.
Logo teoretico, tecnico e pratico, sapeva bene Aristotele, non sono, naturalmente, tra loro separati. Se la razionalità teoretica ha certamente come fine quello di rispondere in modo conoscitivamente certo ed affidabile alla domanda «come stanno le cose, e perché», adoperando i metodi che si sono menzionati, bisogna anche riconoscere che essa non sarebbe mai in grado di compiere il proprio fine se non adoperasse come mezzi anche la razionalità tecnica e quella pratica.
Analogamente, se il fine della razionalità tecnica è «vedere che cosa si può fare per trasformare le cose che stanno in un certo modo, e come si può concretamente procedere a questa trasformazione con precisione, affidabilità, efficienza ed efficacia», è intuitivo che, senza il contributo della raziona- lità teoretica, si condannerebbe ad uno sterile velleitarismo e senza quello della razionalità pratica a scambiare in modo acritico ciò che si può fare con ciò che sarebbe bene fare e che si dovrebbe fare.
Stesso discorso per la razionalità pratica: il suo fine è certamente scegliere ciò che è bene e stabilire anche come agire per realizzarlo nel contesto dato, assumendosi le responsabilità che conseguono e- ventualmente dallo sbagliare. Sarebbe vano questo suo sforzo etico, però, se, nell'eseguirlo, prescin- desse dalle certe ed affidabili consapevolezze che la razionalità teoretica offre sullo «stato delle cose,2 e perché» e che la razionalità tecnica garantisce su «ciò che si potrebbe fare, e come, per trasformare queste cose» in vista del e seguendo il, in questo caso, fine del «dover essere» pratico.
Una domanda preliminare
La pedagogia è una «scienza»? Può, perché ed in che senso, essere definita «scientifica», depositaria di conoscenze certe ed affidabili? Se la risposta fosse positiva, bisognerebbe essere preliminarmente d'accordo sul suo specifico oggetto di studio, anche perché è proprio quest'ultimo, insieme poi al mo- do ed agli strumenti con cui lo si studia, a determinare se il «sapere scientifico», autorizzato dal modo e dagli strumenti, proviene (ed in che senso e perché), in via prioritaria, da logo teoretico, invece che tecnico o pratico, oppure è di tutti e tre insieme.
La questione, però, non può essere risolta sostenendo che le «scienze» non hanno oggetti di studio (come sostenuto da Popper e Dewey), perché semplicemente studiano "problemi da risolvere".
Ulteriore consapevolezza epistemologica: le relazioni che si instaurano fra le parti dell'oggetto, tra oggetto ed ambiente, tra soggetto ed oggetto sono generative, cioè creano di continuo nuovi sistemi relazionali, nei quali «il tutto è più delle parti che lo compongono, perché queste, interagendo fra loro, producono appunto qualcosa di nuovo ed imprevedibile; ma al contempo, il tutto è anche meno delle parti, perché queste, interagendo, sfruttano soltanto alcune delle potenzialità che singolarmente pos- siedono, e sono costrette a bloccare altre». Ma esiste questo oggetto di studio?
L'oggetto di studio della pedagogia: un problema aperto
Esiste un oggetto di studio specifico che qualificherebbe la pedagogia come una «scienza»? E se c'è, allora qual è? A prima vista, si potrebbe rispondere che la pedagogia guardi e selezioni nelle "cose" e nei "problemi" unitari del mondo e della vita delle persone le proprietà peculiari riconducibili all'«e- ducazione».
Ma possiamo essere sicuri che la pedagogia voglia proprio studiare le proprietà che contraddistinguo- no l'oggetto di studio chiamato «educazione» e non quelle nominabili con il termine «formazione»? Ma quest'ultima, è un oggetto di studio differente o addirittura un sostituto, più completo ed avanzato dell'educazione? O si tratta soltanto di un suo ridondante sinonimo? (a questo punto, perché utilizzare due termini diversi per referenziare lo stesso «oggetto di studio» di una medesima «scienza»?).
Non sono interrogativi retorici, ma di merito sostanziale. Senza una chiara risposta ad entrambi, è im- possibile costruire un sapere pedagogico, che possa essere davvero certo ed affidabile, sulla "roccia" della «scienza».
I vantaggi delle «scienze dell'educazione e/o della formazione»
Rispetto a tutto ciò, sono senza dubbio più fortunati dei pedagogisti i loro colleghi psicologi, sociolo- gi, antropologi, ecc., ovvero tutti coloro che possono studiare, dai loro rispettivi punti di vista, l'og- getto (per adesso pedagogicamente ancora equivoco, nominato «educazione» e/o «formazione» senza dover rispondere con nettezza ed in via preliminare agli interrogativi del paragrafo precedente. Questi studiosi mostrano di possedere 2 rilevanti vantaggi rispetto ai colleghi pedagogisti:
La dominanza della razionalità teoretica e del suo metodo moderno
Razionalità teoretica ed il suo metodo - senza temere l'accusa di riduzionismo né di superficiale ap- prossimazione che si potrebbe invece imputare ai pedagogisti - possono proclamare nello studio del- l'oggetto «educazione» e/o «formazione» le virtù di una scienza improntata alla razionalità teoretica e, all'interno di questo logo, soprattutto al metodo ipotetico deduttivo empirico-esperimentale di ma- trice galileiana:
- Identificare proprietà empiricamente verificabili;
- Esplicitare il quadro teorico di partenza assunto come ipotesi;
- Procedere alla verifica delle proprietà dell'oggetto («educazione» e/o «formazione»);
- Trarre coerente conclusioni dalle indagini condotte.3
La «scienza» è per definizione questa continua trasformazione che cambia a volte anche radicalmente paradigma di riferimento, ma che non perde mai il suo valore intrinseco di verità, almeno nei limiti delle condizioni e delle operazioni date per generare i suoi asserti conoscitivi.
L'oggetto di studio «educazione» e/o «formazione», pedagogicamente scivoloso quanto si vuole, è, dal punto di vista delle diverse «scienze dell'educazione e/o formazione», conoscibile, osservabile e predicative nelle sue proprietà empiriche non solo in linea, di fatto, ma anche a livello filosofico-on- tologico, semplicemente perché non ha, ma è anche tutte le proprietà che gli sono a volta a volta attri- buite in ipotesi poi verificate a conclusione di un rigoroso processo di indagine pubblicamente con- trollabile e che porta alla progressiva formulazione di sempre più adeguate teorie.
Questo studio dell'«educazione» e/o della «formazione» condotto dalle «scienze» teoretiche che si improntano al metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale, quindi, è tutt'altro che un'operazione inutile o inaffidabile, sia per l'oggettività da tutti intersoggettivamente controllabile a cui perviene, sia, non- dimeno, per i significati vitali che essa stessa assume per i ricercatori che la praticano e per chi è in prima persona coinvolto nell'impresa.
Ciò vuol dire che, con questa impostazione, non è soltanto assicurata un'intersoggettività operaziona- le-metodologica pubblica, ma pure, ad un livello ulteriore, più radicale, un'intersoggettività forte, im- plicata allo stesso costituirsi di queste diverse «scienze».
Lavorare sull'esperienza perfetta
Le «scienze dell'educazione e/o della formazione», com'è già stato detto, «oggettualizzano» secondo specifiche proprietà empiriche che variano a seconda dei vari punti di vista assunti e secondo proprie differenziate operazioni di accertamento e verifica intersoggettivamente ripetibili, la «cosa» «educa- zione» e/o «formazione».
Riescono a farlo senza troppi ostacoli perché, da un lato, non hanno finalità normative: non si confron- tano con il "dover essere" dell'oggetto indagato, cioè educazione/formazione (si limitano all'esplora- zione delle «affezioni empiriche spazio temporali che esse mostrano nell'«essere»»); dall'altro, per- ché non hanno nemmeno finalità (o pretese) essenzialistiche (che cos'è?/che cosa sono?).
Si interessano dell'«educazione» e/o della «formazione» «già accaduta, così come è accaduta», fer- mata nel tempo e nello spazio, nei casi singoli e/o sociali, per spiegarne o comprenderne le ragioni, grazie alla mediazione del loro peculiare logos di indagine.
Lo sguardo delle «scienze dell'educazione e/o della formazione» è sempre retro-spettivo (è chiamato ad indagare il reale già compiuto) perché, per un verso, intende accertare ciò che è già successo così come è successo a riguardo di quanto è stato, perfino contraddittoriamente, assimilato, nell'esperien- za, alla «cosa» «educazione» e/o «formazione»; per l'altro verso, vuole spiegare o comprendere teore- ticamente, con la mediazione del logo, «perché» l'esperienza dell'«educazione» e/o della «formazio- ne» avvenuta, e la sua lettura, è successa proprio in quel modo e non in altro (ricerca mai esauribile, ma attendibile delle cause).
Lo sguardo delle «scienze dell'educazione e/o della formazione», tuttavia è anche pro-spettivo. In- fatti, sul presupposto che anche l'esperienza educativa e/o formativa «veniente», quella che sta per avvenire (quindi im-perfetta), e pure quella che verrà e che non è ancora data (esperienza futura), pos- sano esser spiegate e comprese con le teorie ricavate dalla mediazione esercitata dal logo sull'espe- rienza educativa e/o formativa perfetta, rende disponibili previsioni su quanto ancora non è «dato» in questo campo.
Il passaggio a nord ovest della pedagogia
Il termine «pedagogia» viene da pais, figlio/a; o da paidos, soggetto umano in crescita, in evoluzione; più agogé, da agein, dal verbo greco ago, condurre, guidare, ma ascendendo, come in una spirale; nel senso di uscire e far uscire qualcuno da uno stato inferiore per andare verso uno superiore, facendogli esprimere potenzialità manifeste o inespresse (possibilità) e valorizzandole in modo attivo per render- lo migliore. Questa agogé ascensionale, però, è particolare. Richiama, infatti, l'agogica musicale: ov-