Crisi russa, Repubblica di Weimar e quadro politico italiano del dopoguerra
Documento da Università su crisi russa, Repubblica di Weimar e quadro politico italiano del dopoguerra. Il Pdf, utile per lo studio della storia contemporanea a livello universitario, analizza la Russia tra guerra e crisi sociale, le rivoluzioni del 1917, l'ascesa di Lenin, la Repubblica di Weimar e il dopoguerra in Italia.
Ver más13 páginas
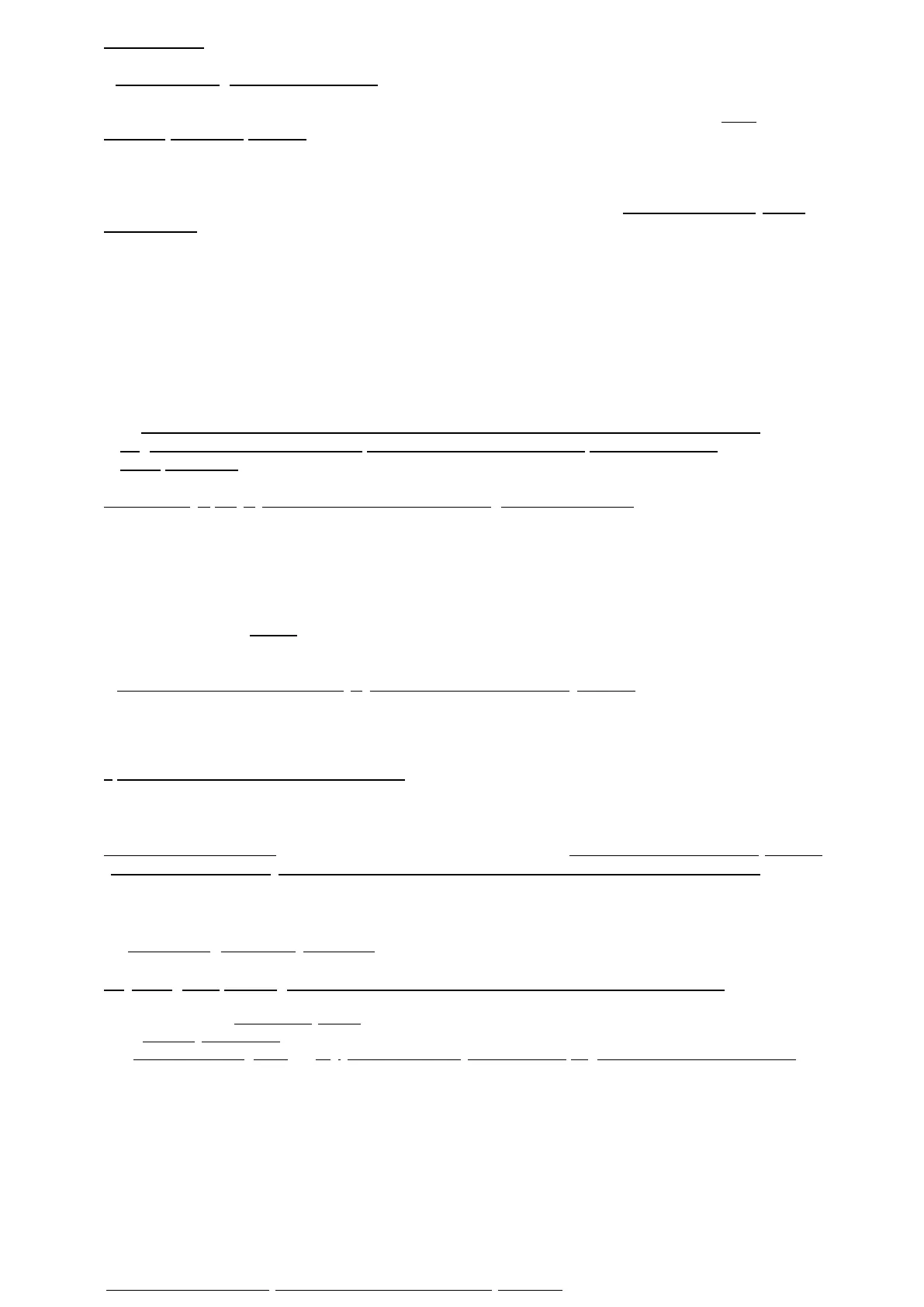
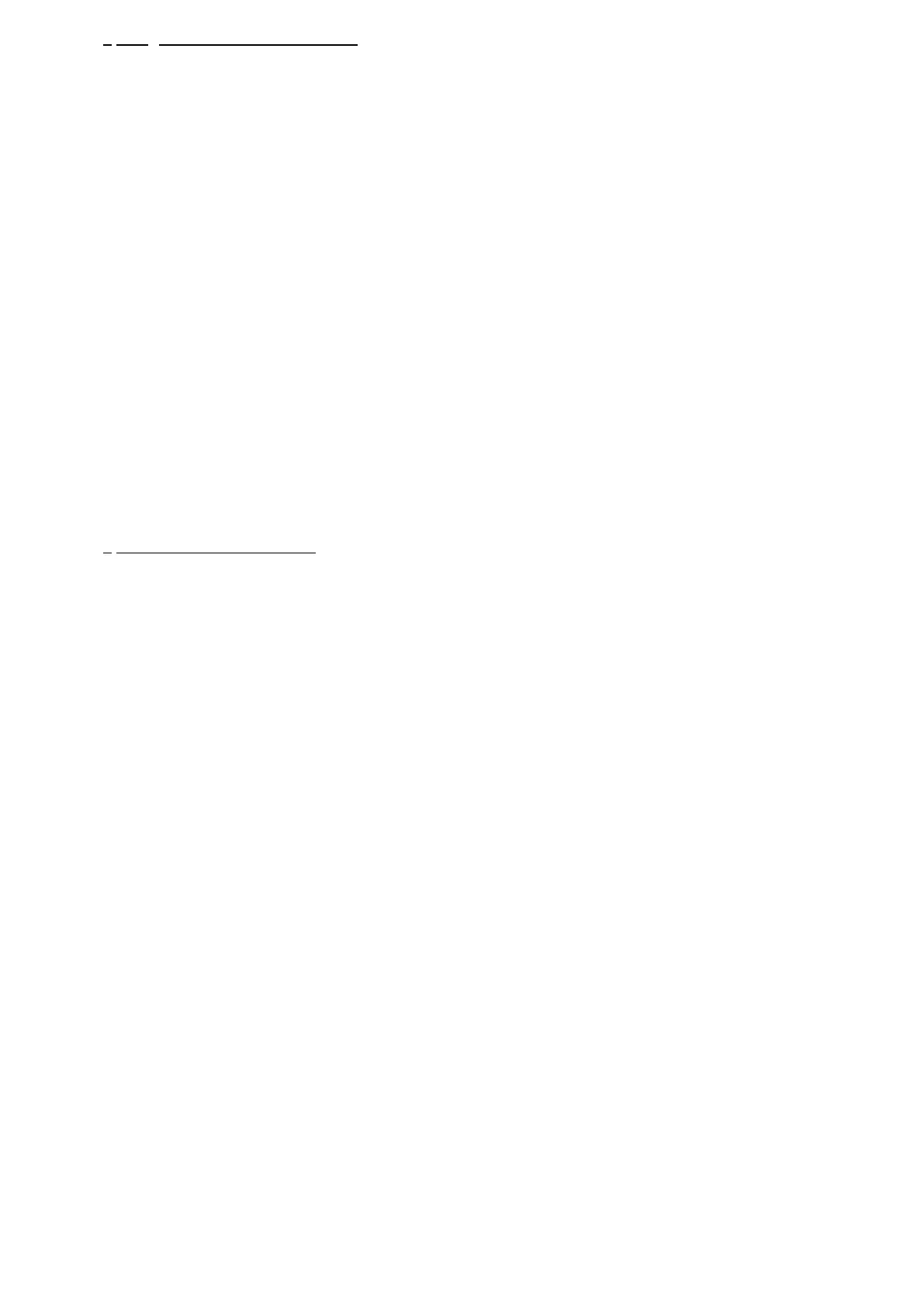
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
La Russia tra guerra e crisi sociale
CAPITOLO 5 1)La Russia tra guerra e crisi sociale La partecipazione della Russia alla Prima guerra mondiale provocò una profonda crisi militare, sociale e politica. Lo zar Nicola II, nonostante le spinte riformatrici provenienti da parte dell'aristocrazia, si dimostrò incapace di gestire la situazione. Entrata in guerra a fianco dell'Intesa con l'illusione di una rapida vittoria, la Russia si trovò presto in difficoltà:
- l'industria non era preparata a sostenere un conflitto prolungato, mancavano i rifornimenti e il numero di soldati mobilitabili era molto basso.
- Le perdite umane furono altissime fin dal primo anno di guerra e molti coscritti, provenienti da zone rurali, non comprendevano nemmeno le ragioni del conflitto.
- La mancanza di armi e la disorganizzazione aggravavano il malcontento, trasformando l'esercito in una potenziale forza rivoluzionaria.
- La disfatta del 1915 e la decisione dello zar di assumere direttamente il comando non migliorarono la situazione. Anzi, il morale dell'esercito crollò, e le diserzioni si moltiplicarono.
Nel frattempo, la popolazione civile affrontava una grave crisi sociale: la scarsità di beni di prima necessità e l'aumento dei prezzi derivavano dal fatto che molti contadini, praticando l'autoconsumo, immettevano pochissimi prodotti sul mercato. Gli operai più poveri erano affamati e stremati, mentre le condizioni di vita nelle città peggioravano rapidamente. In questo contesto, nel 1915, i settori aristocratici liberali iniziarono a chiedere riforme e la convocazione della Duma. Tuttavia, lo zar, contrario a qualsiasi apertura, sciolse il Parlamento e si isolò a Pietrogrado per concentrarsi sulle questioni militari. Il distacco tra la monarchia e la popolazione si fece ormai irreparabile. Quando la Duma fu riconvocata nel novembre 1916, le opposizioni si unirono, dai liberali di L'vov alla sinistra laburista di Kerenskij, in un fronte ormai orientato verso la rivoluzione.
La Rivoluzione di Febbraio del 1917
2) La Rivoluzione di Febbraio del 1917 Nel febbraio 1917 la crisi sociale e politica della Russia sfociò in un'insurrezione popolare a Pietrogrado, che si trasformò rapidamente in una vera e propria rivoluzione. Tutto iniziò l'8 marzo (23 febbraio secondo il calendario giuliano) con una manifestazione pacifica promossa da donne operaie in occasione della Giornata internazionale della donna. Le proteste, inizialmente spontanee, si estesero rapidamente, coinvolgendo oltre 200.000 persone, che chiedevano pane, la fine della guerra e l'abdicazione dello zar. Il governo reagì con la repressione, ma molti soldati rifiutarono di sparare sulla folla e si unirono ai manifestanti, che assaltarono caserme, prigioni e palazzi pubblici. In pochi giorni, Pietrogrado cadde nel caos e divenne il cuore della rivoluzione. Si formarono così 2 centri di potere:
- il governo provvisorio => espressione della Duma e guidato dal liberale L'vov; . il Soviet di Pietrogrado => rappresentanza di operai e soldati, legato ai movimenti socialisti.
Il Soviet, pur essendo molto influente, non volle assumere direttamente il potere: la maggior parte dei suoi membri riteneva necessario passare prima per una fase di democrazia borghese. Perciò offrì un appoggio condizionato al governo provvisorio, che prometteva elezioni libere e l'Assemblea Costituente. Tuttavia, questo governo mostrò subito debolezza, evitando di prendere decisioni fondamentali su temi cruciali come la guerra, la distribuzione della terra e la forma futura dello Stato. La rivoluzione portò rapidamente alla fine del regime zarista: il 15 marzo Nicola II abdicò in favo re del fratello Michele, che il giorno dopo rinunciò a salire al trono, rimettendo la decisione all'Assemblea Costituente. Così, la monarchia crollò nel giro di pochi giorni, rivelando il profondo discredito che circondava lo zarismo. Nel settembre 1917 fu proclamata ufficialmente la repubblica.
L'ingresso di Lenin sulla scena politica
3)L'ingresso sulla scena di Lenin Dopo la rivoluzione di febbraio 1917 => la Russia entrò in una fase di grande incertezza politica. Il governo provvisorio, guidato inizialmente da L'vov e sostenuto dal Soviet di Pietrogrado, cercò di avviare un regime liberale e democratico, ma si trovò subito in difficoltà. Il crollo dell'autorità imperiale aveva lasciato un vuoto di potere, mentre il popolo, stremato dalla fame e dalla guerra, chiedeva con forza due cose: pace e riforma agraria. L'alleanza tra governo e Soviet si rivelò fragile. Il Soviet si politicizzava sempre più, spinto dalla crescita della componente bolscevica, che proponeva soluzioni radicali e immediate. Il tema decisivo che spaccava la scena politica era la guerra: mentre l'ala destra voleva proseguirla, il Soviet e parte del governo (soprattutto Kerenskij) spingevano per una pace senza annessioni né indennità. La svolta si ebbe con il ritorno di Lenin il 16 aprile 1917. Rientrato in Russia con l'aiuto della Germania, Lenin lanciò subito le sue Tesi di aprile, con cui propose di superare la fase democratica borghese per passare direttamente alla rivoluzione socialista. Secondo lui, era necessario rovesciare il governo provvisorio e dare tutto il potere ai Soviet, instaurando un regime dei lavoratori e dei contadini poveri. Le sue parole d'ordine - pace immediata, terra ai contadini, potere ai Soviet - trovarono un'eco crescente in una popolazione esasperata dalle sofferenze quotidiane. Il disastro militare dell'estate 1917, con oltre 60.000 morti e più di 150.000 disertori, indebolì ulteriormente il governo e rafforzò il sostegno popolare ai bolscevichi. Nel luglio 1917 ci fu un tentativo insurrezionale a Pietrogrado, sostenuto da operai e soldati e appoggiato dai bolscevichi, ma il Soviet non ne prese la guida. Il governo represse duramente la rivolta: molti bolscevichi furono arrestati, Lenin dovette fuggire in Finlandia. Tuttavia, il loro consenso tra le masse continuò a crescere, preparando il terreno per la rivoluzione d'ottobre.
La Rivoluzione d'Ottobre
4) La rivoluzione d'Ottobre Dopo il fallito tentativo rivoluzionario di luglio 1917, il potere passò da L'vov a Kerenskij, che instaurò un governo provvisorio sostenuto ancora da un fragile accordo tra la Duma e il Soviet. Tuttavia, le tensioni politiche aumentarono in agosto, quando il generale Kornilov, con l'iniziale appoggio di Kerenskij, tentò un colpo di Stato per instaurare una dittatura militare e sciogliere il Soviet di Pietrogrado. Il piano fallì grazie anche al decisivo intervento dei bolscevichi, che difesero il governo e guadagnarono ulteriore consenso tra le masse popolari. Il fallimento del golpe di Kornilov accelerò la perdita di legittimità del governo provvisorio, mentre i bolscevichi consolidarono il proprio controllo sul Soviet di Pietrogrado, con Trockij come presidente, e su molti altri Soviet locali. La repubblica, proclamata a settembre, non riuscì a fermare il declino del governo, sempre più isolato. In questo contesto, Lenin, rientrato dalla Finlandia, convinse il Comitato centrale bolscevico a organizzare un colpo di Stato. Il Comitato militare rivoluzionario, controllato dai bolscevichi, pianificò l'assalto. Nella notte tra il 6 e 7 novembre 1917 (24-25 ottobre nel calendario russo), i bolscevichi occuparono i punti strategici di Pietrogrado e presero il controllo del palazzo d'Inverno, sede del governo. Quando si aprì il Congresso panrusso dei Soviet, i bolscevichi ottennero la maggioranza dopo il ritiro di menscevichi e socialisti rivoluzionari moderati, contrari al colpo di mano. Così, tutto il potere passò ai Soviet, ma di fatto fu controllato dal partito bolscevico, segnando una rottura con la rivoluzione di febbraio e con la tradizione democratica. Appena preso il potere, Lenin presentò i due primi decreti rivoluzionari:
- Il decreto sulla pace, che annunciava l'avvio di trattative per porre fine alla guerra.
- Il decreto sulla terra, che aboliva la grande proprietà terriera e redistribuiva le terre ai contadini senza indennizzi.
Questi atti inaugurarono una nuova era politica: la nascita della Repubblica dei Soviet, destinata a trasformarsi nell'Unione Sovietica.
La costruzione del regime bolscevico
5)La costruzione di un nuovo regime Bolscevico Dopo aver conquistato il potere con la Rivoluzione d'Ottobre, i bolscevichi si trovarono a dover costruire un nuovo sistema di governo. Questo processo si avviò non tanto con il colpo di Stato, quanto con una serie di decisioni cruciali prese tra novembre e dicembre 1917, che avviarono una svolta autoritaria. Il primo passo fu la creazione del Consiglio dei commissari del popolo, un governo formato esclusivamente da bolscevichi e guidato da Lenin, con Trockij agli Esteri. Questo Consiglio, pur formalmente legato al Soviet, governò in modo autonomo e per decreti. Venne istituita la polizia segreta (Ceka), limitata la libertà di stampa, introdotta la legge marziale e si attuarono riforme come la parità di diritti tra uomini e donne, il controllo operaio sulle industrie e la giornata lavorativa di 8 ore. Un punto di svolta fu il rapporto con l'Assemblea Costituente: nonostante le elezioni del novembre 1917 videro la vittoria dei socialisti rivoluzionari (38%), i bolscevichi non accettarono il risultato. Quando la Costituente rifiutò la "Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore" proposta da Lenin, fu sciolta l'8 gennaio 1918. Questa scelta segnò la fine della democrazia rappresentativa e il rafforzamento del potere bolscevico. Contemporaneamente, si aprì una fase di violenza rivoluzionaria, nota come Terrore rosso, in cui vennero perseguitati ed eliminati i "nemici di classe": borghesi, proprietari terrieri, funzionari e aristocratici. Furono requisite abitazioni, nazionalizzati i beni della Chiesa e istituite forme di giustizia popolare, basate su un "diritto di classe". Il culmine fu raggiunto nel 1918 con la sistematica eliminazione dei kulaki (contadini ricchi) e l'esecuzione dello zar Nicola II e della sua famiglia. Infine, fondamentale fu la decisione di uscire dalla Prima guerra mondiale. Lenin, contrario alla prosecuzione del conflitto, spinse per una pace immediata, nonostante l'opposizione interna. Dopo l'offensiva tedesca del febbraio 1918, fu firmato il trattato di Brest-Litovsk (3 marzo 1918), che impose alla Russia perdite enormi: un terzo della popolazione, vaste aree agricole, industrie e risorse minerarie.
La guerra civile russa
6) La guerra civile Tra il 1918 e il 1921 la Russia fu attraversata da una sanguinosa guerra civile, causata dallo scontro tra i bolscevichi ("rossi"), saliti al potere dopo la Rivoluzione d'Ottobre, e le forze controrivoluzionarie ("bianchi"), composte da ex ufficiali zaristi e sostenute dalle potenze dell'Intesa (Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Giappone e Italia). Queste ultime temevano sia l'influenza tedesca sull'area orientale, sia la possibile espansione della rivoluzione bolscevica in Europa. I bolscevichi si trovarono a fronteggiare gravi difficoltà: nonostante avessero il potere politico, il controllo del vasto territorio russo era ancora fragile. Le opposizioni interne, in particolare quelle della vecchia burocrazia zarista e degli intellettuali, erano forti, e molte aree del paese videro la nascita di forze armate controrivoluzionarie. La minaccia spinse Lenin a trasferire la capitale da Pietrogrado a Mosca. Lenin rispose con il "Terrore rosso" e l'organizzazione di un potente esercito, l'Armata Rossa, affidato a Trockij. Quest'ultima, ben strutturata e motivata, riuscì a prevalere sui bianchi, i quali non riuscirono a proporre un'alternativa credibile e non ottennero il supporto della popolazione contadina, timorosa di un ritorno alla servitù zarista. Anche l'appoggio straniero si rivelò insufficiente, e tra il 1920 e il 1921 i bianchi furono definitivamente sconfitti. Nel 1920 la Polonia attaccò la Russia sovietica e occupò Kiev, ma fu poi respinta dall'Armata Rossa. La guerra si concluse con la pace di Riga nel marzo 1921, che assegnò parte dell'Ucraina e della Bielorussia alla Polonia. Con ciò si chiuse la guerra civile e si consolidò il potere bolscevico. L'esperienza dell'Armata Rossa contribuì a forgiare l'identità delle nuove generazioni, che costituirono il nucleo del futuro Partito Comunista. Lenin sperava in una rivoluzione mondiale e nel 1919 fondò la Terza Internazionale (Comintern), con l'obiettivo di coordinare i movimenti comunisti globali. Il biennio 1919-1920 fu segnato da tentativi rivoluzionari in Ungheria, Baviera e Germania, oltre che da forti mobilitazioni in altri paesi, tra cui l'Italia (il "biennio rosso"). Tuttavia, questi tentativi fallirono, e l'idea di una rivoluzione mondiale venne sostituita da quella della costruzione del socialismo in un solo paese.