Descrivere la Lingua dei Segni Italiana: prospettiva cognitiva e sociosemiotica
Documento dall'Università degli Studi di Catania sulla lingua dei segni italiana (LIS) da una prospettiva cognitiva e sociosemiotica. Il Pdf esplora la storia della comunità sorda in Italia, la percezione linguistica e le espressioni artistiche, utile per studenti universitari di Lingue.
Mostra di più14 pagine
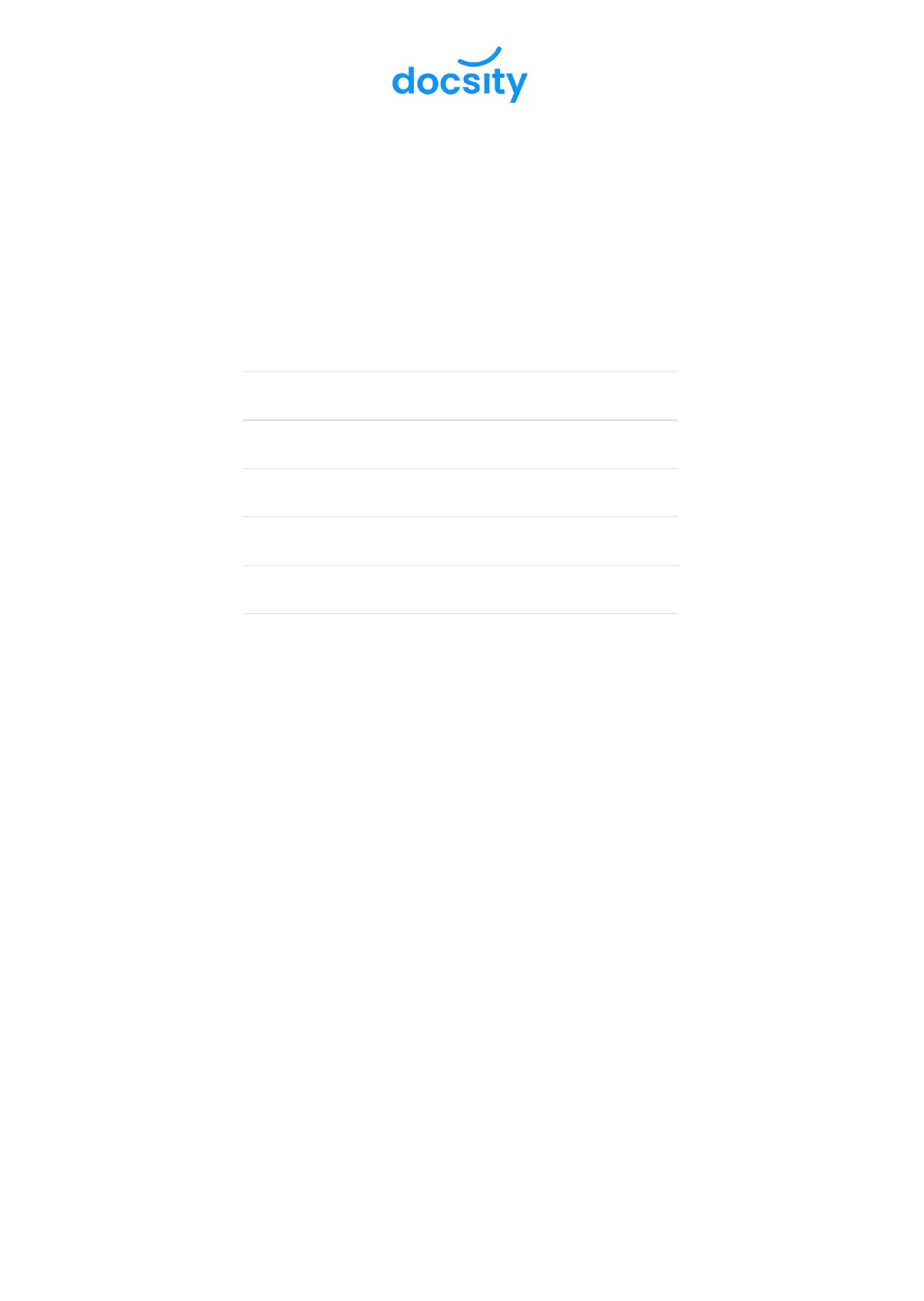
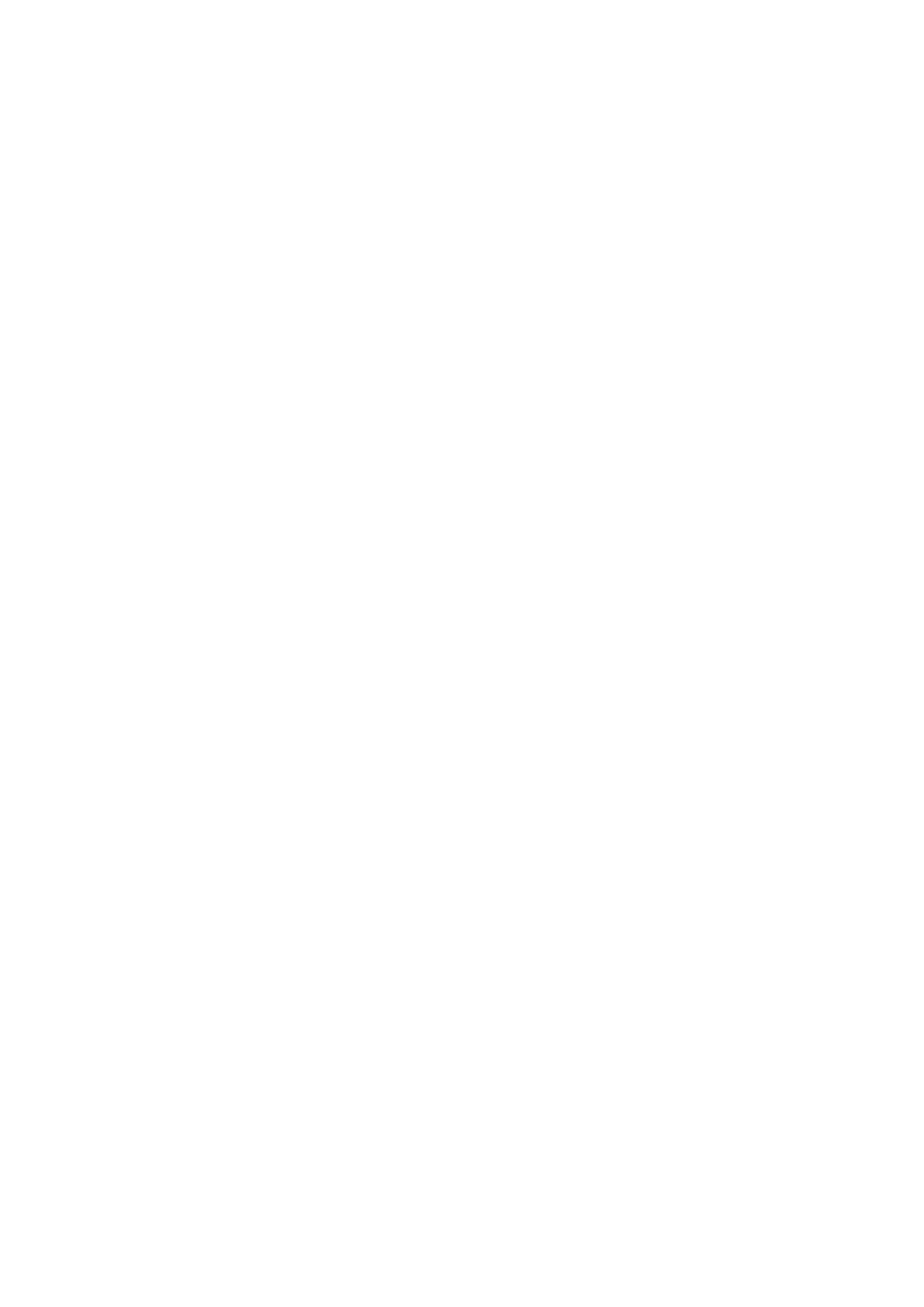
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Introduzione alla Lingua dei Segni Italiana
Nelle prime descrizioni della LIS si analizzava la lingua secondo strutture e categorie tratte dall'analisi delle lingue vocali e soprattutto scritte, mentre la prospettiva teorica che si adotta oggi muove proprio dalle caratteristiche uniche e peculiari delle lingue dei segni. Anzi, le proprietà semiotiche e le caratteristiche strutturali delle lingue dei segni contribuiscono a evidenziare aspetti analoghi delle lingue parlate. Noi ipotizziamo una stretta continuità tra azione e linguaggio e mostriamo come gesti, parole e segni abbiano origine dalle azioni della vita quotidiana e dalle interazioni degli esseri umani fra loro e con l'ambiente che li circonda. Come nelle lingue parlate sono stati considerati "paralinguistici" fenomeni come il gesto e "perilinguistici" fenomeni come la prosodia, così nelle lingue segnate sono state spesso escluse dalle analisi le strutture maggiormente iconiche e alcune componenti corporee perché difficilmente descrivibili secondo le categorie discrete tipiche sia di una linguistica strutturalista sia di una linguistica formale. In relazione ai fenomeni "paralinguistici", analogamente a quanto è avvenuto per le lingue parlate con una serie di aspetti come la gestualità, queste componenti corporee sono state tradizionalmente definite "non manuali". Il segnato non è sempre segmentabile in unità discrete. Il fine dei parlanti e dei segnanti è quello di comunicare, chiedere, comandare, persuadere, manifestare pensieri, emozioni e sentimenti.
CAPITOLO 1: Per una Nuova Descrizione della Lingua dei Segni Italiana
Già nella prima metà dell'800 alcuni educatori dei sordi avevano avuto una chiara percezione della peculiarità delle lingue dei segni come, ad esempio, Bébian (insegnante dell'Istituto dei Sordomuti di Parigi), che pubblicò una descrizione molto approfondita della lingua dei segni "naturale" utilizzata dai suoi allievi sordi, arrivando a proporre anche un sistema di scrittura, la "mimografia". Il primo grande linguista a sottolineare l'interesse teorico di queste lingue è l'americano William Dwight Whitney il quale sosteneva, come farà Saussure, che l'audio-oralità non è essenziale per una lingua. Bisognerà attendere l'arrivo nel 1955 di William Stokoe al Gallaudet di Washington, allora l'unico college che aveva come missione l'istruzione di studenti sordi, perché prenda l'avvio di un ambito di ricerca che si è diffuso in tutto il mondo. Stokoe arriva nell'istituzione americana come insegnante di letteratura inglese, ma si trasforma a esploratore della cultura e del linguaggio delle persone sorde e del loro reale modo di comunicare. Segnare era stato considerato fino a quel momento una sorta di pantomima, senza struttura interna o coerenza o regola, qualcosa molto al di sotto del livello di definizione di una lingua. Stokoe si convince e riesce a dimostrare che quei gesti considerati imprecisi e approssimativi hanno invece una struttura, sono organizzati in un sistema gerarchico autonomo, cioè indipendente dalle lingue vocali e presentano le stesse caratteristiche distintive di tutti i linguaggi umani. I gesti della comunicazione dei sordi sono lingue. Nel 1960, con Sign Language Structure, Stokoe mostra la linguisticità della lingua dei segni americana. Il suo approccio è stato rivoluzionario perché il suo fine non era pedagogico ma linguistico. Le ricerche sull'ASL hanno avuto una forte influenza anche in altri paesi europei. Nel 1979 venne organizzati a Roma il primo incontro italiano sulle lingue dei segni. L'inizio delle ricerche sulla forma di comunicazione usata dalle persone sorde in Italia è stato influenzato sia dalle ricerche avviate da Stokoe sia da quanto veniva elaborato in altri paesi europei, in particolare: Danimarca, Francia, Gran Bretagna e Svezia. Nel 1981 viene pubblicato il volume "I segni come parole", che raccoglie una rassegna degli studi condotti negli altri paesi sulle lingue dei segni e riflessioni sullo status linguistico da attribuire a queste lingue. All'epoca la ricerca era influenzata dalla definizione semiotica di lingua proposta da Charles Hockett. Fra i 13 parametri proposti, che permettono di caratterizzare le lingue verbali rispetto ad altri sistemi di comunicazione umani e non umani, ce n'erano alcuni che sembravano applicarsi con qualche difficoltà alle lingue dei segni. Lo stesso Hockett riconosceva che le lingue dei segni erano la prova che almeno uno dei parametri, "l'uso del canale fono-articolatorio", poteva non essere così necessario, ma si trattava di dimostrare che anche le lingue dei segni soddisfacevano tutti gli altri criteri. In particolare, due criteri sembravano cruciali: l'arbitrarietà del segnale e la doppia articolazione. Infatti i sistemi iconici costringono chi comunica a parlare solo di quegli oggetti, concetti e processi che possono essere facilmente imitati o rappresentati, mentre quando un sistema è arbitrario non esiste un limite a ciò che può essere comunicato. Quindi, nella fase iniziale della ricerca sui segni, era importante enfatizzare gli elementi arbitrari e minimizzare la presenza dell'iconicità perché sembrava che quest'ultima potesse invalidare il loro riconoscimento come lingue. Come dalla combinazione di un numero ristretto di suoni senza significato (fonemi) si crea un vastissimo numero di unità dotate di significato (parole), così dalla combinazione di un numero ristretto di unità minime (cheremi) si può produrre un amplissimo numero di unità ditate di significato (segni). Secondo questa analisi un segno si può scomporre in riferimento a tre parametri:
- il luogo nello spazio dove le mani eseguono il segno (TAB dal latino tabula);
- la configurazione delle mani nell'eseguire il segno (DEZ dall'inglese designator);
- il movimento nell'eseguire il segno (SIG dall'inglese signation).
A quei primi tre parametri si era aggiunto quello dell'orientamento della mano. Il criterio adottato per stabilire quali parametri potessero definirsi distintivi nella LIS era equivalente a quello utilizzato per distinguere i fonemi nelle lingue vocali. Ad esempio in italiano due parole come pollo e bollo hanno significati diversi e l'esistenza di una coppia minima di questo tipo permette di affermare che /p/ e /b/ sono due fonemi distinti. Allo stesso modo, in LIS la presenza di due segni che si distinguevano solo in uno dei parametri, è stata la base per decidere quali parametri andassero considerati come cheremi distinti. Si riteneva all'epoca che i segni non fossero scomponibili in unità minime prive di significato. Tale pregiudizio derivava dal fatto che, apparentemente, le lingue dei segni non possiedono un sistema flessionale, non usano quasi mai segni funzionali, come articoli e preposizioni, non sembrano fare chiara distinzione tra nomi e verbi e presentano un ordine relativamente libero degli elementi nella frase. Questi equivoci nascono se si considerano modelli di riferimento mutuati dalle lingue vocali. Piuttosto che comprendere le specificità delle lingue dei segni, si evidenziano le possibili analogie e corrispondenze con le lingue vocali. Si sottolineava, quindi, che tutte le informazioni espresse da alcune lingue vocali tramite gli articoli, le preposizioni, il sistema flessionale o l'ordine delle parole nelle frasi, vengono trasmesse nelle lingue dei segni grazie a meccanismi come: l'uso particolare dello spazio, la modificazione sistematica del movimento con cui viene prodotto il segno, la produzione di movimenti non manuali del capo e degli occhi, le espressioni facciali, l'orientamento e la postura di tutto il busto. In realtà, quello che si affermava all'inizio del volume La lingua italiana dei segni veniva poi contraddetto nella descrizione dei singoli parametri. Un aspetto di questo fenomeno riguardava il collegamento tra particolari aree del corpo e il significato dei segni. Ad esempio, sulla tempia o sulla fronte sono prodotti segni che rimandano a oggetti che si pongono sul capo o riconducibili ad attività mentali. Ma, soprattutto, nel caso delle configurazioni, si notava continuamente il collegamento tra la forma delle mani e il significato. Ad esempio per riferirsi a qualcosa di duro e compatto si utilizzerà una configurazione come il pugno chiuso, mentre per riferirsi a qualcosa di liscio e piano si adotterà piuttosto una configurazione con la mano aperta e le dita unite. Per alcuni segni, dove il rapporto con luogo e configurazione non era così evidente, il collegamento con il significato poteva emergere più chiaramente nel movimento. La comunicazione dei sordi in Italia ha a lungo sofferto a causa di questi pregiudizi che hanno determinato una forte discriminazione sociale. Questa visione ci ha portato a trovare una chiara distinzione tra verbi e nomi, a voler cercare un ordine dei segni nella frase sulla base di categorie (soggetto, oggetto, verbo) per lo più inadeguate a descrivere la lingua dei segni. Un uso eccessivo di espressioni facciali o di movimenti del corpo era considerato poco appropriato. Si riteneva che soltanto i segni fossero unità discrete, arbitrarie e analizzabili in termini di unità minime. I gesti erano considerati come elementi iconici, mutevoli e non analizzabili in termini di parametri formazionali. Quindi veniva accentuata una forte separazione tra gesti e mimica da una parte, come elementi non linguistici e segni dall'altra, come elementi linguistici.
2: Continuità tra Azione, Gesto, Segno e Parola
La prospettiva relativa a una netta distinzione tra gesti e segni è venuta progressivamente modificandosi. In primo luogo si è riconosciuta l'origine comune di entrambi nell'azione. I gesti fondamentali nelle prime fasi di acquisizione delle lingue parlate e segnate sono sostanzialmente azioni. Azioni e gesti precedono e accompagnano l'acquisizione delle prime parole e dei primi segni. L'azione sembra svolgere il ruolo sistematico di precursore delle prime forme linguistiche sia gestuali che vocali. Tra i primi gesti a essere prodotti sono stati individuati i cosiddetti gesti deittici (richiesta ritualizzata, mostrare, dare e indicare) e i gesti rappresentati che possono riferirsi ad azioni intransitive (fare ciao, nuotare, dormire) oppure ad azioni transitive che rimandano alla manipolazione di oggetti (telefonare, mangiare, rompere). È stato dimostrato che i significati di questi primi gesti, sono gli stessi delle prime parole. Le prime parole comprese dai bambini riguardano le azioni e i gesti che sono in grado di eseguire e all'inizio tutti i bambini tendono a comunicare più con i gesti che con le parole. Anche quando la produzione di parole aumenta, i gesti non scompaiono ma, anzi, i bambini producono le cosiddette combinazioni crossmodali. Ad esempio indicano la sedia e dicono "mamma" per indicare dove deve sedersi la madre. Anche successivamente quando la modalità vocale sembra aver preso il sopravvento, il gesto continua a svolgere un ruolo importante. Ad esempio, in un compito di denominazione di foto utilizzato per valutare la comprensione e produzioni di nomi e predicati, bambini udenti italiani, in età tra i due e i tre anni, spesso producevano gesti deittici o rappresentativi in accompagnamento o in sostituzione alle parole. Analizzando i gesti prodotti si è scoperto che alcuni rappresentavano le azioni raffigurate nella foto presentata al bambino, altri le azioni eseguite con l'oggetto raffigurato nella foto, altri le azioni che caratterizzavano il personaggio raffigurato nella foto. Confrontando le produzioni di bambini diversi di fronte alla stessa foto, sono state notate forti somiglianze nelle caratteristiche motorie di esecuzione del gesto. Inoltre, un'analisi più dettagliata relativa alle forme delle mani nell'esecuzione di questi gesti ha permesso di scoprire che i bambini udenti italiani utilizzavano nei gesti le stesse forme delle mani utilizzate da bambini che acquisiscono la lingua dei segni americana.
3: Strategie Rappresentative
Negli ultimi anni si è cominciato a capire che le strategie di rappresentazione simbolica sono fondamentalmente quattro:
- mimo: tutto il corpo rappresenta l'azione o il personaggio;
- manipolazione: le mani assumono un tipo di afferramento che rimanda all'azione su un oggetto immaginato;
- mano come oggetto: le mani diventano l'oggetto che si vuole rappresentare;
- forma e misura: le mani tracciano la forma o indicano le dimensioni dell'oggetto che si intende rappresentare.
In sostanza, sia nel caso dei gesti comunicativi che dei segni è possibile attraverso la modalità corporea rendere visibile ciò di cui si parla, adottando la prospettiva del protagonista, personaggio, docsity Descrivere la lingua dei segni italiana - una prospettiva cognitiva e sociosemiotica Linguistica Generale Università degli Studi di Catania (UNICT) 13 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/descrivere-la-lingua-dei-segni-italiana-una-prospettiva-cognitiva-e-sociosemiotica/7283336/DESCRIVERE LA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA INTRODUZIONE Nelle prime descrizioni della LIS si analizzava la lingua secondo strutture e categorie tratte dall'analisi delle lingue vocali e soprattutto scritte, mentre la prospettiva teorica che si adotta oggi muove proprio dalle caratteristiche uniche e peculiari delle lingue dei segni. Anzi, le proprietà semiotiche e le caratteristiche strutturali delle lingue dei segni contribuiscono a evidenziare aspetti analoghi delle lingue parlate. Noi ipotizziamo una stretta continuità tra azione e linguaggio e mostriamo come gesti, parole e segni abbiano origine dalle azioni della vita quotidiana e dalle interazioni degli esseri umani fra loro e con l'ambiente che li circonda. Come nelle lingue parlate sono stati considerati "paralinguistici" fenomeni come il gesto e "perilinguistici" fenomeni come la prosodia, così nelle lingue segnate sono state spesso escluse dalle analisi le strutture maggiormente iconiche e alcune componenti corporee perché difficilmente descrivibili secondo le categorie discrete tipiche sia di una linguistica strutturalista sia di una linguistica formale. In relazione ai fenomeni "paralinguistici", analogamente a quanto è avvenuto per le lingue parlate con una serie di aspetti come la gestualità, queste componenti corporee sono state tradizionalmente definite "non manuali". Il segnato non è sempre segmentabile in unità discrete. Il fine dei parlanti e dei segnanti è quello di comunicare, chiedere, comandare, persuadere, manifestare pensieri, emozioni e sentimenti. CAPITOLO 1: PER UNA NUOVA DESCRIZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA Già nella prima metà dell'800 alcuni educatori dei sordi avevano avuto una chiara percezione della peculiarità delle lingue dei segni come, ad esempio, Bébian (insegnante dell'Istituto dei Sordomuti di Parigi), che pubblicò una descrizione molto approfondita della lingua dei segni "naturale" utilizzata dai suoi allievi sordi, arrivando a proporre anche un sistema di scrittura, la "mimografia". Il primo grande linguista a sottolineare l'interesse teorico di queste lingue è l'americano William Dwight Whitney il quale sosteneva, come farà Saussure, che l'audio-oralità non è essenziale per una lingua. Bisognerà attendere l'arrivo nel 1955 di William Stokoe al Gallaudet di Washington, allora l'unico college che aveva come missione l'istruzione di studenti sordi, perché prenda l'avvio di un ambito di ricerca che si è diffuso in tutto il mondo. Stokoe arriva nell'istituzione americana come insegnante di letteratura inglese, ma si trasforma a esploratore della cultura e del linguaggio delle persone sorde e del loro reale modo di comunicare. Segnare era stato considerato fino a quel momento una sorta di pantomima, senza struttura interna o coerenza o regola, qualcosa molto al di sotto del livello di definizione di una lingua. Stokoe si convince e riesce a dimostrare che quei gesti considerati imprecisi e approssimativi hanno invece una struttura, sono organizzati in un sistema gerarchico autonomo, cioè indipendente dalle lingue vocali e presentano le stesse caratteristiche distintive di tutti i linguaggi umani. I gesti della comunicazione dei sordi sono lingue. Nel 1960, con Sign Language Structure, Stokoe mostra la linguisticità della lingua dei segni americana. Il suo approccio è stato rivoluzionario perché il suo fine non era pedagogico ma linguistico. Le ricerche sull'ASL hanno avuto una forte influenza anche in altri paesi europei. Nel 1979 venne organizzati a Roma il primo incontro italiano sulle lingue dei segni. L'inizio delle ricerche sulla forma di comunicazione usata dalle persone sorde in Italia è stato influenzato sia dalle ricerche avviate da Stokoe sia da quanto veniva elaborato in altri paesi europei, in particolare: Danimarca, Francia, Gran Bretagna e Svezia. Nel 1981 viene pubblicato il volume "I segni come parole", che raccoglie una rassegna degli studi condotti negli altri paesi sulle lingue dei segni e riflessioni sullo status linguistico da attribuire a queste lingue. All'epoca la ricerca era influenzata dalla definizione semiotica di lingua proposta da Charles Hockett. Fra i 13 parametri proposti, che permettono di Document shared on https://www.docsity.com/it/descrivere-la-lingua-dei-segni-italiana-una-prospettiva-cognitiva-e-sociosemiotica/7283336/caratterizzare le lingue verbali rispetto ad altri sistemi di comunicazione umani e non umani, ce n'erano alcuni che sembravano applicarsi con qualche difficoltà alle lingue dei segni. Lo stesso Hockett riconosceva che le lingue dei segni erano la prova che almeno uno dei parametri, "l'uso del canale fono-articolatorio", poteva non essere così necessario, ma si trattava di dimostrare che anche le lingue dei segni soddisfacevano tutti gli altri criteri. In particolare, due criteri sembravano cruciali: l'arbitrarietà del segnale e la doppia articolazione. Infatti i sistemi iconici costringono chi comunica a parlare solo di quegli oggetti, concetti e processi che possono essere facilmente imitati o rappresentati, mentre quando un sistema è arbitrario non esiste un limite a ciò che può essere comunicato. Quindi, nella fase iniziale della ricerca sui segni, era importante enfatizzare gli elementi arbitrari e minimizzare la presenza dell'iconicità perché sembrava che quest'ultima potesse invalidare il loro riconoscimento come lingue. Come dalla combinazione di un numero ristretto di suoni senza significato (fonemi) si crea un vastissimo numero di unità dotate di significato (parole), così dalla combinazione di un numero ristretto di unità minime (cheremi) si può produrre un amplissimo numero di unità ditate di significato (segni). Secondo questa analisi un segno si può scomporre in riferimento a tre parametri: ·il luogo nello spazio dove le mani eseguono il segno (TAB dal latino tabula); ·la configurazione delle mani nell'eseguire il segno (DEZ dall'inglese designator); ·il movimento nell'eseguire il segno (SIG dall'inglese signation). A quei primi tre parametri si era aggiunto quello dell'orientamento della mano. Il criterio adottato per stabilire quali parametri potessero definirsi distintivi nella LIS era equivalente a quello utilizzato per distinguere i fonemi nelle lingue vocali. Ad esempio in italiano due parole come pollo e bollo hanno significati diversi e l'esistenza di una coppia minima di questo tipo permette di affermare che /p/ e /b/ sono due fonemi distinti. Allo stesso modo, in LIS la presenza di due segni che si distinguevano solo in uno dei parametri, è stata la base per decidere quali parametri andassero considerati come cheremi distinti. Si riteneva all'epoca che i segni non fossero scomponibili in unità minime prive di significato. Tale pregiudizio derivava dal fatto che, apparentemente, le lingue dei segni non possiedono un sistema flessionale, non usano quasi mai segni funzionali, come articoli e preposizioni, non sembrano fare chiara distinzione tra nomi e verbi e presentano un ordine relativamente libero degli elementi nella frase. Questi equivoci nascono se si considerano modelli di riferimento mutuati dalle lingue vocali. Piuttosto che comprendere le specificità delle lingue dei segni, si evidenziano le possibili analogie e corrispondenze con le lingue vocali. Si sottolineava, quindi, che tutte le informazioni espresse da alcune lingue vocali tramite gli articoli, le preposizioni, il sistema flessionale o l'ordine delle parole nelle frasi, vengono trasmesse nelle lingue dei segni grazie a meccanismi come: l'uso particolare dello spazio, la modificazione sistematica del movimento con cui viene prodotto il segno, la produzione di movimenti non manuali del capo e degli occhi, le espressioni facciali, l'orientamento e la postura di tutto il busto. In realtà, quello che si affermava all'inizio del volume La lingua italiana dei segni veniva poi contraddetto nella descrizione dei singoli parametri. Un aspetto di questo fenomeno riguardava il collegamento tra particolari aree del corpo e il significato dei segni. Ad esempio, sulla tempia o sulla fronte sono prodotti segni che rimandano a oggetti che si pongono sul capo o riconducibili ad attività mentali. Ma, soprattutto, nel caso delle configurazioni, si notava continuamente il collegamento tra la forma delle mani e il significato. Ad esempio per riferirsi a qualcosa di duro e compatto si utilizzerà una configurazione come il pugno chiuso, mentre per riferirsi a qualcosa di liscio e piano si adotterà piuttosto una configurazione con la mano aperta e le dita unite. Per alcuni segni, dove il rapporto con luogo e configurazione non era così evidente, il collegamento con il significato poteva emergere più chiaramente nel movimento. La comunicazione dei sordi in Italia ha a lungo sofferto a causa di questi pregiudizi che hanno determinato una forte discriminazione sociale. Questa visione ci ha portato a trovare una chiara distinzione tra verbi e nomi, a voler cercare un ordine dei segni Document shared on https://www.docsity.com/it/descrivere-la-lingua-dei-segni-italiana-una-prospettiva-cognitiva-e-sociosemiotica/7283336/nella frase sulla base di categorie (soggetto, oggetto, verbo) per lo più inadeguate a descrivere la lingua dei segni. Un uso eccessivo di espressioni facciali o di movimenti del corpo era considerato poco appropriato. Si riteneva che soltanto i segni fossero unità discrete, arbitrarie e analizzabili in termini di unità minime. I gesti erano considerati come elementi iconici, mutevoli e non analizzabili in termini di parametri formazionali. Quindi veniva accentuata una forte separazione tra gesti e mimica da una parte, come elementi non linguistici e segni dall'altra, come elementi linguistici. 2: CONTINUITA' TRA AZIONE, GESTO, SEGNO E PAROLA La prospettiva relativa a una netta distinzione tra gesti e segni è venuta progressivamente modificandosi. In primo luogo si è riconosciuta l'origine comune di entrambi nell'azione. I gesti fondamentali nelle prime fasi di acquisizione delle lingue parlate e segnate sono sostanzialmente azioni. Azioni e gesti precedono e accompagnano l'acquisizione delle prime parole e dei primi segni. L'azione sembra svolgere il ruolo sistematico di precursore delle prime forme linguistiche sia gestuali che vocali. Tra i primi gesti a essere prodotti sono stati individuati i cosiddetti gesti deittici (richiesta ritualizzata, mostrare, dare e indicare) e i gesti rappresentati che possono riferirsi ad azioni intransitive (fare ciao, nuotare, dormire) oppure ad azioni transitive che rimandano alla manipolazione di oggetti (telefonare, mangiare, rompere). È stato dimostrato che i significati di questi primi gesti, sono gli stessi delle prime parole. Le prime parole comprese dai bambini riguardano le azioni e i gesti che sono in grado di eseguire e all'inizio tutti i bambini tendono a comunicare più con i gesti che con le parole. Anche quando la produzione di parole aumenta, i gesti non scompaiono ma, anzi, i bambini producono le cosiddette combinazioni crossmodali. Ad esempio indicano la sedia e dicono "mamma" per indicare dove deve sedersi la madre. Anche successivamente quando la modalità vocale sembra aver preso il sopravvento, il gesto continua a svolgere un ruolo importante. Ad esempio, in un compito di denominazione di foto utilizzato per valutare la comprensione e produzioni di nomi e predicati, bambini udenti italiani, in età tra i due e i tre anni, spesso producevano gesti deittici o rappresentativi in accompagnamento o in sostituzione alle parole. Analizzando i gesti prodotti si è scoperto che alcuni rappresentavano le azioni raffigurate nella foto presentata al bambino, altri le azioni eseguite con l'oggetto raffigurato nella foto, altri le azioni che caratterizzavano il personaggio raffigurato nella foto. Confrontando le produzioni di bambini diversi di fronte alla stessa foto, sono state notate forti somiglianze nelle caratteristiche motorie di esecuzione del gesto. Inoltre, un'analisi più dettagliata relativa alle forme delle mani nell'esecuzione di questi gesti ha permesso di scoprire che i bambini udenti italiani utilizzavano nei gesti le stesse forme delle mani utilizzate da bambini che acquisiscono la lingua dei segni americana. 3: STRATEGIE RAPPRESENTATIVE Negli ultimi anni si è cominciato a capire che le strategie di rappresentazione simbolica sono fondamentalmente quattro: A. mimo: tutto il corpo rappresenta l'azione o il personaggio; B. manipolazione: le mani assumono un tipo di afferramento che rimanda all'azione su un oggetto immaginato; C. mano come oggetto: le mani diventano l'oggetto che si vuole rappresentare; D. forma e misura: le mani tracciano la forma o indicano le dimensioni dell'oggetto che si intende rappresentare. In sostanza, sia nel caso dei gesti comunicativi che dei segni è possibile attraverso la modalità corporea rendere visibile ciò di cui si parla, adottando la prospettiva del protagonista, personaggio, Document shared on https://www.docsity.com/it/descrivere-la-lingua-dei-segni-italiana-una-prospettiva-cognitiva-e-sociosemiotica/7283336/