Appunti sulla logica arcaica, Parmenide, Eraclito e il neopositivismo
Documento di Università sulla logica arcaica, Parmenide, Eraclito e il neopositivismo logico. Il Pdf, utile per la materia Filosofia, esplora il problema logico, la tri-unità di pensiero, linguaggio e realtà, i paradossi di Zenone e i concetti di verità logiche e sperimentali.
Mostra di più51 pagine
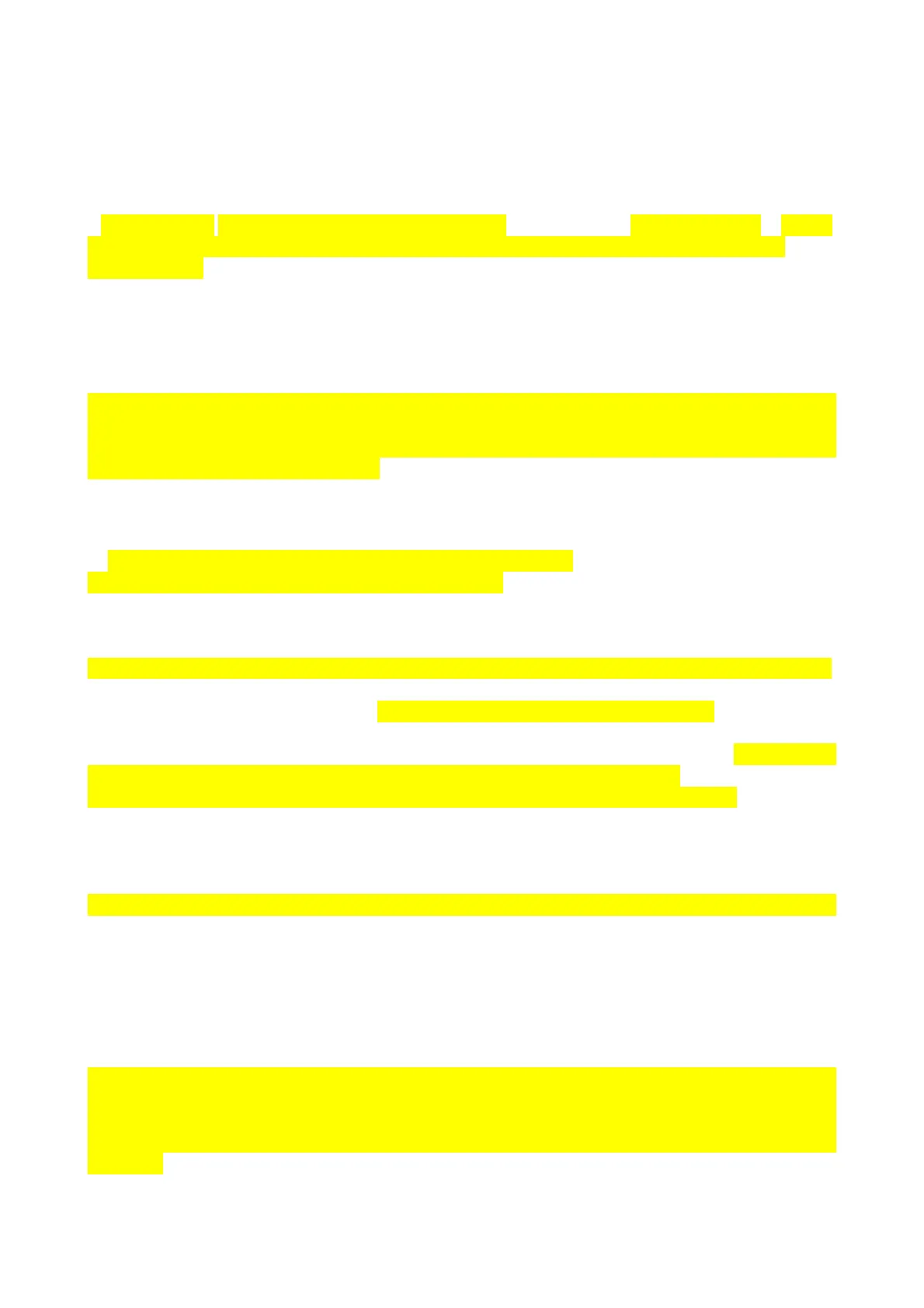
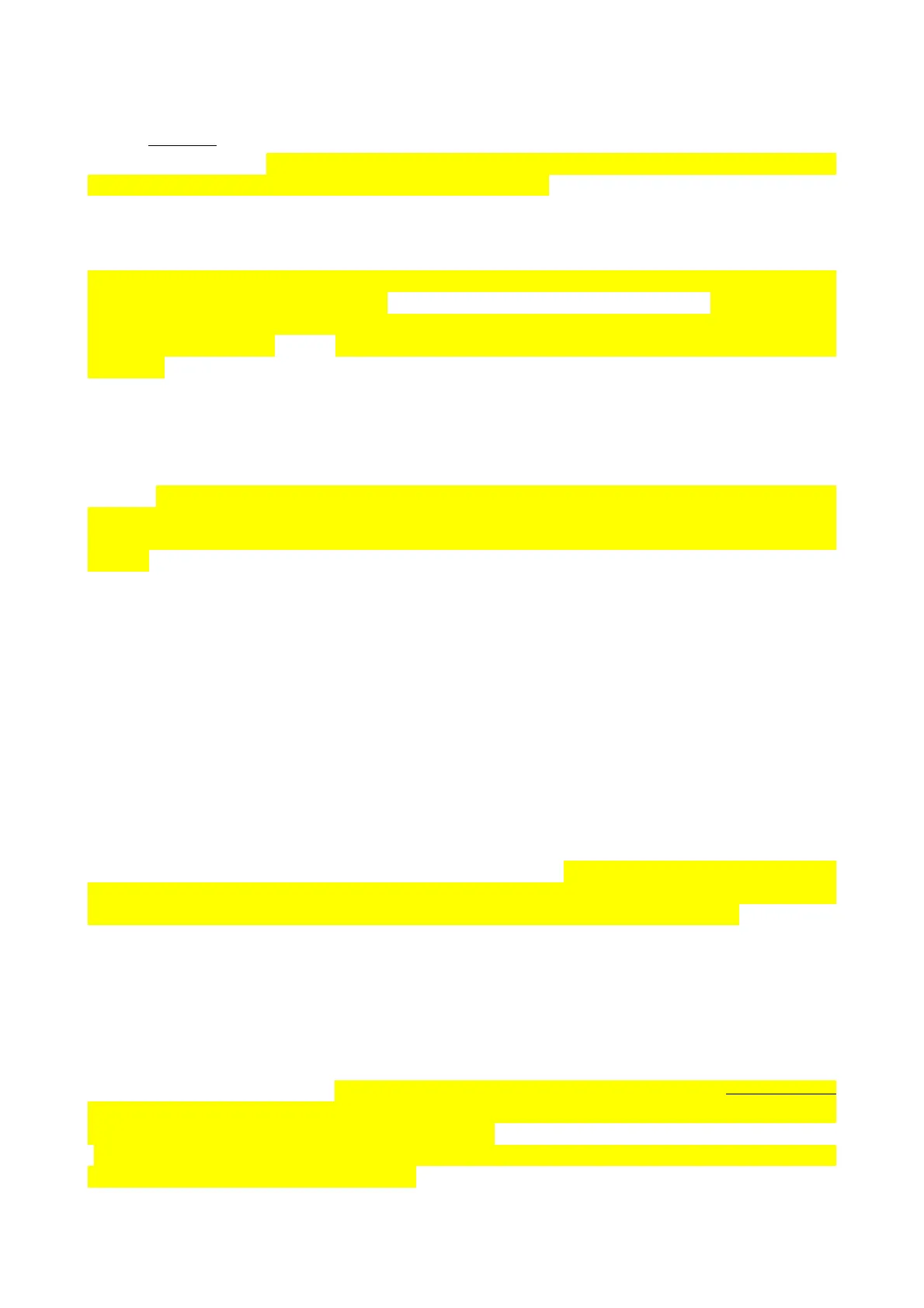
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Logica Arcaica e Problemi Logici
Il Problema Logico e la Logica Pre-Aristotelica
LEZ. 2
1) Che cosa si intende per «problema logico»? Per quali motivi è legittimo parlare di «logica»
prima della messa a punto della "logica classica" di Aristotele?
Il problema logico riguarda l'insieme delle singole questioni, molte delle quali di carattere pratico, a partire
da cui prende avvio una forma di riflessione volta a stabilire le condizioni di correttezza ed errore del
pensiero verbale, concepito come inseparabile dalle realtà materiali da esso espresse. Prima di Aristotele
alcuni autori hanno cercato di sviluppare un pensiero logico che consentisse di spiegare la natura a partire
da argomentazioni coerenti e razionali ed è per questo che appare legittimo parlare di logica prima della
messa a punto della "logica classica" di Aristotele.
Tri-unità di Pensiero, Linguaggio e Realtà nella Logica Arcaica
2. Cosa si intende per tri-unità di pensiero, linguaggio e realtà con riferimento alla logica arcaica?
Secondo gli autori "preplatonici", parlare di Tri-unità di pensiero, linguaggio e realtà significa non fare
distinzione tra ambito del pensiero, struttura del linguaggio e mondo materiale. Questo significa che ciò che
è linguisticamente espresso in modo «corretto» deve essere «vero» con riguardo al pensiero, e al contempo
«reale» in riferimento al mondo esterno. Nella "logica arcaica" i tre momenti epistemologici della logica,
dell'ontologia e della gnoseologia, permangono ancora indistinti.
Caratteristiche Strutturali della Logica Arcaica
3. Quali sono le caratteristiche strutturali principali della logica arcaica?
Le caratteristiche strutturali principali della logica arcaica sono quattro:
Prima di tutto la Tri- unità di pensiero, linguaggio e realtà. Non c'è distinzione tra ambito del pensiero,
struttura del linguaggio e mondo materiale. Il che vuol dire che, ciò che è linguisticamente espresso in modo
«corretto» deve essere «vero» con riguardo al pensiero, e al contempo «reale» in riferimento al mondo
esterno.
Una seconda caratteristica generale della logica arcaica è la cosiddetta Unità indifferenziata di parole e cose:
i nomi non sono una semplice "etichetta" che aderisce accidentalmente alla cosa designata per rendere
possibile la comunicazione tra uomini. Tra parola e cosa c'è una relazione intrinseca.
Le cose sono
strutturate verbalmente, come se fossero le parole da cui vengono designate; le parole, d'altro canto, hanno
la medesima capacità di produrre effetti e la medesima tangibilità delle cose che designano. Le parole sono
la "voce" delle cose. Non a caso nella "logica arcaica" si parla a rigore di «cose-nomi».
Una terza caratteristica della logica arcaica è la cosiddetta Natura verbale dell'«errore».
Nella "logica
arcaica" l'errore non è dovuto a una mancata adeguazione di discorsi a stati di fatto, ma errare è
semplicemente «parlar male». Poiché l'espressione verbale non si distingue dal suo contenuto, ciò che
infrange i criteri dell'espressione verbale è di conseguenza «falso». D'altro canto, tutto ciò che è esprimibile
in modo corretto, per quanto paradossale possa apparire, è «vero» e «reale».
Una quarta caratteristica della logica arcaica è la scaturigine dei problemi a partire dalle forme linguistiche.
Nella "logica arcaica" è ravvisabile una certa tendenza a tradurre continuamente contingenze linguistiche in
problemi.
Confronto tra Parmenide ed Eraclito
Differenze e Punti di Contatto tra le Logiche di Parmenide e Eraclito
LEZ. 3
4. Quali sono le differenze e i punti di contatto tra le logiche di Parmenide e Eraclito?
Parmenide, come Eraclito, prendendo le mosse dall'unità indifferenziata di parole e cose, pur non
mettendola mai in discussione, non è disposto ad ammetterne la fatale aporia che ne consegue: egli si
chiede come è possibile, se ogni realtà del mondo è quel che è in quanto ha il nome che ha, e se ad ogni
cosa corrisponde il suo proprio nome, che la sua esistenza implichi in qualche modo anche una sua
negazione.
A differenza di Eraclito che constatava che in ogni cosa-nome ad ogni «è» si accompagna un «non è»,
Parmenide tenta di rimuovere questo conflitto di denominazioni, che di conseguenza è anche un conflitto
1reale, trovando almeno una parola in cui questa drammatica condizione non è valida. E lo farà attingendo al
termine «essere», che nel greco di Parmenide veniva usato per esprimere molteplici stati di cose, tra cui
l'affermazione. Pertanto, se per Eraclito le cose-nomi al contempo «sono» e «non sono», per Parmenide
esse «non sono» rispetto all'autentica cosa-nome che è l'«essere».
Caratteri Generali dell'Opera di Eraclito nella Logica Arcaica
5. Quali sono i caratteri generali dell'opera di Eraclito nel contesto della "logica arcaica"?
Per Eraclito la struttura del linguaggio coincide con la struttura della realtà materiale, le determinazioni
verbali valgono come determinazioni reali. Celebre è la tesi di Eraclito secondo la quale ogni aspetto della
realtà è l'esito di un conflitto tra opposti, una sua vittoria transitoria e momentanea prima di venir oppresso
e invaso dal suo opposto. Perciò, paradossalmente, «giorno» e «notte», «vita» e «morte» ecc. sono la
stessa cosa.
Inoltre Eraclito parte dall'idea del "tutto scorre" (panta rhei), dove l'accento viene posto sul perpetuo
divenire delle cose invece che sul perenne conflitto dei diversi aspetti opposti del reale.
Le conclusioni alle sue teorie provengono non dall'osservazione ripetuta di stati di cose, ma dal considerare
la struttura del reale concordante con la struttura del linguaggio. Gli aspetti opposti del reale sono in
relazione, si implicano e condizionano a vicenda, l'uno è indispensabile per la configurazione dell'altro.
Pertanto quando egli parla di armonia degli opposti si riferisce alla loro compagine ben connessa, la
risultante dell'equilibrio di sforzi opposti e tensioni contrarie. La relazione oppositiva tra parole si converte
in un conflitto e connubio di realtà opposte. Per Eraclito ogni antitesi verbale diviene sempre un'antitesi
effettiva.
Caratteri Generali dell'Opera di Parmenide nella Logica Arcaica
6. Quali sono i caratteri generali dell'opera di Parmenide nel contesto della logica arcaica?
Parmenide, come Eraclito, prendendo le mosse dall'unità indifferenziata di parole e cose, pur non
mettendola mai in discussione, non è disposto ad ammetterne la fatale aporia che ne consegue: egli si
chiede come è possibile, se ogni realtà del mondo è quel che è in quanto ha il nome che ha, e se ad ogni
cosa corrisponde il suo proprio nome, che la sua esistenza implichi in qualche modo anche una sua
negazione.
A differenza di Eraclito che constatava che in ogni cosa-nome ad ogni «è» si accompagna un «non è»,
Parmenide tenta di rimuovere questo conflitto di denominazioni, che di conseguenza è anche un conflitto
reale, trovando almeno una parola in cui questa drammatica condizione non è valida. E lo farà attingendo al
termine «essere», che nel greco di Parmenide veniva usato per esprimere molteplici stati di cose, tra cui
l'affermazione. Pertanto, se per Eraclito le cose-nomi al contempo «sono» e «non sono», per Parmenide
esse «non sono» rispetto all'autentica cosa-nome che è l'«essere». Parmenide nella reciproca opposizione
di tutti i segni, e dunque di tutte le cose, salva solo quella che nella sua espressione verbale non avesse
avuto altro all'infuori di ciò che manifesta l'esistenza di ogni cosa-nome, ossia la parola essere.
I Paradossi di Zenone
Esposizione dei Paradossi di Zenone
LEZ. 4
7. Si espongano i paradossi di Zenone
A Zenone, allievo di Parmenide, si devono alcuni celebri paradossi direttamente conseguenti agli
atteggiamenti mentali da cui scaturisce la "logica arcaica", e in particolare all'impostazione del «problema
logico» prospettata da Parmenide. Essi mostrano in modo esemplare a quali conseguenze di indecidibilità
può condurre una considerazione della realtà che rimanga su un piano puramente linguistico: il cosiddetto
paradosso di "Achille e la tartaruga" e quello della "freccia".
L'idea generale sottesa al paradosso di "Achille e la tartaruga" è che «sia necessario che chi insegue giunga
prima al punto da cui è partito chi fugge». «Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga,
simbolo di lentezza. Egli corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci metri di vantaggio.
2Achille ha percorso 10 metri, e la tartaruga è ancora avanti di un metro; Achille percorre quel metro, e la
tartaruga percorre un decimetro, e così via all'infinito; di modo che Achille può correre per sempre senza
raggiungerla»
Quella invece sottesa al paradosso della freccia è che «ciò che si muove occupa sempre in un istante di
tempo, uno spazio uguale a sé». La freccia impiegherà di sicuro un certo tempo per giungere al suo
bersaglio. Ora, dividendo questo tratto di tempo in istanti, risulta che in ogni istante di tempo la freccia può
occupare soltanto una porzione di spazio identica alla sua stessa lunghezza, e quindi è di fatto ferma in ogni
istante. Ma come è possibile, allora, che dalla somma di tutti quegli istanti di tempo in cui la freccia risulta
ferma scaturisca un suo movimento?
Contenuto e Significato del Paradosso di Achille e la Tartaruga
8. Si espongano il contenuto e il significato del paradosso zenoniano di "Achille e la tartaruga"
L'idea generale sottesa al paradosso zenoniano di "Achille e la tartaruga" è che «sia necessario che chi
insegue giunga prima al punto da cui è partito chi fugge». «Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la
tartaruga, simbolo di lentezza. Egli corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci metri di
vantaggio. Achille ha percorso 10 metri, e la tartaruga è ancora avanti di un metro; Achille percorre quel
metro, e la tartaruga percorre un decimetro, e così via all'infinito; di modo che Achille può correre per
sempre senza raggiungerla»
Contenuto e Significato del Paradosso della Freccia
9. Si espongano il contenuto e il significato del paradosso zenoniano della "freccia"
L'idea generale sottesa al paradosso zenoniano della "freccia" è che «ciò che si muove occupa sempre in un
istante di tempo, uno spazio uguale a se». La freccia impiegherà di sicuro un certo tempo per giungere al
suo bersaglio. Ora, dividendo questo tratto di tempo in istanti, risulta che in ogni istante di tempo la freccia
può occupare soltanto una porzione di spazio identica alla sua stessa lunghezza, e quindi è di fatto ferma in
ogni istante. Ma come è possibile, allora, che dalla somma di tutti quegli istanti di tempo in cui la freccia
risulta ferma scaturisca un suo movimento?
Melisso e Anassagora nella Logica Arcaica
Caratteri Generali dell'Opera di Melisso
LEZ.5
10. Quali sono i caratteri generali dell'opera di Melisso nel contesto della logica arcaica?
Melisso, fu celebre per il suo motto: «il niente dal niente> attraverso il quale egli trasporta la problematica
di Parmenide direttamente sul piano del visibile, e lo caratterizza in senso temporale. Dal piano verbale
l'«essere» si cala, per così dire, sul piano della materia, e acquista alcune determinazioni "positive", delle
quali quella secondo il tempo (l'«eternità») diventa la prioritaria. Anche l'ideale dell'«eterno», dunque,
nasce da un'insidia della parola.
Caratteri Generali dell'Opera di Anassagora
11. Quali sono i caratteri generali dell'opera di Anassagora nel contesto della logica arcaica?
Anassagora condivide l'impostazione di Empedocle, in modo particolare la stabilità delle singole cose, che,
in quanto oggetti determinati, non rischiano di venir meno nel loro esser tali per quanto sia variabile il loro
ordine di accrescimento o diminuzione. Una delle molte innovazioni di Anassagora rispetto ai pensatori
precedenti è l'aver introdotto termini di "prospettiva" al di là dei nomi delle cose, che però, al pari di questi,
appartengono alla natura verbale e materiale delle «cose-nomi» senza intaccarne in alcun modo il grado di
esistenza. Per quanto le cose possano venir accresciute o diminuite esse rimangono né più né meno di quel
che sono, non perdono o acquistano un solo granello del loro "essere così e non altrimenti". A questa
dottrina è collegata anche una teoria della causalità e dell'«intelletto» di particolare interesse
epistemologico. Per quanto riguarda la prima, Anassagora ritiene che l'effetto, prima di giungere ad
esistenza, sarebbe già presente nella causa. Per quanto invece riguarda la seconda, l'«intelletto» viene
concepito da Anassagora non come una semplice facoltà umana, ma come una (invisibile) realtà
onnipervadente di cui partecipa ogni «cosa-nome».