Argomenti di Filosofia del Diritto: Teoria Generale e Kelsen
Documento di Università su Argomenti di Filosofia del Diritto. Il Pdf esplora la nascita della teoria generale del diritto, la rielaborazione di Hans Kelsen, la teoria delle codificazioni e l'utilitarismo inglese, per la materia Diritto.
Mostra di più67 pagine
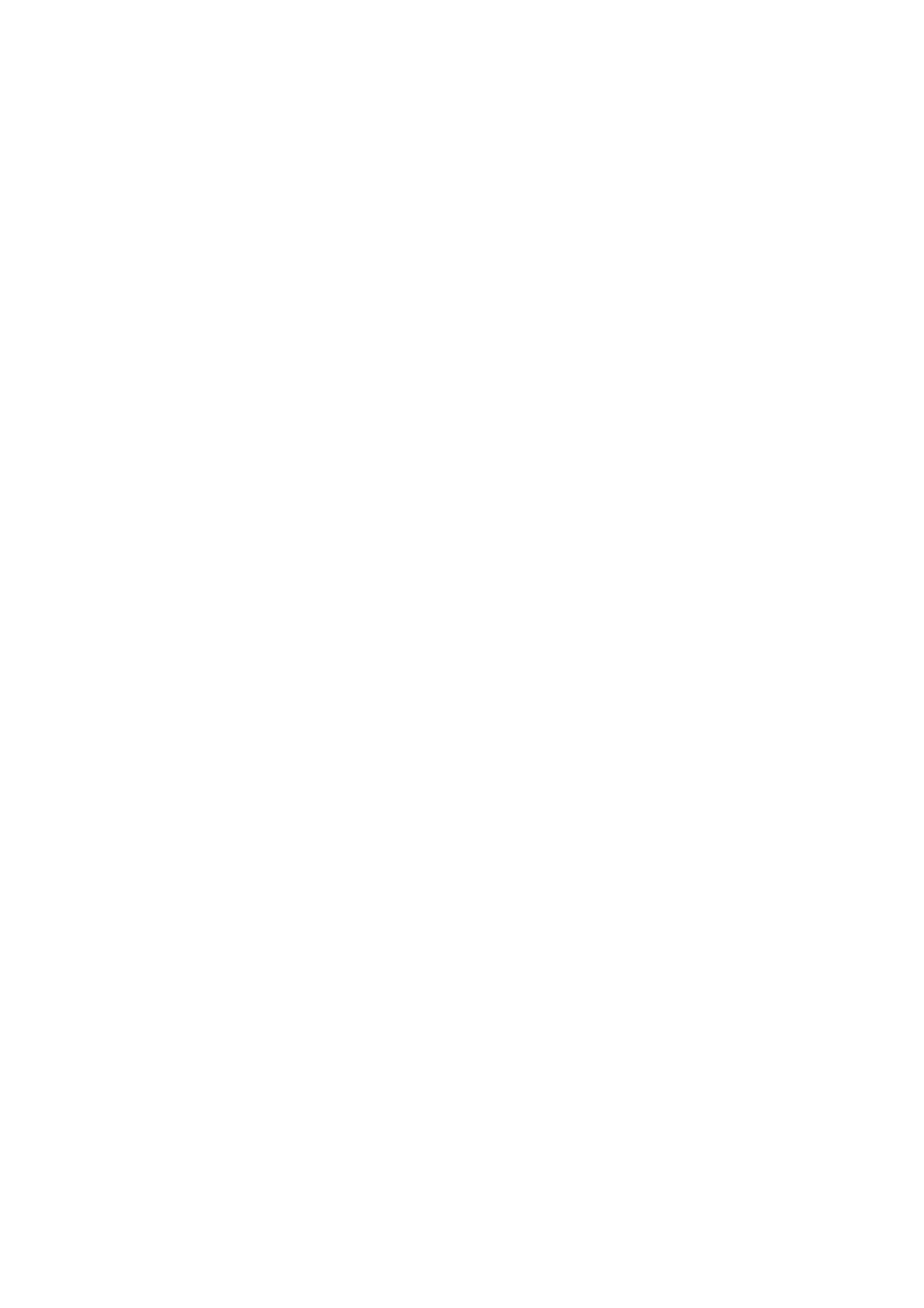
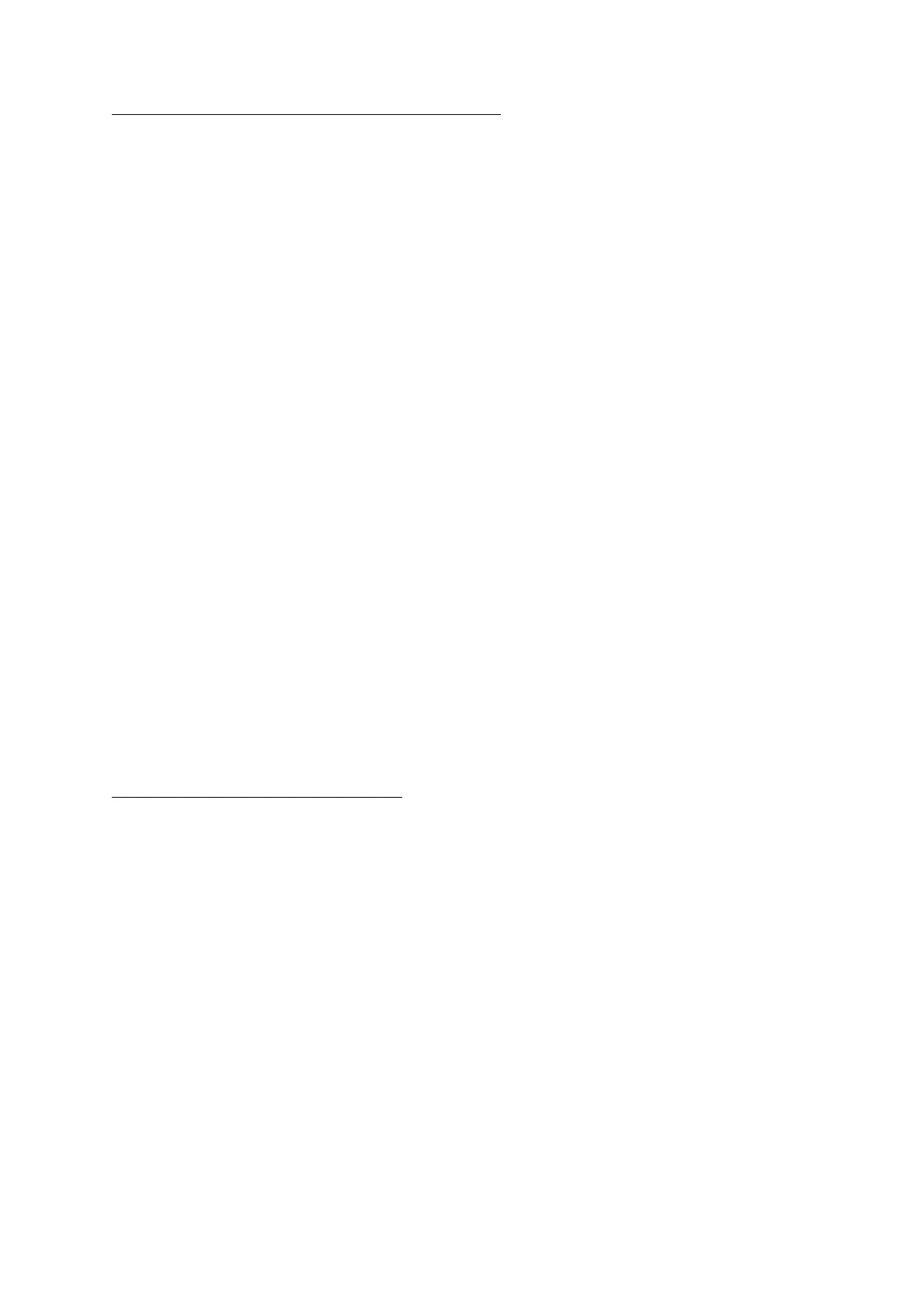
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
INTRODUZIONE
La nascita della teoria generale del diritto
L'atto di nascita della teoria del diritto è unanimemente individuato nell'articolo del 1874 del giurista tedesco Adolf Merkel dal titolo "Sul rapporto tra filosofia del diritto e scienza positiva del diritto", nel quale veniva sostenuta la tesi che non c'è filosofia del diritto se non nel diritto positivo e che perciò filosofia del diritto e teoria generale del diritto coincidono.
La teoria di Merkel rappresenta il punto di approdo di alcuni orientamenti della cultura giuridica del primo Ottocento:
- in Germania i post-kantiani erano cimentati in elaborazioni razionali del diritto positivo, assumendo tale diritto come elemento empirico da ordinare nelle forme a priori della ragione secondo il procedimento della scienza teorizzato da Kant nella "Critica della ragion pura".
- la Pandettistica propugnava una scienza giuridica costituita da una genealogia di concetti.
- In Inghilterra Austin, riprendendo Bentham, perviene all'elaborazione della analytical jurisprudence intesa come teoria del diritto positivo in generale, a differenza dei post-kantiano e dei pandettisti che adottavano un metodo logico-formale, Austin perviene alla costruzione di un sistema di concetti attraverso la comparazione di elementi giuridici positivi diversi nello spazio e nel tempo.
Merkel e gli altri esponenti della Allgemeine Rechtslehre (teoria generale del diritto), pensavano che una teoria formale delle norme positive potesse costituire un sistema razionale analogo a quello delle scienze della natura e realizzare una scienza del diritto. Si allontanavano però così dall'idea di scienza propria del positivismo giuridico ed elaborarono una scienza di norme positive nel senso di poste dalla volontà del legislatore.
La teoria generale del diritto portò a un grande raffinamento degli strumenti della scienza giuridica e all'elaborazione dei concetti tuttora fondamentali nello studio del diritto e alla determinazione dei "caratteri differenziali del diritto", ovvero i caratteri che distinguono le norme giuridiche da altri tipi di norme e che possiamo individuare nella statualità, nell'imperatività, nella bilateralità, nell'astrattezza, nella generalità, nella coercibilità e nella certezza.
La rielaborazione di Hans Kelsen
Di fronte alla crisi dello Stato moderno accentratore e alla tendenza dei gruppi sociali a costituirsi in cerchie giuridiche indipendenti, si fa strada la tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici.
L'affermarsi in ambito filosofico del neopositivismo logico poi aveva portato nuovi argomenti contro la teoria imperativistica sostituendo alla nozione di norma come comando, quella di proposizione prescrittiva.
Kelsen, giurista austriaco, è sicuramento il maggior interprete di questa ondata di cambiamento e di revisione della teoria del diritto. Per Kelsen le norme giuridiche non sono comandi ma giudizi ipotetici che enunciano che, dato un evento A (l'illecito), ad esso deve seguire un evento B (la sanzione): se c'è A, allora deve essere B principio di imputazione. Quindi, a differenza del principio di causalità (se c'è A c'è B), che esprime un rapporto oggettivo e immanente tra i due accadimenti, il principio di imputazione assume un fatto come condizione e un altro come conseguenza, connettendo il secondo al primo.
Ciò che caratterizza le norme giuridiche da altri tipi di norme è la sanzione, che rappresenta l'elemento specifico e qualificante della norma giuridica. Alla luce di ciò, Kelsen chiama primaria la norma che enuncia la sanzione come conseguenza di un dato comportamento (comunemente chiamata secondaria), e secondaria la norma che prescrive ai soggetti un determinato comportamento (comunemente dettaprimaria). Per Kelsen titolare di un diritto soggettivo è "l'individuo la cui manifestazione di volontà è condizione della sanzione".
Kelsen distingue tra sistemi statici e dinamici, i primi sono quelli in cui le norme sono collegate tra loro in base al loro contenuto, mentre nei sistemi dinamici le norme sono collegate tra loro in base ad un criterio formale (derivano le une dalle altre attraverso le delegazioni di potere).
L'ordinamento giuridico, esempio tipico di ordinamento dinamico, consta di norme di condotta (che prescrivono determinati comportamenti) e di norme di competenza (che prescrivono chi e con quali formalità può e deve emanare norme). L'ordinamento giuridico ha una struttura piramidale: alla base troviamo le norme individuali (atti amministrativi e giurisdizionali) che derivano la loro validità da una norma superiore, la quale è a sua volta valida perché posta in essere da organi cui un'altra norma ancora superiore attribuisce tale potere e così via. All'apice troviamo la norma fondamentale che costituisce il fondamento di validità di tutto il sistema di norme che compongono un ordinamento giuridico: tale norma dapprima era definita "presupposto logico trascendentale", poi viene riferita ad una "costituzione effettivamente statuita ed efficace, ed una costituzione è efficace quando le norme prodotte in conformità alle sue disposizioni sono applicate e seguite".
La teoria kelseniana costituisce la formulazione più rigorosa di una teoria formale del diritto (nel senso che studia il diritto nella sua struttura normativa, nella sua forma). Per costruire un sistema logico coerente, il fenomeno giuridico viene ridotto ad un unico oggetto, la norma.
Teoria del diritto e filosofia analitica
La teoria del diritto trovò nuovi fondamenti e nuovi elementi di sviluppo nella filosofia analitica, la quale ritiene che il compito essenziale della filosofia sia la chiarificazione di ogni tipo di linguaggio.
Il carattere essenziale della scienza non è la sua verità assoluta ma il rigore del suo procedimento.
Questo approccio, che aveva in parte già interessato Kelsen, influenzò profondamente i giuristi Hart in Inghilterra e Bobbio in Italia.
Hart, in consonanza con Kelsen, sostituisce alla nozione austiniana di diritto come comando coattivo, la nozione di norma. Hart argomenta che il comando richiede un appropriato rapporto tra chi comanda e il destinatario del comando e, inoltre, che il comando ha un carattere episodico legato ad una situazione di superiorità tra chi lo emana e chi lo riceve.
Tutti caratteri che la norma giuridica non ha: essa infatti non presuppone un rapporto diretto tra chi comanda e chi è comandato, ma è generale; non ha carattere episodico, bensì permanente; non poggia su una posizione di superiorità tra chi comanda, bensì deve la sua efficacia alla disposizione di abituale obbedienza dei consociati al diritto.
Come Kelsen, anche Hart ritiene che il diritto sia un ordinamento di norme, ovvero l'unione di due tipi di norme: le primarie, che impongono obblighi, e le secondarie, che attribuiscono poteri.
Nella combinazione di questi due tipi di norme Hart ritiene che stia quella "chiave della scienza del diritto" che Austin aveva individuato nella nozione di comando coattivo ovvero la norma di riconoscimento. Questa è un fatto empirico, è implicita nell'attività giuridica effettiva.
Negli stessi anni, in Italia, Bobbio propone una sorta di innesto tra teoria del diritto kelseniana e filosofia analitica. Il punto di convergenza veniva individuato nel fatto che, da un lato, la teoria kelseniana si presentava come metodo avalutativo e scientifico di studio del diritto, volto alla costruzione di una scienza giuridica "purificata" da implicazioni ideologiche e, dall'altro, la filosofia analitica affermava la necessità di una ricerca non volta ai valori ultimi ma limitata a dare chiarezza e rigore ad ogni tipo di linguaggio.Proprio questo innesto ha portato alla luce difficoltà e insufficienza di una teoria meramente strutturale del diritto. In primo luogo, Bobbio rileva che essa non è affatto avalutativa: infatti la validità di una norma implica la sua obbligatorietà nel senso che tale norma venga assunta come criterio guida del comportamento. In secondo luogo, l'approccio meramente strutturale, porta Bobbio a riconoscere l'esigenza di un'analisi funzionale da affiancare alla teoria formale: il diritto non è un sistema chiuso ed indipendente, bensì un sottosistema all'interno del sistema sociale complessivo, e ciò che lo distingue è la funzione.
La teoria del diritto realista
Gli antiformalisti di fine Ottocento e inizio Novecento, avevano messo in crisi alcuni assunti della teoria del diritto positivistica ma senza elaborare una teoria alternativa, che verrà invece formulata dallo scandinavo Karl Olivecrona.
Olivecrona sostiene che il linguaggio giuridico sia un linguaggio direttivo, che fa uso di termini che non hanno alcun referente semantico, nel senso che non esiste alcun fenomeno nel mondo spazio-temporale corrispondente a tali locuzioni.
Secondo Olivecrona, le norme non sono dei comandi, bensì imperativi indipendenti, ossia rappresentazioni di modelli di comportamento espressi in forma imperativa. Un comando infatti implica un rapporto diretto tra chi comanda e chi obbedisce, una relazione di subordinazione tra i due, ed è episodico, mentre le norme sono comandi "spersonalizzati", nel senso che chi comanda è un'entità astratta, il legislatore, e chi è comandato è la generalità dei consociati, e valgono nel tempo fino a che non vengono modificate. Il diritto è un insieme di norme che esercitano un potere vincolante sui membri di una comunità.
La teoria del diritto elaborata da Olivecrona è una teoria realista-normativista: il diritto viene considerato un fatto, ossia un meccanismo sociale, una realtà socio-psicologica; le norme, sono effettivamente seguite perché sono sperimentate e sentite come socialmente vincolanti in primo luogo dai giudici. La norma non è valida se non è efficace, ma per essere efficace deve essere sentita come socialmente vincolante. Attraverso questo elemento psicologico (il senso di obbligatorietà) avviene il recupero dell'elemento normativo, caratteristica del realismo scandinavo.
Il linguaggio giuridico non è descrittivo ma ha una funzione direttiva: è un linguaggio capace di influenzare il comportamento e serve come strumento di controllo sociale.
La teoria del diritto oggi
Nel corso della prima metà del '900, con il superamento della concezione statalista e imperativista del diritto, si fa strada la consapevolezza che il diritto sia una realtà complessa non riducibile alle norme formalmente valide.
Nel prima metà del secolo scorso, Bobbio ha sottolineato la distinzione tra filosofia del diritto dei filosofi e filosofia del diritto dei giuristi: la prima prende le mosse da una certa concezione del mondo e la applica al diritto, la seconda invece muove dall'esperienza giuridica concreta.
CAP 1- NORME GIURIDICHE
Norme come segni linguistici (o come enunciazione)?
Se con "norma" si intende un segno, una scrittura, o una specifica enunciazione, allora qualsiasi cittadino che abbia copiato le norme per ricordarsele meglio, sta seguendo norme diverse per il solo motivo che esse sono state scritte su un supporto diverso e non sono l'enunciazione/scrittura originale. Si tratta pertanto di conseguenze assurde.