Romanticismo e Idealismo: sintesi della filosofia tedesca di fine '700
Documento dall'Università su Romanticismo e Idealismo (sintesi). Il Pdf analizza la filosofia tedesca di fine '700, il rifiuto della ragione illuministica, il senso dell'infinito e la Sehnsucht, la filosofia politica. Utile per lo studio della Filosofia a livello universitario.
Mostra di più9 pagine
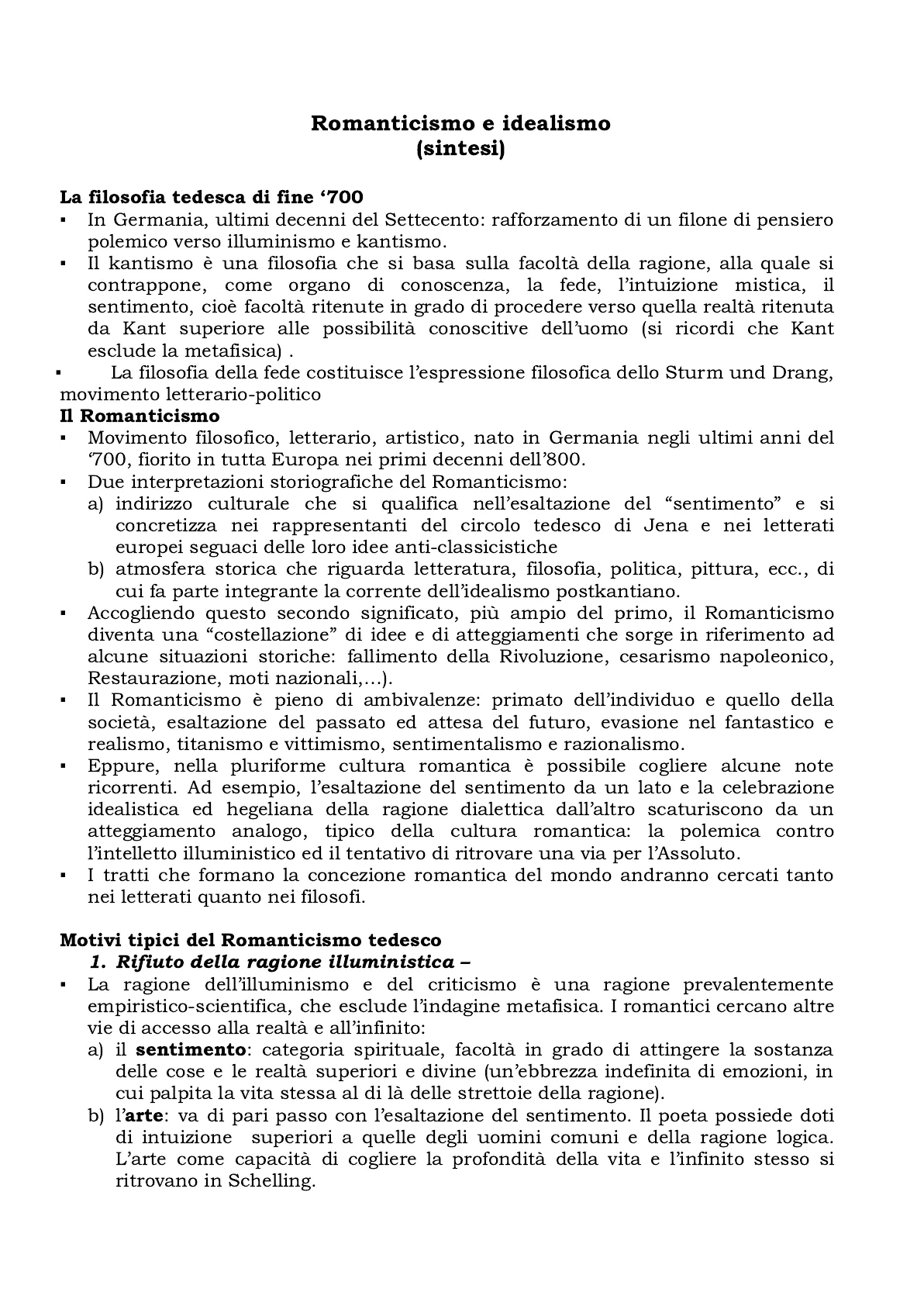
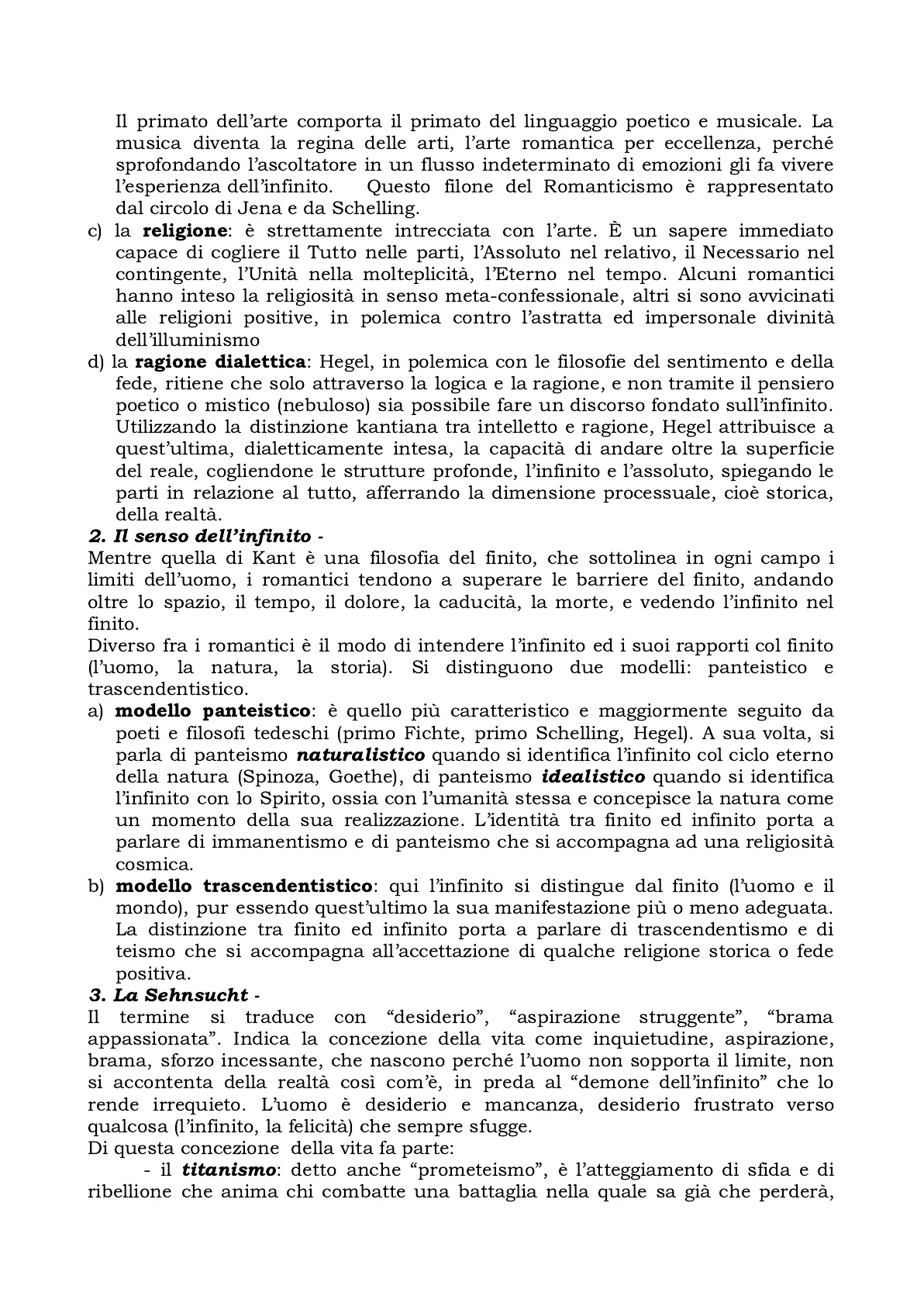
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
La filosofia tedesca di fine '700
- In Germania, ultimi decenni del Settecento: rafforzamento di un filone di pensiero polemico verso illuminismo e kantismo.
- Il kantismo è una filosofia che si basa sulla facoltà della ragione, alla quale si contrappone, come organo di conoscenza, la fede, l'intuizione mistica, il sentimento, cioè facoltà ritenute in grado di procedere verso quella realtà ritenuta da Kant superiore alle possibilità conoscitive dell'uomo (si ricordi che Kant esclude la metafisica) .
La filosofia della fede costituisce l'espressione filosofica dello Sturm und Drang, movimento letterario-politico
Il Romanticismo
- Movimento filosofico, letterario, artistico, nato in Germania negli ultimi anni del '700, fiorito in tutta Europa nei primi decenni dell'800.
- Due interpretazioni storiografiche del Romanticismo:
- indirizzo culturale che si qualifica nell'esaltazione del "sentimento" e si concretizza nei rappresentanti del circolo tedesco di Jena e nei letterati europei seguaci delle loro idee anti-classicistiche
- atmosfera storica che riguarda letteratura, filosofia, politica, pittura, ecc., di cui fa parte integrante la corrente dell'idealismo postkantiano.
- Accogliendo questo secondo significato, più ampio del primo, il Romanticismo diventa una "costellazione" di idee e di atteggiamenti che sorge in riferimento ad alcune situazioni storiche: fallimento della Rivoluzione, cesarismo napoleonico, Restaurazione, moti nazionali, ... ).
Il Romanticismo è pieno di ambivalenze: primato dell'individuo e quello della società, esaltazione del passato ed attesa del futuro, evasione nel fantastico e realismo, titanismo e vittimismo, sentimentalismo e razionalismo.
- Eppure, nella pluriforme cultura romantica è possibile cogliere alcune note ricorrenti. Ad esempio, l'esaltazione del sentimento da un lato e la celebrazione idealistica ed hegeliana della ragione dialettica dall'altro scaturiscono da un atteggiamento analogo, tipico della cultura romantica: la polemica contro l'intelletto illuministico ed il tentativo di ritrovare una via per l'Assoluto.
- I tratti che formano la concezione romantica del mondo andranno cercati tanto nei letterati quanto nei filosofi.
Motivi tipici del Romanticismo tedesco
1. Rifiuto della ragione illuministica
- La ragione dell'illuminismo e del criticismo è una ragione prevalentemente empiristico-scientifica, che esclude l'indagine metafisica. I romantici cercano altre vie di accesso alla realtà e all'infinito:
- il sentimento: categoria spirituale, facoltà in grado di attingere la sostanza delle cose e le realtà superiori e divine (un'ebbrezza indefinita di emozioni, in cui palpita la vita stessa al di là delle strettoie della ragione).
- l'arte: va di pari passo con l'esaltazione del sentimento. Il poeta possiede doti di intuizione superiori a quelle degli uomini comuni e della ragione logica. L'arte come capacità di cogliere la profondità della vita e l'infinito stesso si ritrovano in Schelling.Il primato dell'arte comporta il primato del linguaggio poetico e musicale. La musica diventa la regina delle arti, l'arte romantica per eccellenza, perché sprofondando l'ascoltatore in un flusso indeterminato di emozioni gli fa vivere l'esperienza dell'infinito.
Questo filone del Romanticismo è rappresentato dal circolo di Jena e da Schelling.
- la religione: è strettamente intrecciata con l'arte. È un sapere immediato capace di cogliere il Tutto nelle parti, l'Assoluto nel relativo, il Necessario nel contingente, l'Unità nella molteplicità, l'Eterno nel tempo. Alcuni romantici hanno inteso la religiosità in senso meta-confessionale, altri si sono avvicinati alle religioni positive, in polemica contro l'astratta ed impersonale divinità dell'illuminismo
- la ragione dialettica: Hegel, in polemica con le filosofie del sentimento e della fede, ritiene che solo attraverso la logica e la ragione, e non tramite il pensiero poetico o mistico (nebuloso) sia possibile fare un discorso fondato sull'infinito. Utilizzando la distinzione kantiana tra intelletto e ragione, Hegel attribuisce a quest'ultima, dialetticamente intesa, la capacità di andare oltre la superficie del reale, cogliendone le strutture profonde, l'infinito e l'assoluto, spiegando le parti in relazione al tutto, afferrando la dimensione processuale, cioè storica, della realtà.
2. Il senso dell'infinito
Mentre quella di Kant è una filosofia del finito, che sottolinea in ogni campo i limiti dell'uomo, i romantici tendono a superare le barriere del finito, andando oltre lo spazio, il tempo, il dolore, la caducità, la morte, e vedendo l'infinito nel finito.
Diverso fra i romantici è il modo di intendere l'infinito ed i suoi rapporti col finito (l'uomo, la natura, la storia). Si distinguono due modelli: panteistico e trascendentistico.
- modello panteistico: è quello più caratteristico e maggiormente seguito da poeti e filosofi tedeschi (primo Fichte, primo Schelling, Hegel). A sua volta, si parla di panteismo naturalistico quando si identifica l'infinito col ciclo eterno della natura (Spinoza, Goethe), di panteismo idealistico quando si identifica l'infinito con lo Spirito, ossia con l'umanità stessa e concepisce la natura come un momento della sua realizzazione. L'identità tra finito ed infinito porta a parlare di immanentismo e di panteismo che si accompagna ad una religiosità cosmica.
- modello trascendentistico: qui l'infinito si distingue dal finito (l'uomo e il mondo), pur essendo quest'ultimo la sua manifestazione più o meno adeguata. La distinzione tra finito ed infinito porta a parlare di trascendentismo e di teismo che si accompagna all'accettazione di qualche religione storica o fede positiva.
3. La Sehnsucht
Il termine si traduce con "desiderio", "aspirazione struggente", "brama appassionata". Indica la concezione della vita come inquietudine, aspirazione, brama, sforzo incessante, che nascono perché l'uomo non sopporta il limite, non si accontenta della realtà così com'è, in preda al "demone dell'infinito" che lo rende irrequieto. L'uomo è desiderio e mancanza, desiderio frustrato verso qualcosa (l'infinito, la felicità) che sempre sfugge.
Di questa concezione della vita fa parte:
- il titanismo: detto anche "prometeismo", è l'atteggiamento di sfida e di ribellione che anima chi combatte una battaglia nella quale sa già che perderà,data l'impossibilità di superare le barriere del finito. A volte, il titanismo sfocia nel suicidio, visto come atto di sfida estrema verso il destino. Atteggiamento opposto ma complementare al titanismo è il vittimismo, cioè la tendenza a sentirsi schiacciati da forze superiori (destino, società, natura).
4. La tendenza all'evasione e l'amore per l'eccezionale
E' la predilezione per tutto ciò che, essendo fuori del comune (meraviglioso, atipico, irregolare, lontano, misterioso, magico, fiabesco, primitivo, notturno, lugubre, spettrale), può generare sensazioni diverse e sconosciute. Ecco quindi l'evasione dal presente e dall'abituale, verso mondi remoti nel tempo e nello spazio. L'evasione più significativa è quella che avviene nei mondi del sogno e dell'arte. Il viandante romantico si contrappone al viaggiatore cosmopolitico e pratico-interessato degli illuministi, curioso dei costumi stranieri e delle istituzioni politiche. Il viandante, invece, è colui che erra, che vaga inquieto verso qualcosa di irraggiungibile ed illusorio.
Altro tema caratteristico è quello dell'armonia perduta, risalente ad una situazione primitiva fatta di spontaneità e di simbiosi con la natura, da cui la civiltà e l'intelletto hanno sradicato l'uomo (cfr. Rousseau). Questo tema implica uno schema triadico che anticipa quello della dialettica hegeliana: armonia iniziale - scissione intermedia - ricostruzione di un'armonia futura basata sul recupero del passato. La concezione della storia che ne deriva è di tipo regressivo e progressivo al tempo stesso: regressivo per la mitizzazione del "passato felice"; progressivo perché il poeta, diversamente dagli altri uomini, non vive avvolto nell'oblio dell'autentico e dell'originario, ma veglia in attesa del recupero dell'originario e del ritorno del divino.
5. La nozione di uomo come "spirito"
Lo "spirito" è l'uomo, inteso come
- attività infinita ed inesauribile che si autocrea liberamente, superando continuamente i propri ostacoli;
- soggetto contrapposto ad un oggetto, cioè la natura, che ha senso in funzione del soggetto stesso, cioè dell'uomo, ragion d'essere di ogni cosa e dunque Dio (cfr. Fichte, che per primo fissa l'equazione Io = Dio). L'uomo è infinità e creatività.
6. Nuova concezione della storia
Mentre per l'Illuminismo il soggetto della storia è l'uomo, per il Romanticismo è la provvidenza. A "tirare le fila" non è l'insieme degli individui sociali, ma una forza extra-umana e sovra-individuale, concepita come forza immanente o trascendente.
Se è così, la prospettiva romantica appare storicistica, mentre quella illuministica anti-storicistica: infatti, gli illuministi giudicano la storia, rifiutandone alcuni momenti, mentre i romantici vedono nella storia un processo globalmente positivo, in cui non vi è nulla di irrazionale o di inutile ed in cui il regresso è solo apparente. Non si può intentare un processo a Dio, ogni momento della storia è un anello necessario della catena, con una propria individualità ed autonomia che non è opportuno comparare col presente ed i suoi valori.
Lo storicismo romantico costituisce una forma di tradizionalismo e di giustificazionismo, che santifica il passato.
L'Illuminismo guarda il mondo storico in maniera umanistica e problematicistica, critica e riformatrice, scorgendo errori, pregiudizi, violenze. Il Romanticismo guarda la storia in maniera provvidenzialistica e necessitaristica, assolutizzando le istituzioni basilari del passato: famiglia, ceti sociali, monarchia, Stato, Chiesa.
8. La filosofia politica
Nella primissima fase il Romanticismo politico è filorivoluzionario, individualista e antistatalista. Uno dei motivi ricorrenti è la lotta dell'individuo contro la società (cfr. Byron).
Nella seconda fase, più propriamente romantica, il Romanticismo politico è sempre più statalista e conservatore, perché l'individuo è tale solo all'interno di una comunità storica e sovrapersonale ed in virtù dell'appartenenza alle istituzioni tradizionali come la famiglia, lo stato; senza contare che senza Dio o la Chiesa vi è solo anarchia e caos. Dunque, culto dell'autorità. Tuttavia, se da un lato in Europa "romantico" è sinonimo di "conservatore", dall'altro è equivalente di "liberale" e "patriota" (bifrontismo politico del Romanticismo).
Uno dei concetti più originali dello storicismo romantico è quello di "nazione". Nel Settecento l'idea di "popolo" equivale all'insieme degli individui che scelgono per libera convenzione o contratto di vivere insieme, nell'Ottocento l'idea di "nazione" equivale all'insieme degli individui che devono vivere insieme a motivo di elementi come razza, lingua, costume, religione. Gli organismi sociali non sono fatti dalle volontà dei singoli ma da una misteriosa "anima popolare", dallo "spirito del popolo", dal "genio della nazione".
L'universalismo degli enciclopedisti, giudicato antistorico ed astratto, è sostituito dal richiamo alla pluralità irriducibile delle nazioni e delle espressioni culturali dei popoli. Al cosmopolitismo dell'illuminismo e di Kant, che proclamava diritti naturali comuni e vagheggiava pacifici organismi internazionali, viene contrapposto il nazionalismo, con la politica specifica dei singoli Stati.
All'universalismo religioso degli illuministi, che parla di una religione universale e razionale, si contrappone la molteplicità delle religioni positive.
Al cosmopolitismo linguistico dell'Illuminismo ed al suo progetto di una lingua universale, si contrappone il nazionalismo linguistico.
Tuttavia, anche gli illuministi sono consapevoli della molteplicità e specificità delle culture umane. Solo che ad essi premeva andare oltre, mentre ai romantici interessava conservarle in nome della tradizione storica.
In altri stati (Italia, per esempio), il concetto di nazione, anziché condurre allo statalismo organicistico e nazionalistico si salda a quello di libertà, sia dallo straniero (indipendenza), sia dal potere assoluto (libertà nello stato).
In Mazzini, per esempio, uno dei principali esponenti della cultura romantica italiana, il culto della nazione si sposa con
- liberalismo = salvaguardia dei diritti individuali
- democrazia = teoria del popolo come detentore della sovranità
- patriottismo = battaglia per far coincidere lo stato con la nazione
- principio dell'autodeterminazione nazionale = ogni nazione deve essere padrona del proprio destino politico.
Riassumendo, le tre coordinate di fondo della filosofia sociale romantica tedesca ed europea sono: individualismo antistatalistico, statalismo organicistico e nazionalista, nazionalismo liberal-democratico e patriottico.
9. Nuova concezione della natura
Si assiste ad un mutamento di rotta rispetto alla rivoluzione scientifica: la natura, da ordine oggettivo fatto di materia in movimento secondo rigide leggi meccaniche, viene vista in modo