La Politica Economica: macroeconomia, fiscale e monetaria
Documento di Università sulla Politica Economica. Il Pdf, utile per lo studio dell'Economia a livello universitario, analizza la macroeconomia, la politica fiscale (espansiva e restrittiva), la politica monetaria e la politica dei redditi.
Mostra di più12 pagine
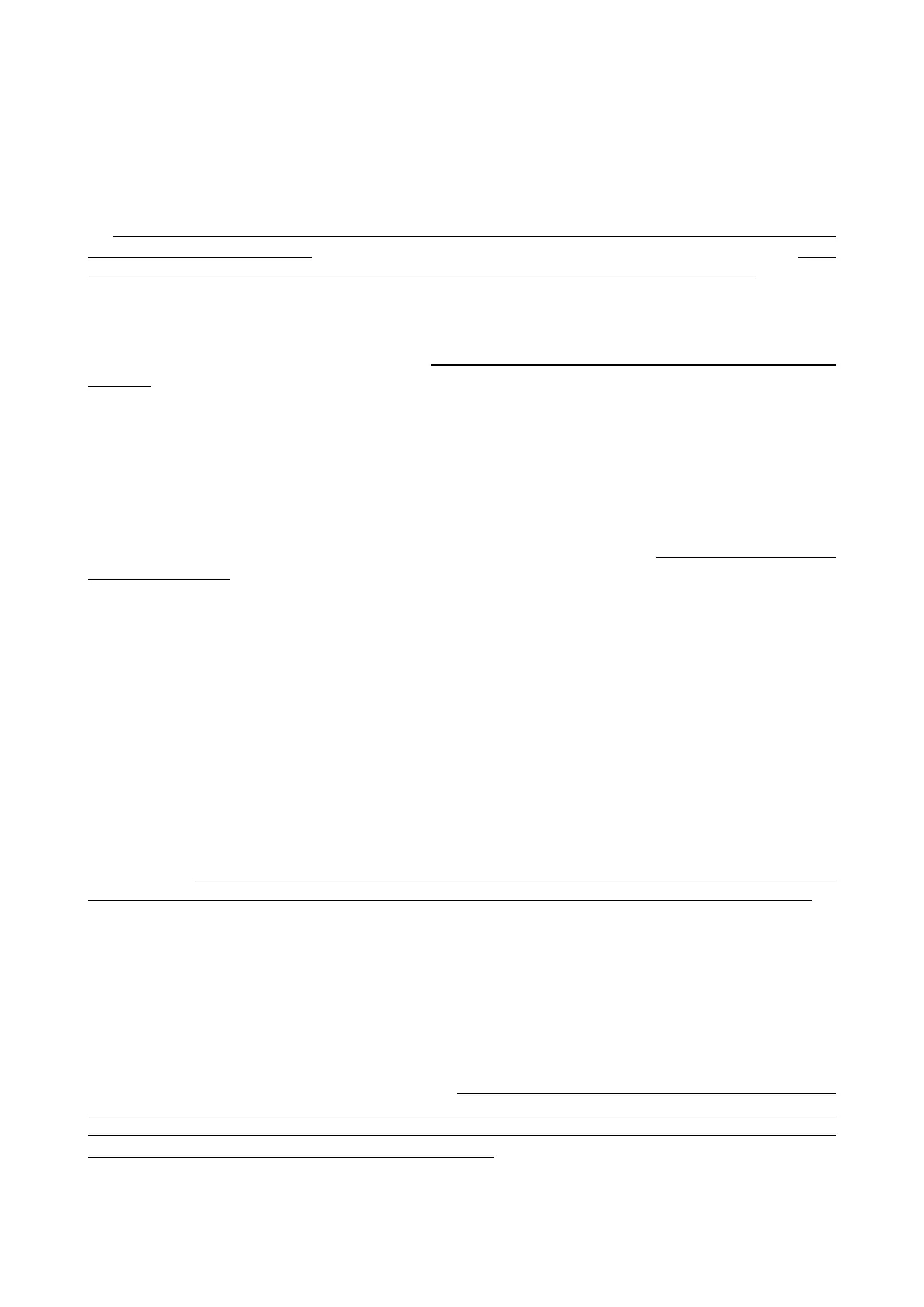
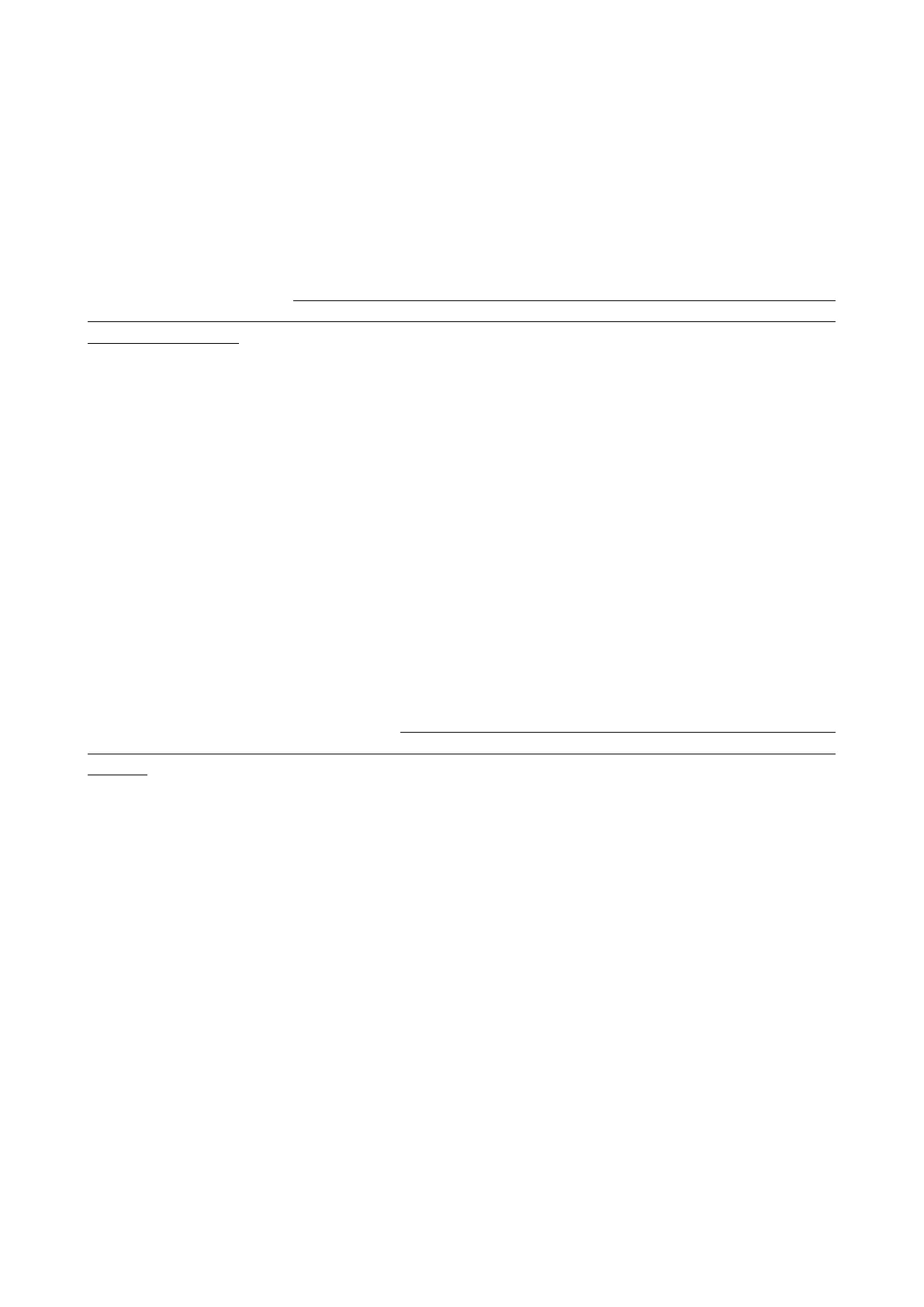
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
I caratteri della macroeconomia
LA POLITICA ECONOMICA La macroeconomia è quella parte della scienza economica che studia il funzionamento del sistema economico nella sua globalità. Per l'analisi macroeconomica vengono presi in considerazione non i comportamenti dei singoli soggetti economici e delle variabili che li influenzano, bensì le grandezze aggregate (i consumi complessivi delle famiglie, il reddito nazionale, il livello di occupazione, lo sviluppo economico del Paese, ecc.) e le relazioni che intercorrono tra le stesse. L'aggregazione è lo strumento fondamentale utilizzato dall'analisi macroeconomica. Nella macroeconomia l'aggregazione consiste nel raggruppare i dati all'interno di categorie più ampie possibili: ad esempio, la categoria della produzione nazionale si ottiene combinando i prodotti di tute le molteplici tipologie di attività produttive, dalla ceramica alla siderurgia, ai servizi, alla produzione di automobili, a quella di souvenir ecc., la categoria aggregata del lavoro è il risultato di tutti i lavoratori del sistema economico, dagli insegnanti ai carpentieri, ai medici, agli idraulici eccetera.
Gli aggregati economici non sono percepibili direttamente nella realtà, ma sono elaborati da istituti specializzati per mezzo di procedimenti e tecniche di tipo statistico. Ognuno di noi è in grado di capire quanto sia aumentato il prezzo della benzina, ma non riesce a valutare l'aumento del livello generale dei prezzi che invece viene calcolato da appositi enti statistici, in Italia tale compito è svolto dall'ISTAT. Lo studio degli aggregati economici consente agli economisti di elaborare modelli utili per il studio e la comprensione del sistema economico.
L'obiettivo dell'analisi macroeconomica
A che cosa serve l'analisi macroeconomica, come può essere d'aiuto nella soluzione del problema economico della scarsità? Possiamo affermare che l'approccio macroeconomico per la comprensione del sistema economico è relativamente recente, e si deve soprattutto all'economista John Maynard Keynes. Questo economista, come sappiamo, criticò l'impostazione dell'economia classica fino ad allora dominante, proponendo una concezione alternativa. Secondo la teoria classica, il sistema economico funzionava benissimo e raggiungeva i livelli di produzione più elevati possibile alla sola condizione che lo Stato si disinteressasse dell'economia e lasciasse che le forze automatiche del mercato concorrenziale perfetto esprimessero i loro benefici effetti. In questo modo il sistema avrebbe naturalmente raggiunto il suo equilibrio di piena occupazione e non vi sarebbero state crisi economiche. Il fondamento dell'analisi economica da parte della scuola classica era di tipo microeconomico e non sussisteva alcuna esigenza di esaminare il sistema nel suo complesso. Il ruolo dello Stato doveva essere, per così dire, istituzionale, relegato alla gestione dei servizi pubblici essenziali (come la giustizia, la difesa militare e l'ordine pubblico) e alla tutela del mercato concorrenziale dalle insidie provenienti dal formarsi di monopoli.
La necessaria presenza dello Stato nell'economia
Keynes, anche alla luce della grande crisi del 1929 che smentiva drammaticamente i postulati classici, sostenne invece che il sistema economico poteva svilupparsi in modo armonico soltanto grazie all'aiuto delle autorità statali, che in questo modo acquisivano un ruolo di primo piano nello svolgimento dell'attività economica. Lo Stato doveva affiancare gli operatori economici privati coordinandone le azioni e orientandone le scelte, allo scopo di sostenere l'occupazione, favorire gli investimenti, incentivare il ricorso al credito, incoraggiare i consumi eccetera, il tutto nell'interesse generale dell'economia e della società. Per fare questo occorreva disporre di una 1visione di insieme dei fenomeni economici, una visione appunto macroeconomica, poiché l'intervento statale non era diretto ad aiutare questo o quel soggetto determinato, ma il sistema nel suo complesso. Era quindi indispensabile disporre di un'analisi delle grandezze economiche globali aggregate.
La politica economica
Si può dire dunque, che la macroeconomia sia nata come strumento indispensabile per l'attuazione della politica economica. Per politica economica si intende il complesso degli interventri delle autorità pubbliche effettuati sul sistema economico per adeguarne il funzionamento in vista degli obiettivi generali di carattere economico e sociale. Dalla definizione fornita emerge che la politica economica si compone di due momenti distinti ugualmente importanti:
- la definizione degli obiettivi da perseguire: ad esempio la riduzione della disoccupazione, sviluppo di certi settori industriali, difesa del potere d'acquisto della moneta eccetera;
- la determinazione delle strategie per realizzarli: ad esempio la riduzione dell'imposizione fiscale sui cittadini, la diminuzione del tasso di interesse sui prestiti di denaro, eccetera.
Rispetto all'analisi microeconomica, l'approccio macroeconomico sposta il baricentro dell'indagine economica: coinvolge soggetti pubblici e non privati, si concentra su problematiche generali anziché particolari, utilizza modelli ricavati dall'aggregazione dei fenomeni economici, è orientata al perseguimento di obiettivi universali di natura economico - sociale, quali l'equilibrio generale del sistema, la piena occupazione, la stabilità della moneta, l'equa distribuzione della ricchezza.
La contabilità nazionale
La macroeconomia studia le grandezze aggregate e, quindi, deve poter disporre di dati di insieme dei vari fenomeni economici riguardanti il sistema. Di tale grandezze si occupa la contabilità nazionale. La contabilità nazionale è l'insieme dei conti mediante i quali si descrive quantitativamente la situazione del sistema economico in un determinato arco di tempo, solitamente un anno. Essa mira ad elaborare un quadro di sintesi del sistema, indispensabile per gli interventi di politica economica.
Il governo dell'economia
Le decisioni su obiettivi e strategie di politica economica spettano, all'interno di ciascuno Stato, all'autorità pubblica (principalmente al Governo e agli enti territoriali quali Regioni, Province e comuni) e possono essere variamente concordate con altri soggetti, ad esempio con i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro (cosiddette parti sociali); in quest'ultimo caso si parla di politica della concertazione. E a questi soggetti dunque che, nel contesto macroeconomico, si pone il problema delle scelte.
Struttura istituzionale dello Stato
Lo Stato come apparato è un ente sovrano. Ciò significa che i suoi poteri non derivano da nessun'altra autorità, sono per così dire originari, e che non sussistono altri poteri al di sopra o al di fuori di esso. La sovranità dello Stato consente ai suoi organi di imporre ai cittadini certi comportamenti e di costringere con la forza coloro che non li osservano spontaneamente. Essa si esprime tradizionalmente attraverso tre diversi poteri: 2
- legislativo: potere di dettare le leggi che spetta al Parlamento;
- esecutivo: potere di dare applicazione pratica alle leggi che spetta al Governo;
- giurisdizionale: potere di amministrare la giustizia che spetta alla Magistratura.
I principi dello Stato moderno
Lo Stato moderno si ispira ai principi liberale e democratico, secondo i quali la sovranità, o meglio la legittimazione del potere di imporre le regole, di eseguirle e di farle rispettare appartiene al popolo e non al sovrano. Il popolo, tuttavia, esercita il suo potere tramite rappresentanti nominati attraverso periodiche elezioni, secondo il metodo democratico della maggioranza. I rappresentanti del popolo vanno a formare gli organi previsti dalla Costituzione, ed è tra tali organi che i singoli poteri della sovranità vengono attentamente ripartiti, secondo il principio della separazione dei poteri.
Le esigenze dello Stato sociale
Lo Stato ha:
- fini generali (essenziali), propri di qualunque comunità in ogni momento storico perché legati alla sua sopravvivenza, come la difesa dalle aggressioni, l'ordine pubblico e la giustizia;
- fini specifici, dettati dalla particolare contingenza storica, economica e sociale e dalla sensibilità verso certe questioni piuttosto che altre.
Uno Stato sociale come il nostro, ha tra i suoi fini quello di garantire condizioni di vita adeguate a tutti i cittadini, anche ai meno abbienti. Di conseguenza è impegnato a procurare lavoro a chi non lo ha, ad erogare prestazioni sanitarie gratuite a chi non può pagarle, a fornire libri scolastici ai figli delle famiglie povere, eccetera. Ovviamente, non sempre si è liberi di scegliere, dovendo talvolta dedicare ogni risorsa al superamento di situazioni particolari, si pensi alla necessità di ridurre il pesante debito pubblico o di far fronte alle conseguenze di catastrofi ambientali.
Il settore non profit
Nell'espletamento dei suoi obiettivi sociali, lo Stato fa sempre più ricorso al cosiddetto settore non profit. Il settore non profit è costituito dall'insieme delle organizzazioni private, associazioni, enti morali, fondazioni, imprese cooperative, organizzazioni di volontariato, che perseguono finalità di utilità sociale e collettiva dedicandosi alla produzione di beni e di servizi in settori come l'ambiente, il tempo libero la cultura, l'educazione, la salute, la ricerca, la difesa dei diritti civili, eccetera.
I principi costituzionali della Sicurezza sociale
Lo Stato italiano trova nei valori della solidarietà sociale, della tutela dei deboli e dei bisognosi, uno dei suoi presupposti fondamentali. La stessa Costituzione prevede molti articoli dedicati alla sicurezza sociale e allo Stato sociale. Secondo quanto sancito dall'art. 38 della Costituzione: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera". 3