I cambiamenti del II-I secolo a.C., i Gracchi e l'inizio delle guerre civili
Slide sui cambiamenti del II-I secolo a.C., i Gracchi e l'inizio delle guerre civili. Il Pdf, pensato per la scuola superiore e la materia Storia, riassume gli eventi chiave della Roma repubblicana, inclusi gli scontri tra Silla e Mario, fornendo una comprensione chiara e concisa di questo periodo storico.
Mostra di più13 pagine
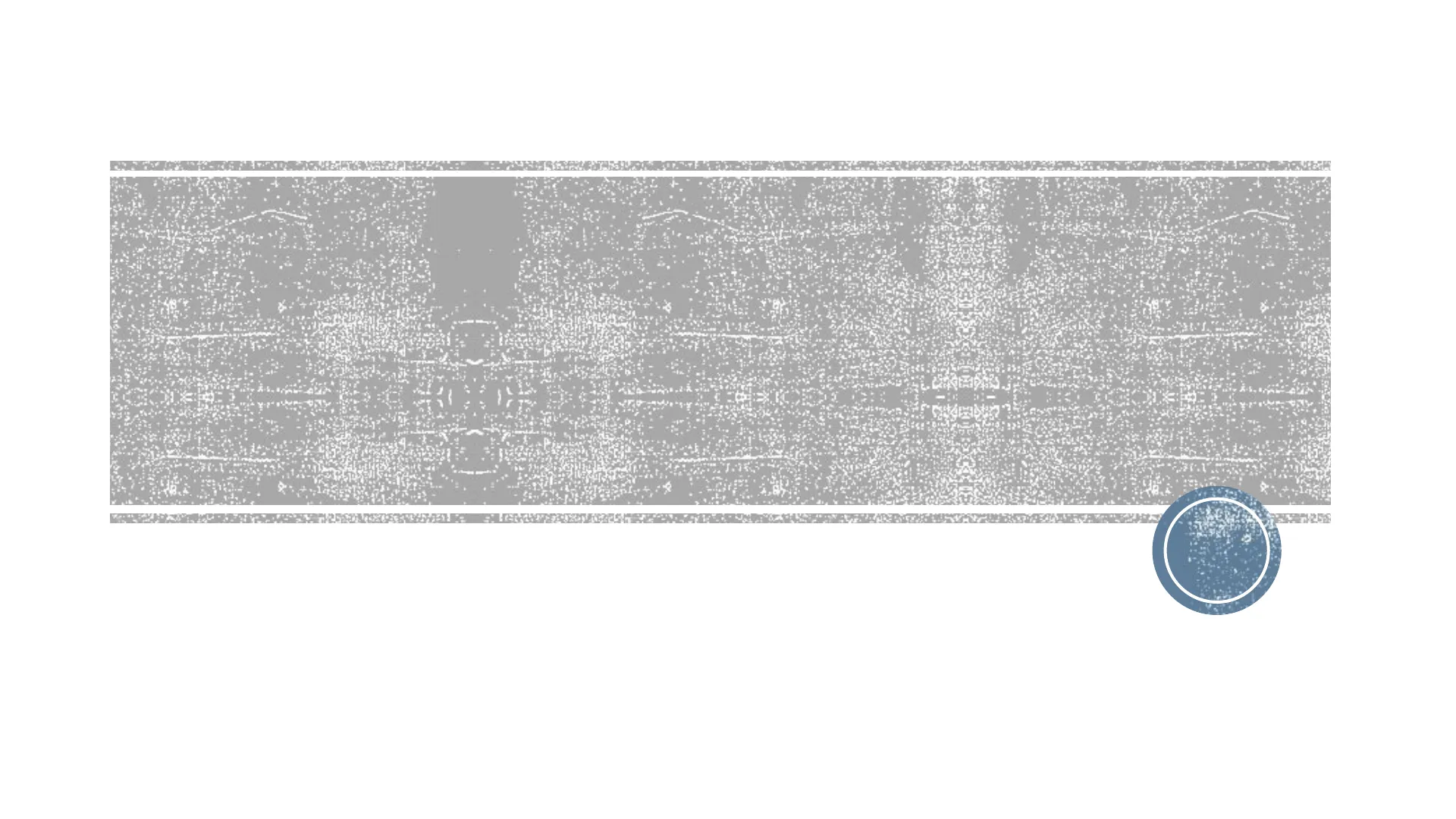
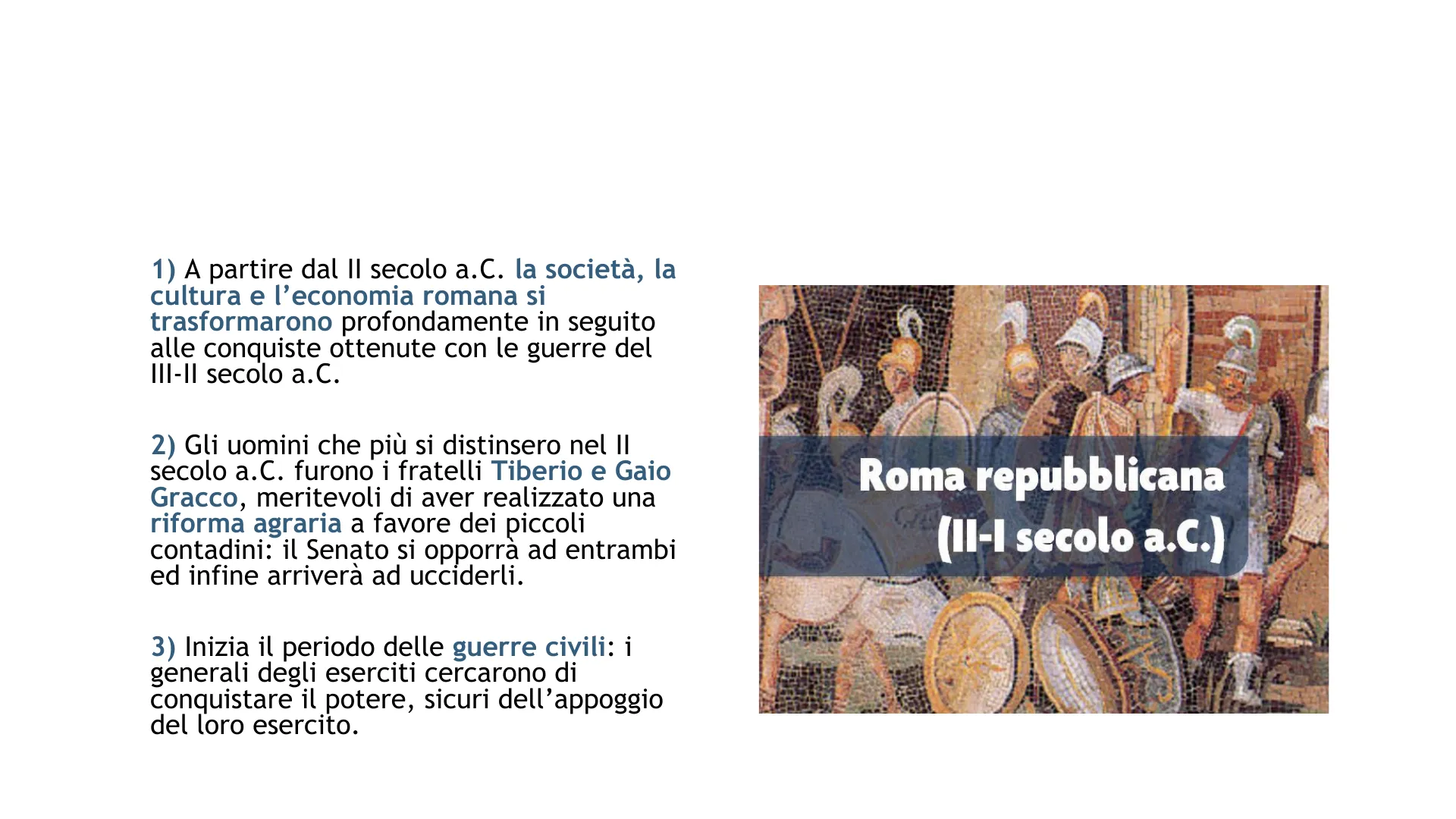
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
I cambiamenti del II-I secolo a.C.
Roma repubblicanaAVVENIMENTI PRINCIPALI DELLA ROMA DEL II-I SECOLO A.C. I nobili quicebbero dovuto pagare le tasse sulla proprietà teriera
- A partire dal II secolo a.C. la società, la cultura e l'economia romana si trasformarono profondamente in seguito alle conquiste ottenute con le guerre del III-II secolo a.C.
- Gli uomini che più si distinsero nel II secolo a.C. furono i fratelli Tiberio e Gaio Gracco, meritevoli di aver realizzato una riforma agraria a favore dei piccoli contadini. It Senato si opporrà ad entrambi ed infine arriverà ad ucciderli.
- Inizia il periodo delle guerre civili: i generali degli eserciti cercarono di conquistare il potere, sicuri dell'appoggio del loro esercito.
Le trasformazioni della società romana e la crisi della piccola proprietà terriera
Roma repubblicana (II-I secolo a.C.)
- A metà del II secolo a.C. Roma controllava quasi tutto il Mediterraneo: le ricchezze provenienti dalle conquiste venivano gestite da un nuovo ceto sociale, i cavalieri (equites). I cavalieri non erano ricchi di nascita, poiché non avevano nobili origini, ma appartenevano a famiglie che si erano arricchite di recente. Il ceto equestre da un lato costituiva il motore dello sviluppo economico, dall'altro era escluso dalle cariche pubbliche, monopolizzate dalla nobilitas, in quanto non aveva accesso ne al consolato ne al senato. Pertanto, nonostante la rilevanza sociale dei cavalieri, a guidare la classe dirigente era ancora la nobilitas, la "nobiltà", composta da patrizi di nascita e da plebei arricchiti. Ad essa appartenevano le famiglie i cui membri avevano raggiunto le più alte magistrature, in particolare il consolato, indipendentemente dal fatto che fossero di origine patrizia o plebea. Era un gruppo chiuso, deciso a difendere i propri privilegi.
- La piccola proprietà terriera entrò in crisi: ciò vuol dire che i contadini, che possedevano piccole quantità di terra, si ritrovarono in difficoltà economiche per vari motivi. Innanzitutto essi venivano mandati a combattere per anni in guerra, così erano costretti a lasciare le loro terre, che nessuno poteva più coltivare e che venivano quasi del tutto abbandonate; inoltre, quando Roma conquistava, per mezzo delle guerre, nuove terre, le assegnava in proprietà non ai contadini bisognosi, ma ai senatori, tra l'altro già ricchi per origine. Le terre assegnate ai senatori erano di grandi dimensioni e per questo venivano chiamate latifondi.
- La chiamata in guerra e lo sviluppo dei latifondi, assegnati unicamente ai senatori, fece precipitare in crisi economica i contadini, che scelsero di abbandonare le campagne, vendendole ai latifondisti, per andare a vivere in città, nella speranza di un futuro migliore. Qui i contadini costituirono la nuova classe sociale della plebe urbana.
La carriera politica e il cursus honorum
nobiltà La carriera politica era accessibile a pochi individui, in genere appartenenti alla nobilitas. Occorreva infatti possedere una proprietà terriera, avere combattuto con ruoli di comando, godere di amicizie altolocate, disporre di numerosi clienti e di denaro per finanziare campagne elettorali sempre più dispendiose. Questi requisiti erano essenziali per scalare il cursus honorum, la "successione delle cariche", un sistema istituito nel 180 a.C., che regolava il passaggio da una magistratura all'altra, fino al consolato, stabilendo precisi vincoli di età e imponendo intervalli di tempo fra una carica e l'altra. La finalità del cursus honorum era quella di controllare la formazione della classe dirigente, rendendo difficile e onerosa la carriera politica a chi non avesse determinati requisiti. L'ordine delle magistrature stabilito dal cursus honorum era in senso di importanza crescente: questura, tribunato (per i plebei), edilità, pretura, consolato, censura. Il numero dei posti disponibili diminuiva man mano che si salivano i gradini nella gerarchia delle cariche. Le magistrature più ambite erano quelle cum imperio (cioè con potere di comando), che comportavano il comando militare, la facoltà di convocare i comizi e di consultare il senato, il potere della polizia, la facoltà di emanare diritti. Nella tarda repubblica, per candidarsi alla questura occorreva avere almeno 30 anni e 10 anni di servizio militare alle spalle; per diventare edile occorrevano 36 anni; 39 per la pretura; 42 per il consolato. La carica non era ripetibile, almeno negli anni immediatamente successivi a quello in cui la si era ricoperta.
La figura dell'homo novus
Entrare a far parte della classe dirigente era molto difficile, anche se non impossibile. Ci si poteva riuscire facendosi eleggere a una magistratura minore, come l'edilità o la questura, che dava accesso al senato; oppure attraverso matrimoni ben combinati, stretti per sancire alleanze politiche e per fare carriera. Tuttavia, per contare davvero, per acquisire il rango nobiliare, rimaneva necessario appartenere a una famiglia che avesse tra i suoi membri qualche console o magistrato superiore. Possiamo dunque distinguere fra una nobiltà in senso stretto, composta dalle famiglie di rango consolare, e un ceto senatorio un poco più ampio, perché non tutte le famiglie senatorie di origine plebea vantavano un console fra gli antenati. I romani chiamavano homo novus (o "uomo nuovo") chi faceva carriera in politica senza avere un alto magistrato, in particolare un console, tra i parenti in vita o tra i propri avi: "uomo nuovo" era in genere colui che arrivava, primo della sua famiglia, al consolato. FRIG HTEL
Una nuova cultura: tradizionalisti e innovatori del mos maiorum
Fino al III secolo a.C. la società romana era ancora improntata a uno stile di vita e a una mentalità tipici di una civiltà rurale e tradizionalista, condensati nel cosiddetto mos maiorum, il "costume degli antenati": l'insieme dei valori ereditati dalla tradizione e trasmessi ai giovani nell'educazione come modelli di comportamento. I valori del mos maiorum erano: la virtù civile e militare; la devozione agli dèi, alla famiglia, allo stato; la lealtà; la saggezza; la fermezza; la parsimonia. Tali valori si confermarono nei secoli delle conquiste: le vittorie e la crescente potenza di Roma parvero premiare un ideale di cittadino attento agli interessi collettivi più che a quelli personali e uno stile di vita fondato sull'operosità (economica, militare, politica) a vantaggio del bene comune e della res publica, termine che in latino si traduce letteralmente con "cosa comune", "cosa pubblica", e che per estensione acquisisce il significato di "Stato". In generale la cultura greca penetrò progressivamente in quella romana fin dalle origini e poi con forza crescente a partire dal III secolo a.C., dopo la vittoriosa guerra contro Taranto. È a quest'epoca che si deve far risalire la nascita della letteratura latina, che prende a modello quella ellenistica in lingua greca. Lo stesso alfabeto latino, in cui pure sono presenti molti elementi etruschi, si stabilizzò sotto l'influsso della città campana di Cuma, modellandosi sul greco occidentale delle colonie. Inoltre con le conquiste del II secolo a.C., insieme al ricco bottino di guerra e alle opere d'arte, vennero condotti a Roma numerosi intellettuali greci, che diffusero nell'Urbe il sapere greco. Molti di questi, giunti come prigionieri, venivano liberati in riconoscimento delle loro capacità e, come liberti, svolgevano spesso la funzione di precettori dei rampolli delle famiglie senatorie. La produzione e la diffusione della cultura si concentrarono dunque intorno alle personalità politiche e militari emergenti, che diventarono i patroni degli intellettuali greci. Erano poi molti i romani che per ragioni commerciali e politiche avevano imparato il greco e potevano leggere in originale le opere degli storici e dei poeti greci.
Tradizionalisti e innovatori del mos maiorum
La diffusione della cultura greca a Roma e l'attrazione che essa suscitava su parte dell'aristocrazia generarono una forte opposizione in quella parte della classe dirigente che si proponeva come custode dei valori tradizionali del mos maiorum. La cultura greca cominciava a cambiare i costumi romani e i rapporti familiari e la sobrietà arcaica romana veniva sostituita dal lusso e dalla raffinatezza ellenistica. Agli occhi dei tradizionalisti, come Catone il Censore, la cultura greca indirizzava la società e la mentalità romane verso un individualismo e un cosmopolitismo incompatibili con i valori civili tipici di Roma. Pertanto, nel corso del II secolo a.C., si accese una battaglia politica tra "innovatori" e "conservatori". Tra gli innovatori che realizzarono una sintesi fra i valori romani e quelli greci ci furono i membri del Circolo degli Scipioni, formatosi alla metà del II secolo a.C., che riuniva uomini di cultura ed esponenti della nobiltà romana filoellena e intellettuali greci, sotto il patrocinio di Scipione Emiliano. Infine esemplare fu l'opera dello storico greco Polibio (206-124 a.C.), portato come ostaggio a Roma nel 166 a.C. (in seguito alla battaglia di Pidna del 168 a.C. che sancì la definitiva vittoria romana nelle guerre macedoniche), il quale scrisse le Storie, con l'obiettivo di spiegare come Roma fosse divenuta, nel giro di mezzo secolo, padrona del Mediterraneo. POLYBIOU HISTORIAI Polybius, Ludwig August Dindorf, Theodor Büttner-Wobst Digitted by Google
Le conseguenze dei cambiamenti
QUALI FURONO LE CONSEGUENZE DI QUESTI CAMBIAMENTI?
I tentativi di riforma dei Gracchi
- Nel 133 a.C. il tribuno della plebe Tiberio Gracco propose una riforma agraria, cioè una riforma relativa alle terre, per risolvere la crisi della piccola proprietà contadina. La legge fissò un limite alla quantità di terra che un cittadino poteva possedere: la terra in eccesso doveva essere ridistribuita. I senatori si opposero alla riforma e uccisero Tiberio Gracco.
- Nel 123 a.C. il fratello di Tiberio, Gaio Gracco, divenne tribuno della plebe. Egli riprese la riforma agraria e propose altre leggi a vantaggio di plebe e cavalieri.
- Tuttavia Gaio propose anche di concedere la cittadinanza romana ai popoli conquistati in precedenza, i quali erano stati trasformati da Roma in alleati latini. Essi erano privi dei diritti politici di cui invece godevano i cittadini romani.
- Il Senato decise di uccidere Gaio Gracco, perché concedere la cittadinanza romana ai latini avrebbe comportato una eccessiva perdita di potere per Roma. a alamı a alamy stock photo AN6AWH www.alamy.com