L'equilibrio dei fluidi: pressione, legge di Stevino e pressione atmosferica
Documento di Fisica sull'equilibrio dei fluidi, la pressione e la legge di Stevino. Il Pdf, pensato per la scuola superiore, esplora concetti come la pressione idrostatica e atmosferica, fornendo esempi e formule per un apprendimento chiaro e strutturato.
Mostra di più23 pagine
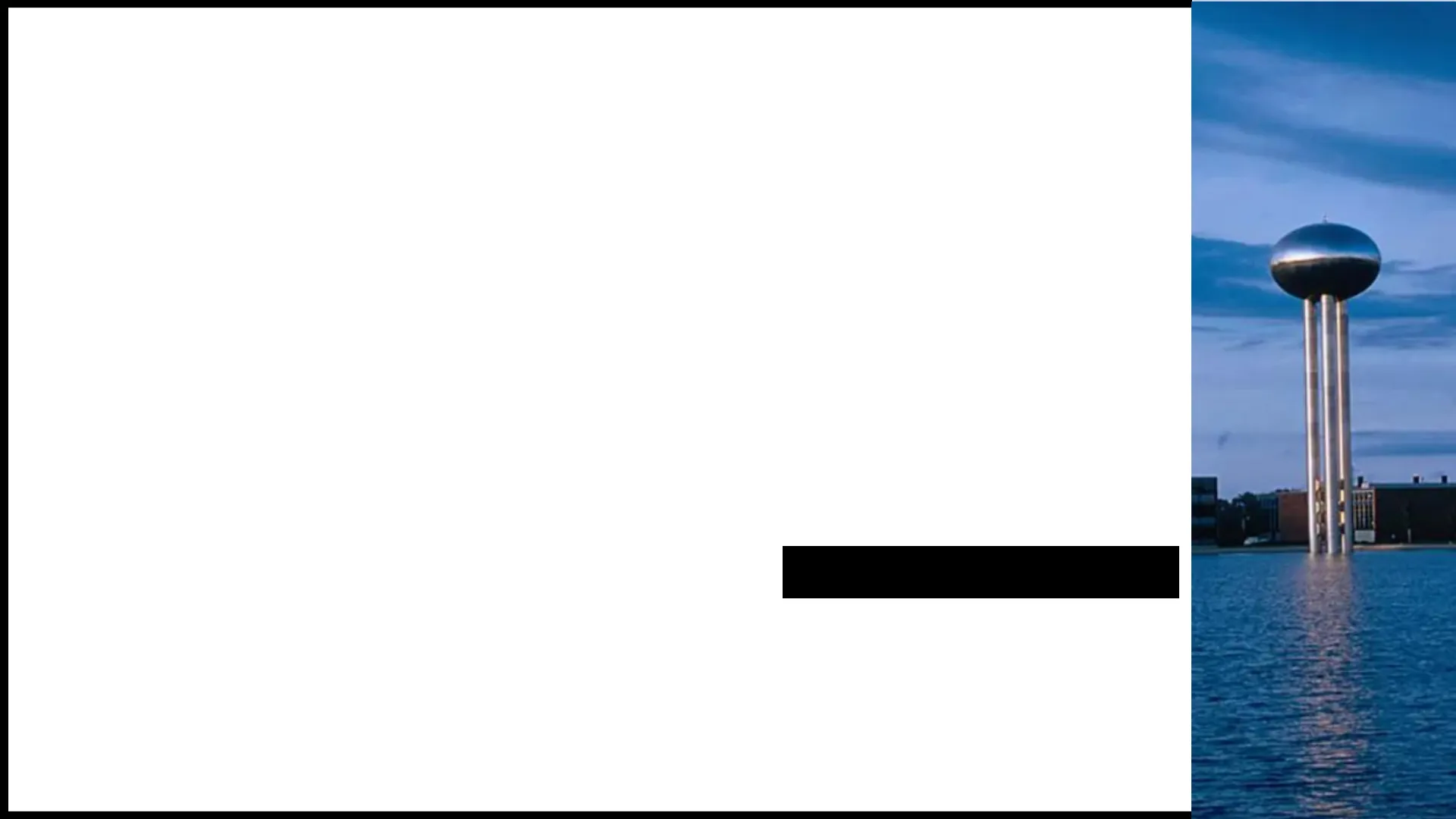
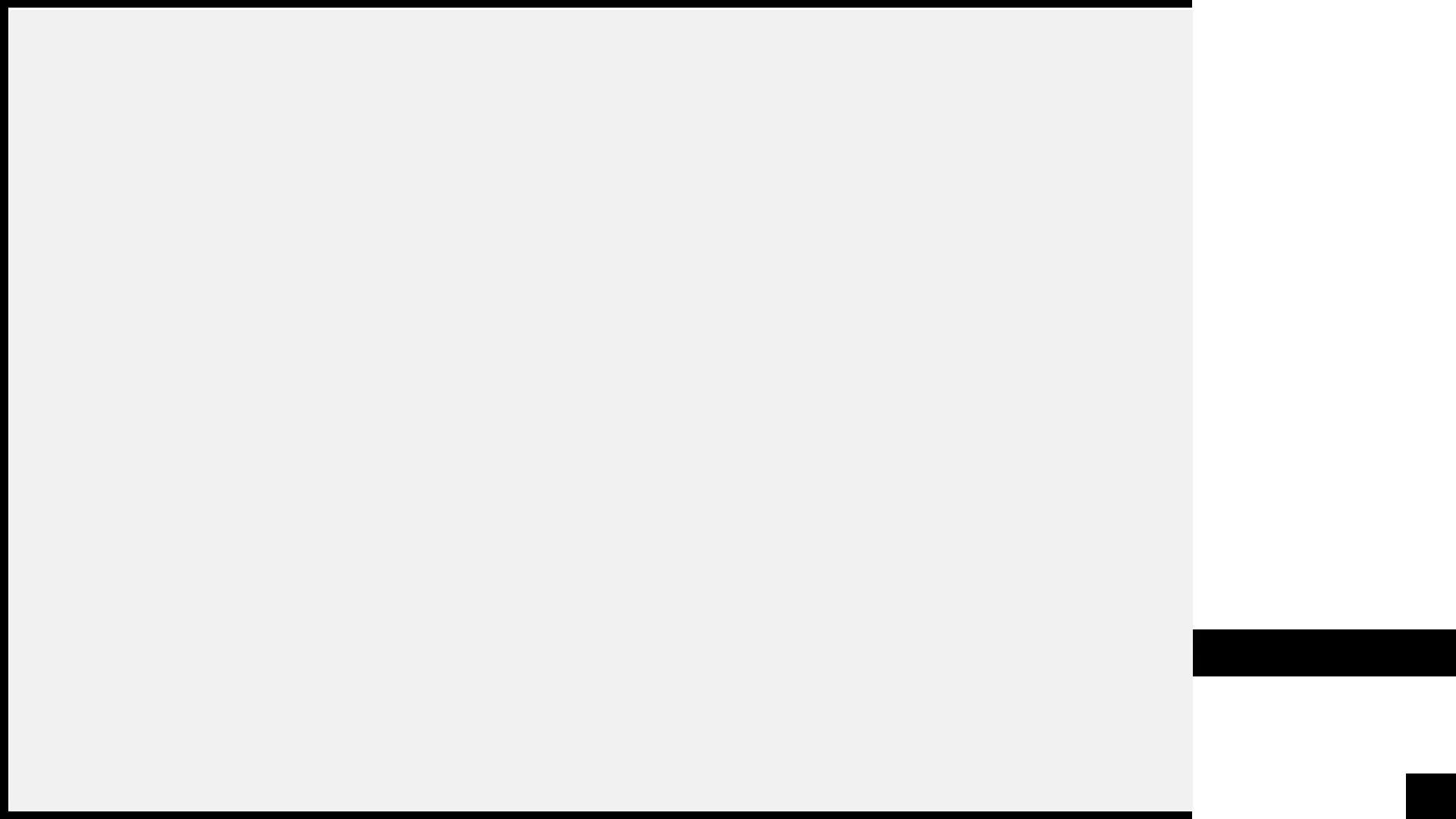
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
MICHELE RELLA
MECCANICA
Statica
L'EQUILIBRIO DEI FLUIDI
La pressione
Immaginiamo di appoggiarci a un muro con le spalle; ripetiamo l'esperimento, appoggiandoci con la stessa forza allo stesso muro, ma con il palmo di una mano; infine, ripetiamo il tutto appoggiandoci con la punta di un dito. Sicuramente, l'esperienza meno gradevole (e più dolorosa) è l'ultima. Come mai? La forza usata nei tre esperimenti è la stessa, ma cambia l'area della superficie di contatto tra noi e il muro: nel primo caso è la più grande; quando usiamo il palmo della mano è l'area di valore intermedio; quando usiamo la punta di un dito, impieghiamo l'area minore. C'è, dunque, una variabile (la forza è costante), che rende l'esperienza più o meno dolorosa: più è piccola l'area di contatto più il dolore è intenso, che è, comunque, soggettivo. Tradotto in grandezze fisiche, cioè grandezze oggettive, la grandezza, che causa il dolore, è la pressione, data dal rapporto tra l'intensità della forza applicata e l'area della superficie di contatto: p = F / A Siccome la pressione è data dal rapporto tra due grandezze scalari (il modulo della forza e l'area), anch'essa è una grandezza scalare. L'unità di misura della pressione nel Sistema Internazionale è il pascal [Pa]. Esso è dato dal rapporto tra un newton e un metro quadratico: 1 [Pa] = 1 [N] / 1 [m2]
Esempio di pressione
Il filetto della lama di un coltello ha un'area di 100x0,05 mm2 . Se una persona, per tagliare della carne, usa quel coltello e imprime una forza di 50,0 N, qual è la pressione esercitata per tagliarla? F A Calcoliamo la pressione con la formula p = F / A p = 50,0 N / 5 mm2 -> 50,0 N / 5 . 10-6 m2 = 1 . 10 . 106 Pa = 1 · 107 Pa NB: per tagliare più facilmente, occorre esercitare più pressione. Dato che questa è direttamente proporzionale alla forza e inversamente proporzionale all'area del filetto della lama del coltello, conviene, in generale, diminuire quest'ultima (affilando il filetto) e non esercitare più forza.
Il principio di Pascal
Blaise Pascal fu uno dei primi scienziati a occuparsi dello studio dell'equilibrio dei fluidi. Egli fece, a tal proposito, un esperimento, assimilabile a quello illustrato di seguito. Prendiamo un contenitore e riempiamolo d'acqua attraverso un foro. In un altro punto dello stesso contenitore, pratichiamo un altro foro e lo chiudiamo con un tappo. Attraverso il primo foro, introduciamo un pistone a tenuta stagna.
Pressione sul pistone
A questo punto, facciamo una forza F sul pistone di area A, generando una pressione p = F / A; vediamo che salta il tappo dall'altra parte. Potremmo dedurre che sotto il tappo ci sia anche lì una pressione, proprio uguale a quella che abbiamo generato sul pistone. Il principio di Pascal dice, dunque, che se si esercita una pressione su un punto all'esterno di un fluido, essa si propaga in tutti gli altri suoi punti con la stessa intensità.
Il martinetto idraulico
Il martinetto idraulico è una macchina, che funziona, sfruttando il principio di Pascal. Essa è costituita da due cilindri chiusi ciascuno da un proprio pistone e collegati tra loro da un tubo A2 F1 F2 A1 p p Il primo cilindro, quello su cui agisce l'operatore, è molto più stretto del secondo, dove viene ollocato un peso da sostenere. I cilindri e il tubo di comunicazione sono riempiti di olio. Se l'operatore esercita una forza F1 sul pistone di area A1, si genera una pressione nell'olio sottostante pari a p = F1 / A1, che, per il principio di Pascal, si trasmetterà a tutto il liquido, anche, sotto il pistone di area A2. D'altro canto, la stessa pressione sarà data da F2 / A2.
Equazione del martinetto idraulico
Si può scrivere, dunque, che: p = F1 / A1 = F2 / A2
Esempio di martinetto idraulico
Un meccanico vuole sollevare un'automobile con un martinetto idraulico. Il martinetto presenta una sezione nel cilindro piccolo di area pari a 1,0 cm2, mentre in ognuno dei cilindri portanti le quattro ruote dell'auto la sezione ha un'area di 500 cm2 . Se il meccanico esercita una forza di 5,0 N sul cilindro piccolo, il peso di quale automobile riuscirà a sollevare? Applichiamo l'equazione del martinetto idraulico, dove F1 è il modulo della forza, che applica il meccanico, A1 è l'area del pistoncino su cui la applica, A2 è l'area totale dei pistoni che sorreggono le quattro ruote dell'auto e F2 è l'incognita: F1 / A1 = F2 / A2 Ricaviamo l'incognita: F2 = A2 · F1 / A1 Inserendo i valori, otterremo: F2 = 4 . 500 cm2 · 5,0 N / 1,0 cm2 = 10 kN
La pressione del peso dei fluidi
Negli esempi visti nel paragrafo precedente, i liquidi erano contenuti in vasi, che presentavano altezze ridotte (pochi centimetri). Per questo motivo, alla base di ogni vaso, la pressione dovuta alla sola presenza del liquido, cioè dovuta al suo peso, era trascurabile. Nel caso invece, di grandi colonne di fluido, liquido o gassoso che sia, bisogna tenere in conto della pressione del peso del fluido stesso (immagiamo facilmente l'enorme pressione che c'è alla base di una diga piena d'acqua). Prendiamo, ad esempio, una cisterna piena d'acqua, come raffigurata di seguito
Misurazione della pressione relativa
La cisterna ha sul fondo la sonda di un manometro. Questo è lo strumento che permette di misurare direttamente la pressione relativa, intendendo per questa, la pressione dovuta o a una forza esterna (vedi l'esempio del martinetto idraulico) o al peso del fluido (vedi questo caso della cisterna). Se volessimo sollevare la sonda nella cisterna, vedremmo che, automaticamente, l'indicatore andrebbe verso indici di pressione relativa minori.
Legge di Stevino
Si può dimostrare che c'è una proporzionalità diretta tra la profondità h cui si trova la sonda nel liquido e la pressione relativa rilevata dal manometro; c'è, altresì, una proporzionalità diretta tra la pressione relativa e la densità del liquido d e tra questa e l'accelerazione di gravità g. Tutte queste considerazioni possono essere regolate dalla seguente espressione pr = d · g - h che prende il nome di legge di Stevino, che definisce la pressione idrostatica di un fluido.
Esempio di legge di Stevino
Una piscina presenta una variazione in altezza del proprio fondo, come nel disegno seguente. Con un manometro misuri la pressione p1 = 20000 Pa a livello h2 e, poi, p2 = 40000 Pa per il livello h2. Qual è il dislivello tra i due fondi della piscina? h1 hz Ah L'acqua ha una densità di 1000 kg/m3 e g = 9,81 m/s2. Potremo, così, ricavare sia h2 sia h2 h1 = pr1 / d · g = 20000 Pa / (1000 kg/m3 · 9,81 m/s) = 2,04 m2 Analogamente, per h2: h2 = Pr2 / d · g = 40000 Pa / (1000 kg/m3 · 9,81 m/s2) = 4,08 m A questo punto, si può calcolare il dislivello richiesto: Ah = h2 - h1 = (4,08 - 2,04) m = 2,04 m NB: giacché il prodotto della densità per l'accelerazione di gravità è costante nelle due espressioni delle altezze h1 e h2, il calcolo del dislivello lo si può effettuare, anche, facendo la differenza tra le pressioni per, poi, dividerla per il prodotto d · g: 4h = 4pr / d . g = (pr2 - Pr) / d · g
La pressione atmosferica
Non esiste, però, solo una pressione, detta relativa e, cioè, dovuta o a una forza esterna o quella idrostatica. Nell'ambiente esiste, come ben sappiamo, l'aria ambientale, che è un gas e, cioè, anch'essa fa parte dei fluidi. Per quanto bassa possa essere la sua densità (d = 1,29 kg/m3), anche l'aria atmosferica ha un proprio peso; per cui, immaginando una colonna d'aria, che gravi perpendicolarmente su una superficie orizzontale, avremo che, anche in questo caso, il suo peso esercita una pressione sulla superficie sottostante. Tale pressione prende il nome di pressione atmosferica pa. La pressione atmosferica (o ambientale) non è considerata relativa e si misura direttamente con uno strumento chiamato barometro. Le unità di misura, che sono tipicamente utilizzate nella fisica dell'atmosfera quando si parla di pressione, sono l'ettopascal [hPa] o il millibar [mbar], che sono equivalenti. L'ettopascal è un'unità di misura cento volte più grande del pascal e il millibar è mille volte più piccolo del bar. Siccome il bar equivale a 100000 Pa, il millibar è 100 pascal; da qui l'equivalenza esposta sopra. Una pressione atmosferica normale vale 101300 Pa; il che equivale a 1013 hPa o 1013 mbar. Un'altra unità di misura della pressione atmosferica è l'atmosfera [atm], usata anche per le pressioni relative. Un'atmosfera corrisponde a 101300 Pa: 1 atm = 1013 hPa = 1013 mbar Se prendiamo un recipiente cilindrico e lo riempiamo d'acqua, lasciando il pelo libero a contatto con l'aria atmosferica, questa eserciterà sull'acqua una pressione, che corrisponde a quella ambientale del momento. Per il principio di Pascal, però, essa è una pressione esterna, che si trasmetterà su tutti i punti del fluido, fino al fondo. Sul fondo del recipiente, quindi, si avrà una pressione totale, detta pressione assoluta pa, data dalla somma di quella atmosferica più quella relativa: Pa = Patm + Pr
Esempio di pressione assoluta
Una cisterna contiene dell'olio minerale (d = 900 kg/m3). La cisterna è aperta in sommità, quindi l'olio è a contatto con l'aria ambientale (pa = 100 kPa). L'olio arriva fino a una profondità di 2,5 m. Qual è la pressione assoluta che ha l'olio sul fondo della cisterna? Che cosa leggerebbero un barometro e un manometro, con la sonda posta al fondo della cisterna? La pressione relativa è data dalla legge di Stevino: pr = d . g . h = 900 kg/m3 · 9,81 m/s2 · 2,5 m = 22 kPa La pressione assoluta sarà data da: Pa = Patm + pr = 100 kPa + 22 kPa = 122 kPa.
Esempio di pressione pneumatico
Lo pneumatico di un'automobile è gonfiato, come prevede il libretto d'uso e manutenzione della macchina, a una pressione relativa di 2,2 bar. Calcolare qual è l'area della superficie di contatto tra il battistrada dello pneumatico e la strada, se l'auto pesa 12 kN. F A b La pressione relativa, che agisce sull'aria contenuta nello pneumatico, è dovuta alla quota-parte di peso dell'auto, che agisce sulla ruota. Ipotizzando, per semplicità, che il peso della macchina si distribuisca uniformemente sulle quattro ruote, si avrà che F = P/4. Possiamo calcolare, ora, l'area di contatto dello pneumatico con la strada: A = F / p, = 3 kN / 2,2 · 105 Pa = 1 · 10-2 m2 = 1 dm2