Storia dell'amministrazione italiana: da Napoleone all'età giolittiana
Documento del Prof. Forcellese su Storia dell'Amministrazione. Il Pdf, un'approfondita trascrizione di lezioni universitarie di Storia, esplora l'evoluzione dell'amministrazione italiana, concentrandosi sul periodo napoleonico, l'unificazione e l'età giolittiana.
See more17 Pages

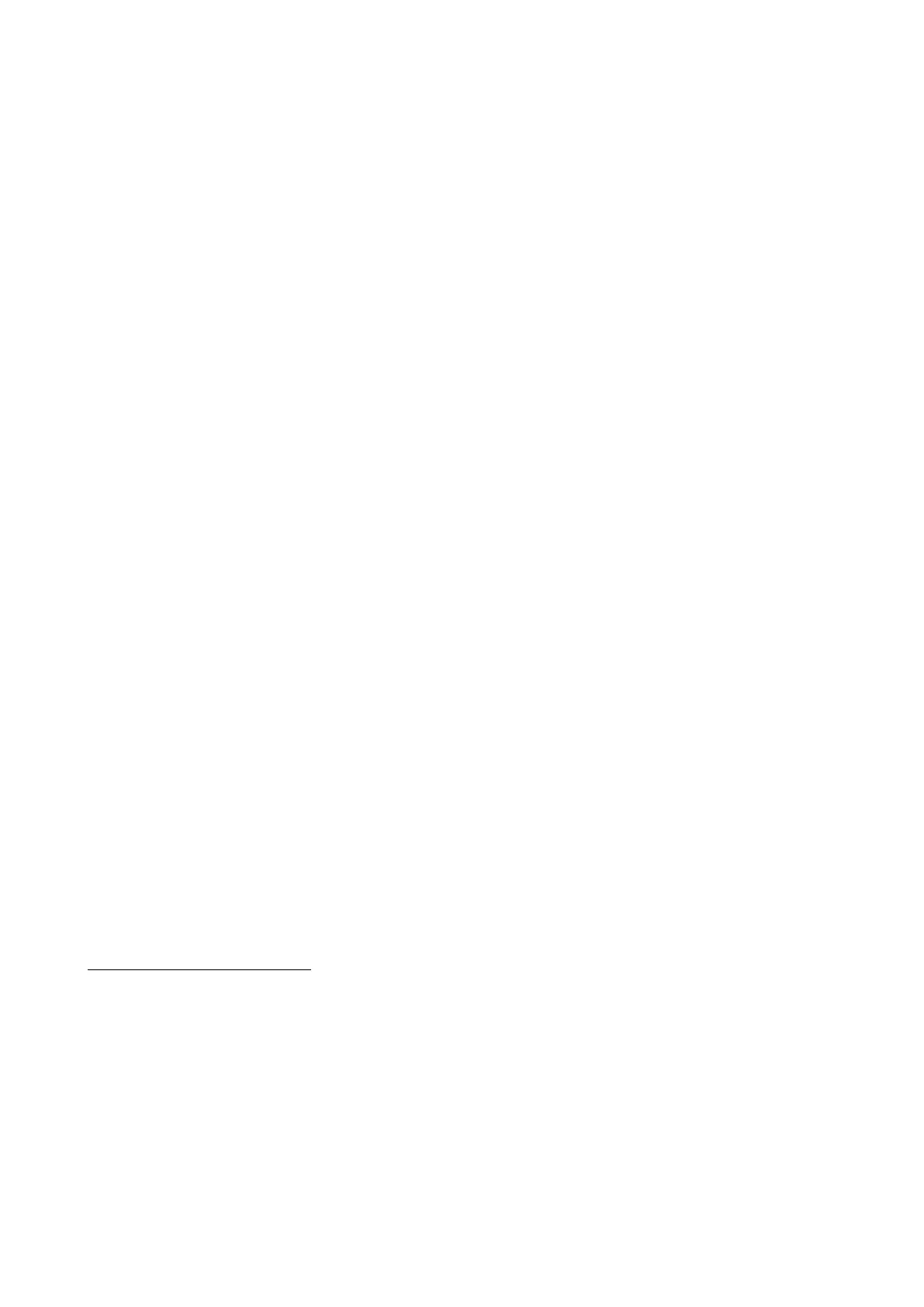
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Storia dell'Amministrazione Italiana
Influenza Napoleonica e Genesi dello Stato Unitario
Quando andiamo a spiegare la storia dell'amministrazione italiana dobbiamo ripartire dall'influenza napoleonica sulla genesi dello stato unitario. Fu un'influenza decisiva non solo dal punto di vista dell'amministrazione ma anche dal punto di vista letterario: questo periodo segna dopo secoli la possibilità per una penisola divisa in vari stati di avere un'unica direzione politica e amministrativa (sebbene con tre "tronconi" statali nominalmente diversi), facendo sorgere in tanti, soprattutto nei confronti degli intellettuali, un forte sentimento di unitarietà (ricordiamo le odi di Foscolo dedicate a Napoleone, oppure le riflessioni di Manzoni e Leopardi). Quella esperienza permane negli stati preunitari, nonostante molti regnanti siano stati spodestati dai troni.
Riforma Cavour e Nascita dello Stato Unitario
Gli storici scelgono come data di partenza della storia dell'amministrazione italiana il 1853, anno della famosa "riforma Cavour" (L. 23 marzo 1853, n.1483), che istituisce l'amministrazione "per ministeri", caratteristica dell'età moderna e contemporanea. Questa riforma è "periodizzante" da due punti di vista: in primo luogo, tale riforma si inserisce in quel virtuoso circuito di riforme costituzionali (1848, lo Statuto Albertino1), in cui c'è la tripartizione tra sovrano, governo e parlamento. La grande novità è che si passa ad una prima forma di rappresentanza politica, per cui il sovrano dovrà rapportarsi con una maggioranza che si forma in parlamento, mediante elezioni, già sperimentate a livello locale nel periodo napoleonico con la nascita del comune moderno (1806, in questo caso parliamo di un elettorato ristretto, basato sul "censo"). In secondo luogo, tale riforma certifica, anche sul piano tecnico, l'inserimento a pieno titolo del Piemonte verso la "modernità" medio-europea.
Possiamo stabilire la data di nascita dello stato unitario italiano nel 17 Marzo 1861, giorno in cui il Re Vittorio Emanuele II diviene per legge il primo Re d'Italia. Come fa a diventare il primo RE d'Italia, essendo nell'ottava legislatura e mantenendo come numero cardinale il 2°? Sia Cavour che Vittorio Emanuele II vogliono rimarcare la continuità dello Stato, una continuità tra i due ordinamenti. Il sovrano mantiene per sé il numerale di 2° per marcare questa continuità, ma tale legislatura viene fatta sulla base di una legge, già utilizzata nel regno di Sardegna (Legge "Rattazzi", che ha una base di fondo molto ristretta (votano l'1,9% dei cittadini rispetto al totale della popolazione), con cui vengono strutturati i collegi uninominali a doppio turno maggioritario per 443 collegi su base provinciale.
Ma perché gli storici fanno partire la storia dell'amministrazione italiana dal 1853 se l'unità d'Italia avviene nel 1861 (formalmente l'Italia esiste anche prima del 1861, ma non c'è un'unità politica dell'Italia)? Perché la legge del 1853 sarà poi legge dello stato italiano. È necessario in questo caso capire cosa si intenda per processo di "piemontesizzazione": ci indica che il corpo legislativo del Regno di Sardegna2, con la casa dinastica dei Savoia, viene esteso a tutta la penisola.
La riforma di Cavour arriva dopo pochi anni dallo Statuto Albertino, si può dire che cerchi di attuare lo statuto in qualche maniera. Lo Statuto inserisce il Piemonte in questa modernità (parlamento/rappresentanza); prima non è che non ci fosse l'amministrazione ma era divisa in ministeri e aziende, i primi si occupavano dell'amministrazione e i secondi della parte economica; non c'era, però una rappresentanza politica, c'era il sovrano. Con questo provvedimento, Cavour vuole riunire la parte amministrativa e quella economica in un'unica direzione che abbia la direzione politica ed esecutiva in capo solo al ministro. Prima avevamo il sovrano ed un governo fiduciario che rappresenta gli interessi solo del Re, ma quando c'è un parlamento che rappresenta gli interessi dell'intera collettività, cioè dello stato nazionale, anche se su base censitaria, ci si deve 1 Nello Statuto Albertino permaneva il dualismo, in quanto non è prevista una fiducia espressa delle camere per formare il governo, perché è il governo del Re. Nella prassi, però, si forma la consuetudine per cui il Presidente del Consiglio, figura non prevista dallo Statuto Albertino, viene ad assumere un ruolo politico con una relativa maggioranza all'interno del Parlamento. Gli storici e i costituzionalisti parleranno di istituto della "doppia fiducia", del sovrano che dà l'incarico e del parlamento che vota. Tutto ciò avverrà attraverso la forte leadership di Cavour, leader dei liberal moderati, in contrapposizione a Rattazzi, leader dei liberal progressisti (dal cui accordo volto ad escludere dall'aerea della maggioranza in parlamento le correnti "estreme" si arriverà a quel tipo di unificazione). 2 Questa modifica amministrativa del Regno di Sardegna avviene intorno alla metà del '700 e la divisione era fatta in amministrazione per ministeri e per aziende. Dal punto di vista costituzionale esisteva un governo fiduciario del Re, mancava una figura apicale politica.2 confrontare con questa rappresentanza. Ciò significa che se Cavour ha una maggioranza in parlamento, il Re conta di meno. Il passaggio fondamentale riguarda il fatto che la divisone della società è diversa rispetto all'ancien regime, per corpi e per ceti. La direzione politica nel senso di rappresentanza della società e della nazione avviene con i parlamenti di età moderna e questo disegno di Cavour va a dare una direzione politica unitaria e una uniformità nell'azione amministrativa (sotto il ministro).
Influssi Determinanti e Riorganizzazione Territoriale
Gli influssi determinanti per la nascita dello stato unitario sono da ricondurre, sicuramente, alla legge Cavour, quale legge che istituisce i ministeri su base gerarchica, e anche al periodo napoleonico che segue la Rivoluzione francese, in virtù di uno smantellamento dell'antico ordine, attraverso cui si disegna un nuovo tessuto di relazioni tra individui e stato, basato sull'eguaglianza giuridica degli abitanti elevati al rango giuridico di "cittadini". Nel periodo citato si afferma un esercizio monopolistico del potere pubblico in virtù di una normazione resa vigente nell'intero territorio: in questo quadro si delineano, dapprima, l'abolizione dei privilegi del clero e della nobiltà e, in secondo luogo, la cancellazione di qualsiasi giurisdizione, sia essa feudale, ecclesiastica, corporativa o cittadina, che sia alternativa a quella statale. Se, quindi, da un lato si tolgono questi grandi privilegi che hanno fatto saltare l'equilibrio della monarchia francese3, dall'altro si evince un netto cambiamento del rapporto tra l'individuo e lo Stato: i cittadini vengono trasformati in una massa di individui giuridicamente uguali, mentre lo Stato assume l'esclusiva del pubblico potere e riorganizza il territorio a partire dalle proprie esigenze. Tutto ciò si accompagna all'affermazione dei diritti della cittadinanza (diritto di culto, libertà di pensiero, stampa, associazione, ecc.) e di una geografia giurisdizionale e politica. La L. 289/1789, infatti, istituisce la ripartizione del territorio secondo uno schema gerarchico a cerchi concentrici sempre più piccoli, dal piccolo al grande: vengono istituiti i dipartimenti, i distretti e le municipalità, che noi poi chiameremo, a livello preunitario con i nomi di province, circondari, mandamenti e comuni.
Il comune è la base naturale.
Il mandamento4 è la circoscrizione territoriale della giurisdizione del pretore (esso è sede di preture), comprendente uno o più comuni; essi eleggeranno, quando saranno creati i consigli provinciali, i rappresentanti in sede provinciale, divisi per numero di popolazione.
Il circondario5 divide la provincia in uno o più circondari, in cui vi è il rappresentante del governo, chiamato dapprima "intendente", poi "governatore" e in ultimo "prefetto". La sede dei circondari sono i sottoprefetti e i tribunali. Questa divisione del territorio è importante anche perché uno degli elementi essenziali della p.a. italiana, cioè il prefetto, andrà a coordinare e sorvegliare, in qualità di rappresentante del governo per conto del Ministero dell'interno, tutte le attività svolte nella provincia, politiche, economiche o amministrative.
Questa divisione, di ispirazione napoleonica, permane anche negli stati preunitari, i quali approfittano di tale circostanza perché garantisce un controllo capillare del territorio, anche attraverso l'uso della polizia. Se, quindi, da un lato l'individuo acquisisce maggiori libertà, dall'altro diventa più sguarnito nei confronti di uno Stato che applica i principi liberali.
Il sistema napoleonico, gerarchico e geometrico del territorio, viene, pertanto, mantenuto, anche con l'introduzione nella rappresentanza locale di criteri censitari per la scelta dei sindaci e dei consiglieri comunali (parliamo di una limitata parte di popolazione, perché durante il decennio napoleonico i principi della libertà, uguaglianza e, soprattutto, della proprietà). I criteri elettorali sono di base censitari, nel senso che per il voto bisogna dimostrare di lavorare e di avere un 3 Negli stati moderni, la rappresentanza era divisa per ceti: nobiltà, clero e terzo stato. Quando vengono convocati, è la stessa monarchia che fissa le regole elettive e che abbassa il diritto alla partecipazione, soprattutto per il terzo stato. Gli Stati generali erano un organo meramente consultivo, privo di competenze definite, venivano convocati dal sovrano saltuariamente, in genere per ottenere sostegno politico o finanziario in circostanze particolarmente delicate. Erano formati dai rappresentanti del clero, della nobiltà e del terzo Stato. Vengono convocati nell'1788, dopo tanti anni, e fanno venir fuori una situazione che si era già creata, cioè che nobiltà e clero rappresentano un'esigua minoranza della popolazione (circa il 2%). Gli altri ceti che si sono pian piano affermati, che chiameremo con il termine "ottocentesco" di borghesia, nei quali rientrano i professionisti, i commercianti, gli artigiani, i banchieri, ecc., iniziano ad invocare la rappresentanza. È una forma diversa del no taxation without representation, per cui le colonie americane si ribellano alla madrepatria (il Parlamento non può stabilire le tasse senza che io abbia dei rappresentanti nell'assemblea stessa). 4 Circoscrizione amministrativa italiana, intermedia tra il circondario e il comune, che, già esistente nell'Italia preunitaria (Piemonte, Lombardia, Toscana, altrove chiamata distretto, come nel Veneto e nel Mantovano), è perdurata fino al 1923; aveva scarsa importanza, servendo solo di base ad alcune funzioni amministrative e giudiziarie. 5 Circoscrizione amministrativa che (fino al 1927) costituiva in Italia la suddivisione di una provincia, segnando anche il limite della competenza dei tribunali, ed era a sua volta ripartita in mandamenti.