Federico Barbarossa: il sogno di un impero universale e i conflitti con i comuni
Documento da Scuola superiore su Federico Barbarossa, il Sogno di un Impero Universale. Il Pdf esplora la figura di Federico Barbarossa, la sua visione di un impero universale e i tentativi di riaffermare l'autorità imperiale in Italia, con un focus sulla battaglia di Legnano e la pace di Costanza, utile per lo studio della Storia.
See more10 Pages
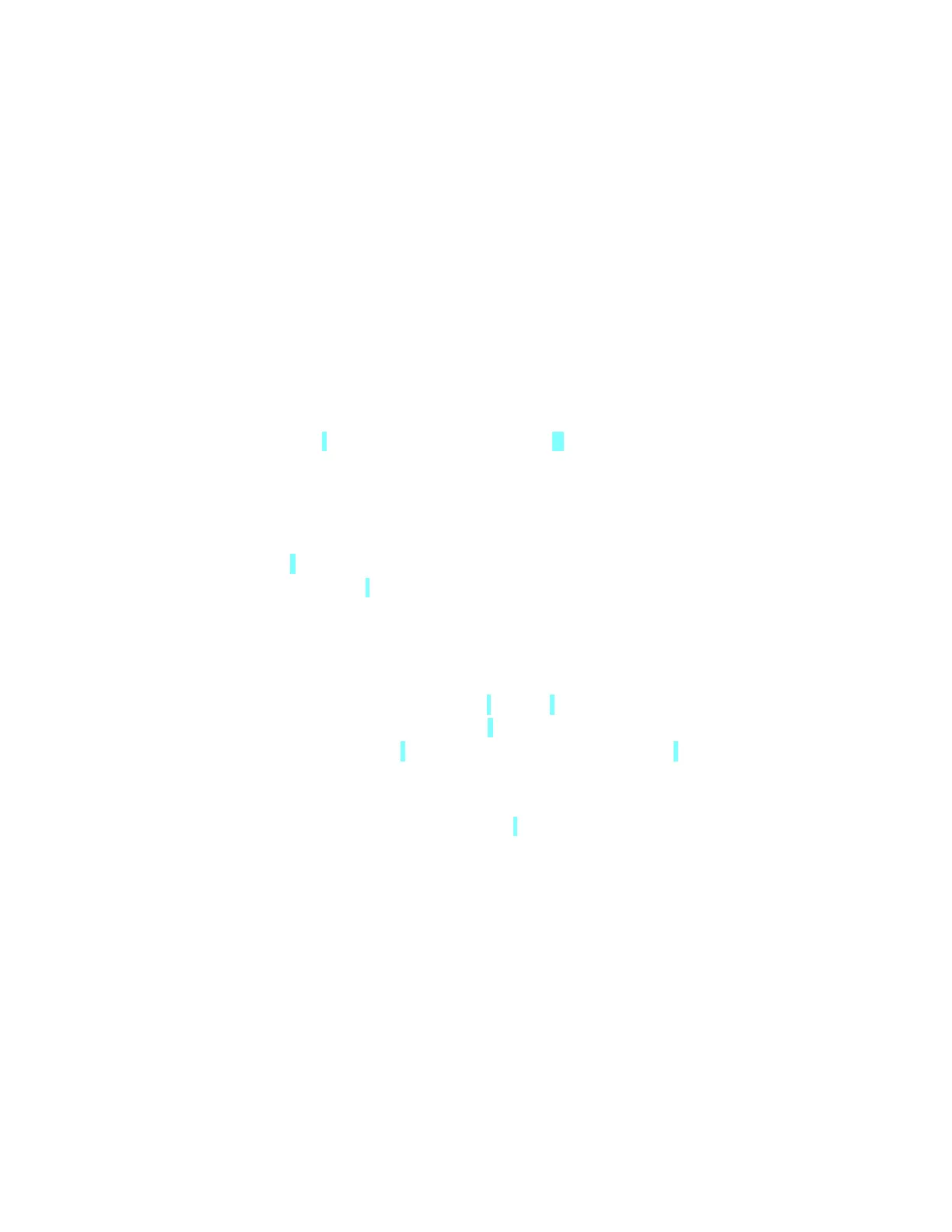
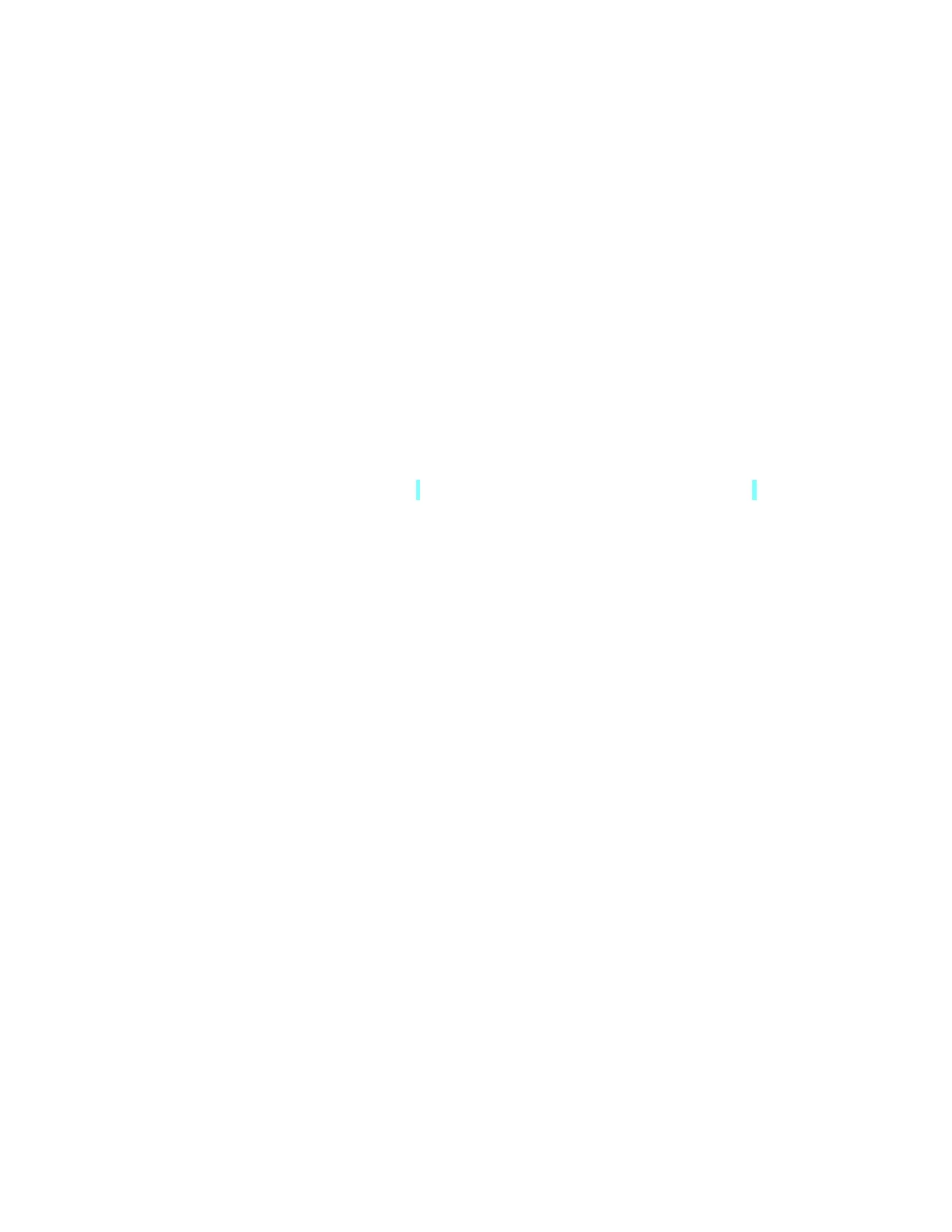
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Federico Barbarossa: Il Sogno di un Impero Universale
Federico I Hohenstaufen (1125-1190). detto "il Barbarossa" per la sua barba fulva, succede al padre Federico II come duca di Svevia nel 1147, anno in cui si unisce allo zio Corrado III. allora imperatore del Sacro romano impero, e a Luigi VII di Francia nella fallimentare seconda crociata.
Eletto re di Germania nel 1152. riporta pace e stabilità politica in patria, condizioni fondamentali per riaffermare la sua autorità in Italia e ottenere cosi il titolo di imperatore (1155). Il suo disegno di restaurazione dell'autorità imperiale e di dominio sul mondo è tuttavia in parte vanificato dalla sconfitta nella lotta contro i comuni, che lo costringe anche ad abbandonare il progetto di cacciare i normanni dall'Italia meridionale. Egli combina allora il matrimonio del figlio Enrico con Costanza d'Altavilla, erede designata del re normanno Guglielmo il Buono, suo nipote, privo di discendenti diretti. In tal modo, una volta scomparso il sovrano, il Regno normanno sarebbe stato pacificamente unito al Sacro romano impero.
Federico I. ormai avanti con gli anni, dirige le sue mire verso il Medio Oriente ponendosi a capo della terza crociata (1189-1192) conl'obiettivo di riconquistare Gerusalemme.
Nell'estate del 1190 trova la morte in Cilicia (nell'odierna Turchia sud-orientale), annegando in un fiume dopo essere caduto da cavallo forse a seguito di un collasso.
La vita e le imprese di Federico I sono state raccontate dal suo biografo Ottone di Frisinga nell'opera Le gesta di Federico I imperatore, in cui troviamo fra l'altro un ritratto fisico e morale del sovrano:
La Prima Discesa di Federico in Italia
Le Richieste di Aiuto in Italia
A legittimare la discesa di Federico I in territorio italiano fu la richiesta di intervento da parte di alcune città lombarde (Lodi, in primo luogo), preoccupate dalle mire espansionistiche del comune di Milano. Lo stesso pontefice aveva sollecitato il suo aiuto per riconquistare il controllo di Roma: la città, infatti, era insorta adottando le istituzioni comunali sotto la guida di Arnaldo da Brescia, un religioso che predicava contro la corruzione e il lusso della Chiesa.
La Dieta di Roncaglia e il Conflitto con i Comuni
Federico I convocò alla fine del 1154 una dieta a Roncaglia, nei pressi di Piacenza (luogo centrale del Regno d'Italia), cui invitò i rappresentanti di tutte le città italiane, della Chiesa e della nobiltà. In quel contesto. egli impose che le regalie fossero nuovamente trasferite al potere imperiale. Come prevedibile, i comuni si opposero a questa decisione. Il sovrano allora diede ai centri italiani un'efficace prova di forza, distruggendo le mura di alcuni comuni tra cui Asti e Tortona. Si diresse quindi a Roma, dove catturò e fece condannare al rogo Arnaldo da Brescia, restituendo la città all'autorità pontificia.
Federico I Imperatore del Sacro Romano Impero
A confermare l'autorità di Federico I fu l'incoronazione imperiale da parte di papa Adriano IV (in carica dal 1154 al 1159), avvenuta a Roma nel 1155. Tuttavia i piani del neoimperatore - che puntava ormai, con il benestare del papato, a dirigere le proprie armi contro i normanni, nel Sud della penisola - furono almeno temporaneamente bloccati: la popolazione romana, che aveva sostenuto Arnaldo da Brescia, insorse contro Federico, costringendolo a rientrare in Germania.
Dallo Scontro con la Lega Lombarda alla Pace di Costanza
La Seconda Discesa dell'Imperatore in Italia
La situazione italiana non era risolta e per questo nel 1158 Federico I tornò in Italia alla guida di un potente esercito. Convocò quindi una seconda dieta, sempre a Roncaglia, in occasione della quale ribadì, attraverso un decreto imperiale - la Constitutio de regali bus ("Costituzione sulle regalie") - il principio secondo cui le regalie erano di pertinenza dell'imperatore e non dei comuni.
I Divieti Imposti ai Comuni
A questo si aggiunse una serie di divieti che minavano le basi delle istituzioni comunali: in primo luogo, si proibiva ai ceti cittadini di riunirsi in associazioni private, le quali, avevano costituito il nucleo originario del comune; in secondo luogo, alle città era fatto divieto di formare leghe. Inoltre, l'imperatore impose in ciascun comune, compresi quelli nei territori soggetti al papato, un funzionario di propria nomina. Si trattava dunque di una vera dichiarazione di guerra ai comuni, che indirettamente minava anche il già fragile rapporto tra Chiesa e Impero.
L'Alleanza dei Comuni nella Lega Lombarda
Conseguenza immediata delle decisioni prese nella dieta fu che il nuovo pontefice. Alessandro III (papa dal 1159 al 1181), assicurò il proprio appoggio ai comuni di Crema e Milano, che nel frattempo erano insorti. La reazione di Federico I fu durissima: entrambe le città furono sconfitte e rase al suolo (1160 e 1162). A quel punto, gli altri comuni su posizioni anti-imperiali decisero di darsi una forma organizzata per opporre una più valida resistenza: costituirono così la Lega veronese (1164), che raccolse l'adesione di Verona. Padova, Treviso e Vicenza, e la Legacremonese (1167), che riunì Cremona, Milano. Mantova. Lodi. Brescia, Bergamo e altre città minori. Entrambe, nel 1167. confluirono nella Lega lombarda.
La Pace di Costanza
Lo scontro militare tra Impero e comuni si protrasse per diversi anni e culminò nella battaglia di Legnano (1176), che segnò la vittoria decisiva della Lega lombarda. Dopo una tregua di sei anni, nel 1183 venne firmata la pace di Costanza (dal nome dalla città tedesca in cui si svolsero gli incontri), che rendeva nulle le decisioni della Constitutio de regalibus e riconosceva nuovamente ai comuni le regalie di cui essi in precedenza avevano goduto. L'imperatore pretese tuttavia in cambio che i comuni gli giurassero fedeltà, e rivendicò il diritto di convalidare la nomina dei magistrati cittadini prima che potessero assumere effettivamente l'incarico.
La Vittoria dei Comuni
Se, a livello formale, le istituzioni comunali risultavano in tal modo subordinate all'autorità imperiale, di fatto la loro esistenza e la loro piena giurisdizione in materie fondamentali come l'amministrazione, il fisco, la difesa, l'esercizio della giustizia ottenevano esplicito riconoscimento da parte di quella stessa autorità. I comuni, insomma, erano usciti vincitori dal lungo conflitto con l'impero.
La Crisi del Comune Consolare
I Violenti Conflitti all'Interno dei Comuni
Sebbene i comuni fossero usciti rafforzati dallo scontro con Federico I Barbarossa, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo si manifestarono aspri conflitti tra opposti gruppi di cittadini. Il potere politico detenuto fino a quel momento dalle famiglie aristocratiche iniziò a essere rivendicato da altre famiglie del ceto borghese che, grazie alle ricchezze accumulate con le loro attività commerciali e artigianali e forti del contributo economico e militare fornito durante la guerra contro l'imperatore, intendevano accedere agli organi di governo, da cui erano di fatto esclusi. Ne derivò un periodo di instabilità, contrassegnato da violente lotte che insanguinarono le città.
Il Passaggio al Comune Podestarile
Per arginare i disordini interni, in molti comuni si attuò una trasformazione istituzionale che condusse alla nascita di una nuova magistratura unica, quella del podestà, destinata a sostituire il collegio dei consoli nell'esercizio delle funzioni esecutive del governo cittadino. Questa nuova fase storica della vita dei comuni viene detta "podestarile".
Il Comune Podestarile
Un Governo al di Sopra delle Parti
Il podestà era un magistrato stipendiato dal comune e reclutato al di fuori della città: in quanto privo di legami con le fazioni in conflitto, egli era ritenuto al di sopra delle parti. Una volta scelto dai consoli stessi o dall'arengo sulla base della sua comprovata esperienza giuridica e militare, egli firmava con il comune un vero e proprio contratto che gli consentiva di portare con sé un gruppo di collaboratori tra cui, di norma, un giudice, notai addetti alla registrazione degli atti pubblici e spesso anche quelli che le fonti chiamano "birri", ossia individui che svolgevano compiti di polizia. Nella sua azione di governo il podestà era inoltre affiancato da due consigli, che detenevano il potere legislativo: il consiglio maggiore, composto da un centinaio di membri provenienti dalle famiglie più influenti, e il consiglio minore, costituito da un numero ristretto (di norma nove o dodici) di individui, denominati "saggi".
Un Politico di Professione
Al termine dell'incarico, che aveva durata variabile (da sei mesi a un anno, al fine di evitare esiti autoritari), il podestà era sottoposto a una verifica che stabiliva se avesse esercitato correttamente o meno le sue funzioni. Per questo motivo il podestà era un vero tecnico della politica e del diritto, ed è spesso ritenuto il primo esempio di "politico di professione".
Un Nuovo Sistema di Regole per la Città
Il passaggio istituzionale al comune podestarile, oltre ad arginare almeno temporaneamente le lotte interne, favorì l'instaurazione di un sistema di governo basato su regole ben definite.
Queste regole furono codificate negli statuti che il podestà giurava di rispettare durante il suo mandato. Essi raccoglievano le norme - valide per tutti - volte a disciplinare la vita pubblica e il governo della città.
L'Affermazione Sociale del Popolo
Popolo "Grasso" e Popolo "Minuto"
Il ruolo di mediatore dei conflitti assegnato al podestà non riuscì a impedire che nella seconda metà del XIII secolo, in molti comuni, esplodessero nuovamente in tutta la loro violenza le tensioni sociali. Queste furono anzi acuite dal sempre più rilevante peso economico e sociale assunto da quel variegato ceto di ricchi mercanti, imprenditori e professionisti che le fonti dell'epoca chiamano popolo "grasso" (o, più genericamente. Popolo) e che si contrapponeva al popolo "minuto", composto soprattutto da piccoli artigiani e bottegai.
L'Organizzazione in Arti Maggiori e Minori
Il "popolo grasso" era organizzato in Arti, associazioni che in origine si prefiggevano finalità essenzialmente di tipo economico. Esse, peraltro, non godevano tutte dello stesso prestigio e della stessa importanza politico-sociale; nella maggior parte delle città mercantili e artigianali, come quelle dell'Italia centro-settentrionale, erano infatti distinte in:
- Arti maggiori, che erano costituite dai grandi gruppi dei professionisti e degli artigiani e mercanti dediti all'esportazione (vi erano ad esempio l'Arte dei giudici, dei notai, dei mercanti. l'Arte della lana ecc.);
- Arti minori, che comprendevano tutte le professioni di natura "locale" (ad esempio fabbri,