Antropologia Filosofica: Natura, Cultura e Tecnica, Implicazioni Ecologiche
Documento di Università su Antropologia Filosofica. Il Pdf esplora il rapporto tra natura, cultura e tecnica, con contributi di pensatori come Scheler, Gehlen, Plessner e Jonas, per la materia Filosofia.
Mostra di più48 pagine
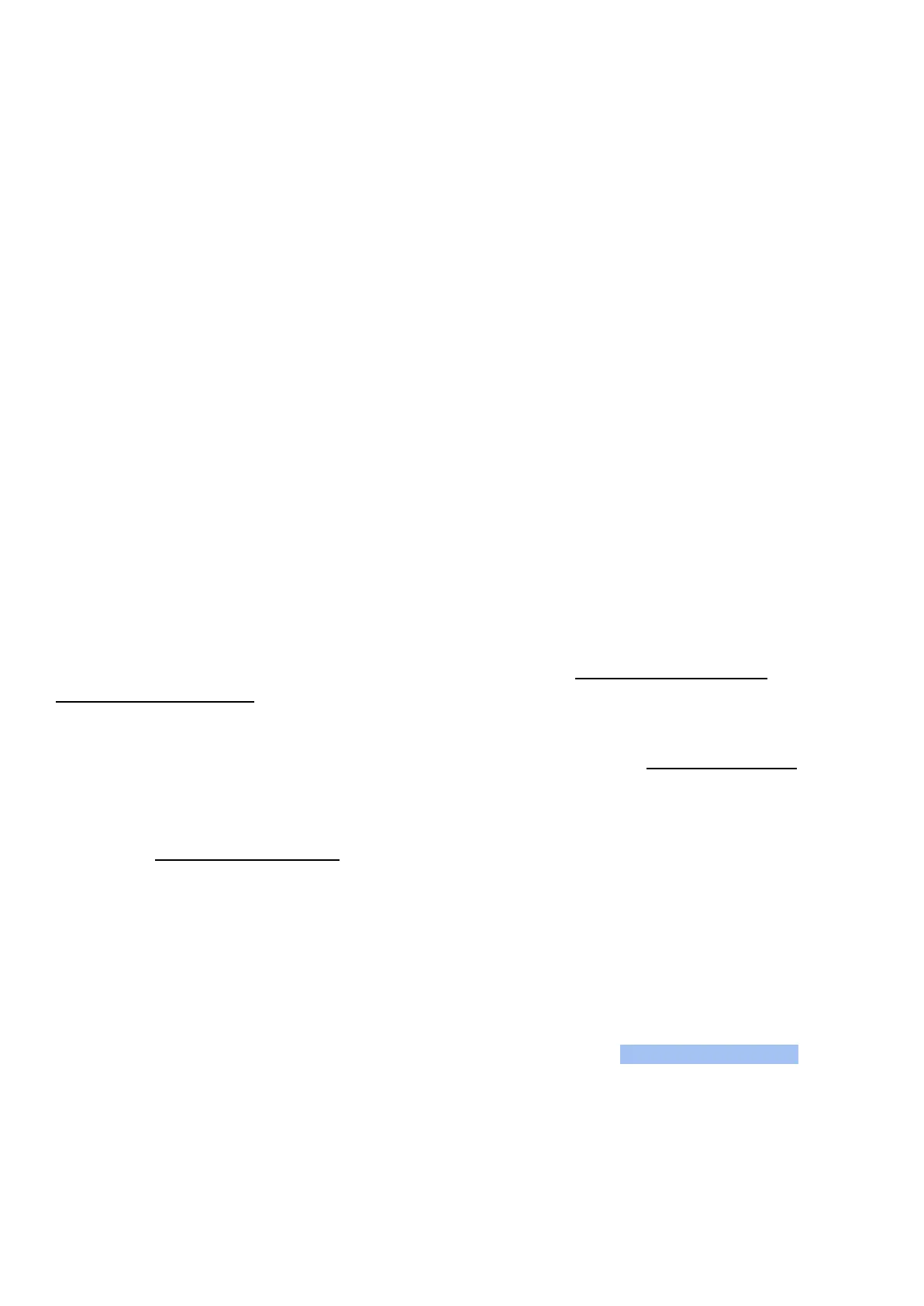
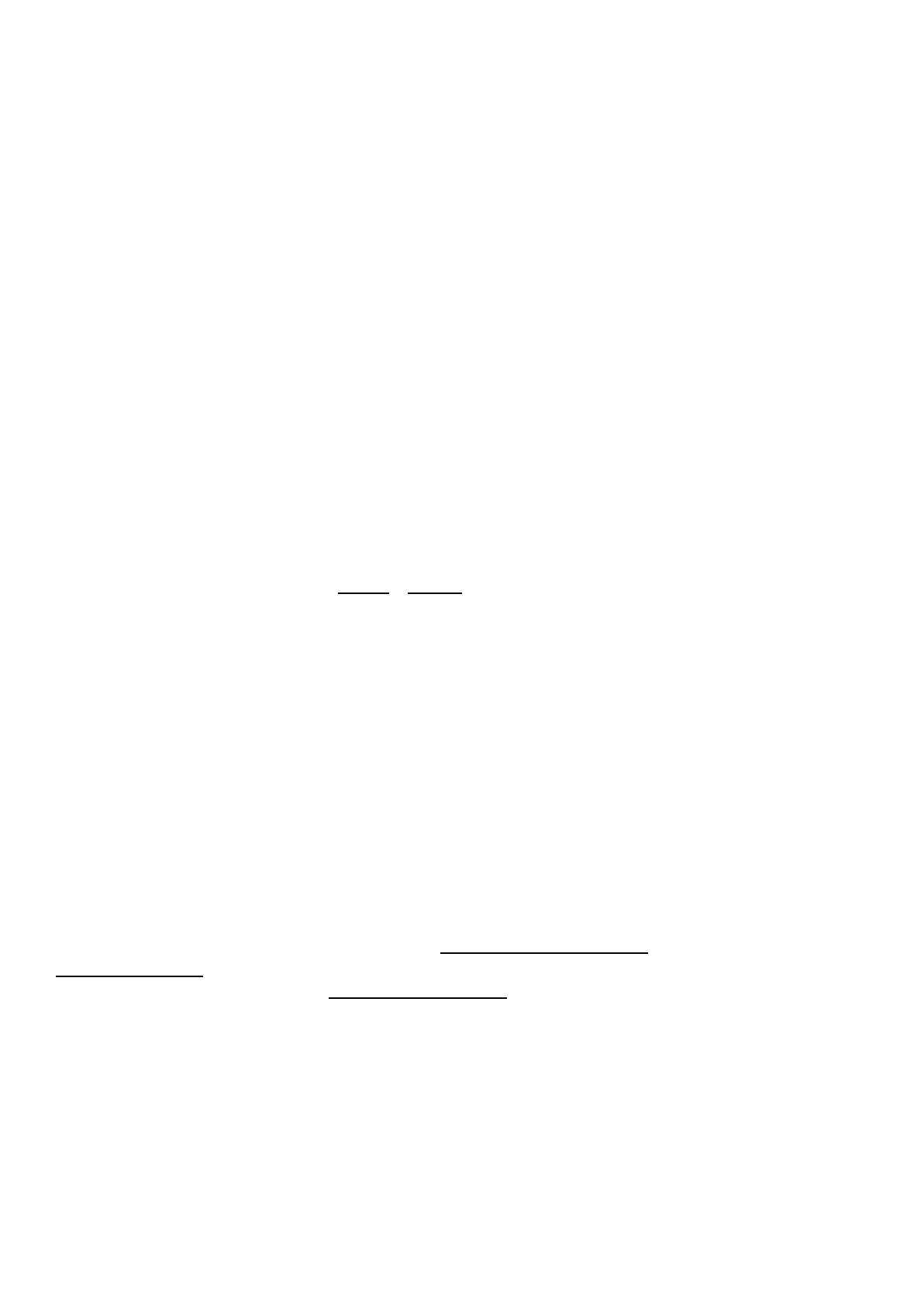
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
INTRODUZIONE: Natura, cultura e tecnica. Fenomenologia del vivente ed ecologia
La crisi ecologica di cui il cambiamento climatico è,per usare un'immagine eloquente,paragonabile alla punta minacciosa di un iceberg che si sta sempre più avvicinando,è la prova evidente che l'umanità sta viaggiando,anche a velocità sostenuta,verso il capovolgimento delle magnifiche sorti progressive della visione scientista-tecnologica degli ultimi secoli in catastrofi progressive. In questa congiuntura risulta chiaro quanto l'ambiente naturale e l'ambiente artificiale siano interconnessi e ciò abbia conseguenze sulla possibilità di sopravvivenza dell'essere umano. Tornare a pensare in termini di sopravvivenza porta ad reinterrogarsi sul senso del vivere e della centralità della sua dimensione corporale senza per questo negare la dimensione spirituale. Prendendo coscienza di questo l'antropologia filosofica contemporanea si occupa dell'essere umano e della fenomenologia del vivente nel suo complesso,delle sue relazioni ecologiche e riflette sulle ricadute dello sviluppo tecnologico sulle questioni ambientali. Sulla base di studi che arrivano dalla filosofia,dall'antropologia e dalle scienze, viene proposto un percorso nella direzione del rintracciamento del senso dello sviluppo della vita nella pluralità delle sue forme. Questo percorso mette radici negli studi e nelle riflessioni dei fondatori dell'antropologia filosofica contemporanea di matrice fenomenologica come Max Scheler, Arnold Gehlen,Helmuth Plessner e in autori collaterali come Hans Jonas e in rappresentanti dell' ermeneutica Hans Georg e Luigi Pareyson.
CHE COS'È L'ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
L'antropologia filosofica si confronta con molti problemi che appartengono agli esseri umani in quanto essi sentono, desiderano,temono,pensano, vogliono,sperano,credono e comunicano,nonostante la differenza di cultura e geostorica. Quindi il campo dell'antropologia filosofica è l'essere umano nel mondo. Il termine "antropologia" inizia a consolidarsi nel suo attuale significato tra 600-700. Tra i primi ad usare questo termine ci sono: Malebranche, Diderot e D'Alambert;Hume si occupa di un'antropologia che elabora non solo la socialità,ma mette in evidenza che le emozioni sono importanti per l'essere umano. È il primo a pensare che anche gli animali soffrono,e Kant che distingue antropologia fisiologica e antropologia pragmatica(il fatto che l'uomo possa rappresentare il proprio IO lo eleva infinitamente al di sopra di tutti gli altri esseri viventi sulla terra. Per questo l'uomo è un essere del tutto diverso dalle cose. Kant distingue un'antropologia fisiologica, che indaga quel che la natura fa dell'essere umano,da un antropologia pragmatica. La distinzione di Kant è rimasta,e ancor oggi vi è un antropologia fisica che considera l'essere umano dal punto di vista biologico,nella sua struttura somatica,nei suoi rapporti con l'ambiente, nelle sue classificazioni e un'antropologia culturale che considera l'essere umano radicalmente costituito dai rapporti storico-sociali. L'antropologia culturale si svilupperà in una prospettiva debitrice agli orientamenti positivistico-evoluzionisti della seconda metà del 1800 con Edward B. Taylor e Lewis Henry Morgan;che intendevano la cultura secondo uno schema evolutivo. Fu Franz Boas a sottolineare che le differenze tra le diverse civiltà sono di ordine naturale e culturale, e la chiave di lettura di stampo evoluzionista non è sufficiente. Egli procedeva dal punto di vista metodologico con un approccio empirista,fin dai primi viaggi avventurosi verso l'Artico e l'isola di Baffin,fra gli indiani nella Columbia Britannica e altri nativi della costa nord-occidentale. La docenza dal 1899 alla Columbia University e la collaborazione all'American Museum of Natural History,gli permisero di guidare una generazione di antropologi e antropologhe che andarono oltre il paradigma unilineare dell'evoluzione. Per Ruth Benedict, Alfred Kroeber,Margaret Mead, Edward Sapir:ogni cultura è un'esperienza irripetibile nella propria interezza di forme e significati. Tale approccio venne definito "particolarismo storico": si soffermò sull'individuale irripetibile. Ciò portò a sostenere il pluralismo,il valore dell'empatia e della ricchezza culturale che nasce dall'incontro con l'altro. Questo "piccolo gruppo", come chiamava affettuosamente Boas i suoi allievi non solo decostruì il concetto di razza,ma aprì le menti all'idea di relativismo culturale e anche all'idea che l'essere umano sia sostanzialmente un animale culturale. Così le tradizioni occidentali apparivano loro come una minima parte del modi che gli esseri umani avevano elaborato per risolvere i problemi basilari o invariabili,secondo Ruth Benedict.
L'eredità della scuola antropologica e la cultura
1L'eredità di questa scuola antropologica,situata nella preistoria dei forti cambiamenti sociali degli ultimi 100 anni, è l'attitudine a pensare che il modo in cui definiamo l'intelligenza è il risultato di un processo sociale, così come il concetto di razza o che,invece,l'osservazione del fenomeni, delle realtà di fatto ci porta ad ammettere che la mescolanza è lo stato naturale del mondo. Oggi,sulla via indicata da questa scuola,si intende per cultura la disposizione ad affrontare la realtà che si costituisce negli individui in quanto membri di società che si sono determinate in seguito all'evoluzione storica. Inoltre,l'indicazione della scuola boasiana di studiare i singoli fenomeni culturali,ovvero le singole culture, come sostenne George Frazer,ha comunque condotto a osservare e rilevare tratti analoghi in società differenti. Tale base empirica ha permesso di formulare ipotesi di carattere generale sui processi culturali. È così sorto il problema del rapporto fra la dimensione universale e quella particolare anche nell'indagine antropologica. Ciò ha portato,da un lato,ad approfondire la connessione dell'antropologia con gli studi etnologici ed etnografici come terreni di verifica di ipotesi antropologiche,che potenziano la ricerca sul campo. Dall'altro lato ha comportato la necessità di un orientamento ideologico che l'antropologia accademica a partire,appunto dalla scuola di Boas,ha individuato nel riconoscimento della pari dignità di tutte le culture. Rilevata la presenza di elementi essenziali ma comuni all'universale natura umana e vedendone le innumerevoli varietà di declinazione,si è concluso che sul piano immanente dell'analisi antropologica non si possano trovare criteri assiologici per cui una cultura è superiore all'altra. In tale prospettiva, la natura umana costituisce ciò che è comune e la cultura ciò che è particolare e relativo. Questo, tuttavia, spalanca la questione del rapporto fra natura umana e realtà naturale del mondo fisico e animale. Alfred Kroeber,allievo di Boas,ad esempio, torna ad argomentare l'irriducibilità della dimensione culturale umana alla realtà naturale ma anche a quella sociale del mondo animale. Gli studi etologici,poi, hanno mostrato come l'evoluzione culturale non sopravvenga all'evoluzione biologica,ma si intrecci con essa e su di essa e interagisca. Così cultura e società sono ritenuti fattori della stessa evoluzione fisico-biologica e la stessa divisione dell'antropologia culturale dall'antropologia fisica, che aveva fondato la scuola boasiana, viene ridiscussa. Si può dunque convenire con Silvana Borutti che dal punto di vista metodologico,così come particolare e universale appaiono termini correlativi di un medesimo processo epistemico,anche cultura e natura risultano termini correlativi di un medesimo processo empirico. L'analisi delle varie prospettive antropologiche fa emergere alla base di ognuna uno specifico orientamento teorico. La presa di coscienza di tali questioni all'interno dell'antropologia culturale, a partire dalla metà del 1900,ha nuovamente interrogato la filosofia e la sua funzione di riflessione su metodi, statuti epistemologíavelamento e critica del presupposti ideologici. L'indagine antropologica si rivela oggi tanto più necessaria quanto più come sostiene Max Scheler:«Noi siamo la prima epoca in cui l'uomo è divenuto completamente e interamente problematico per se stesso;in cui egli non sa più che cosa è,ma nello stessa tempo sa anche che non lo sa>>. Nel Ventesimo secolo,l'accelerazione dello sviluppo delle scienze e delle tecniche ha posto nuovi interrogativi e stimoli anche alla filosofia aggiungendo ai tradizionali aspetti ontologici, metafisici,gnoseologici,elici,necessariamente altre prospettive e variabili a chi indaga le questioni che riguardano l'essere umano nel suo interrogarsi radicale e nel suo desiderio di orientarsi nell'esistenza. In questo nuovo contesto si sviluppa l'antropologia filosofica contemporanea:in questa disciplina il problema-umanità è il problema centrale e prioritario ma si cerca di procedere non più per via deduttiva da sistemi culturali già costituiti,ma per via induttiva e deduttiva in un confronto continuo con l'esperienza per arrivare a risultati con un qualche grado di "oggettività" e dunque di comunicabilità. Crisi delle interpretazioni puramente positiviste e scientiste del mondo. Desiderio di un nuovo umanesimo. Risorge la domanda filosofica di un'interpretazione che armonizzi e unifichi i risultati scientifici in nuove concettualità e visioni sul tema-umanità, tema che torna a interrogare e a mostrare la sua centralità. Tale consapevolezza è ben viva nella concezione ermeneutica attuale che ha fra i suoi maggiori interpreti l'italiano Luigi Pareyson e il tedesco Hans Georg Gadamer,per citare alcuni,il quale sostiene che quando si interpreta, in realtà si attua sempre un progetto. L'autentica comprensione consisterà nell'elaborazione di questa precomprensione,di questo progetto preliminare,continuamente riveduto nell'approfondimento della conoscenza della situazione,del problema.
Il circolo ermeneutico e l'antropologia filosofica
2Il percorso di conoscenza e comprensione è dunque un rapporto circolare,fra le nostre pre-supposizioni e ciò che incontriamo nel conoscere e nel comprendere che dà luogo ad un progetto che via via viene sempre rielaborato. Questo é l'abitare il "circolo ermeneutico". Anche nell'antropologia filosofica si attua una sorta di circolo interpretativo,che Coreth in "Antropologia filosofica" denominata "circolo antropologico". Portiamo noi stessi già sempre con noi:il nostro luogo storico,la nostra esperienza,e l'esperienza del mondo il nostro orizzonte di comprensione. La pre comprensione dell'essere umano concreto,che vive nella storia non può affatto essere posta fuori dal circolo,ma può disporsi in esso in modo aperto. Il fine di questo primo percorso è quello di prendere consapevolezza che il confine dell'antropologia filosofica, contemporanea nata nel 1900,è sfumato e amplia la schiera di coloro che possono essere inclusi fra i suoi cultori. Per tale motivo,a parte un piccolo nucleo costante di autori, considerati i fondatori, Max Scheler, Arnold Gehlen e Helmuth Plessner, di matrice fenomenologica, troviamo spesso citati autori differenti considerali talvolta come centrali,e a questo proposito includere Hans Jonas,altri come precursori in senso proprio o collaterali e ciò si ripercuote sulle svariate articolazioni della stessa disciplina.
CONNOTARE LA LIBERTÀ
Ciò che ha portato l'antropologia filosofica contemporanea a porre al centro dei suoi interessi non solo l'essere umano,ma l'essere umano nella sua relaziona con l'ambiente, ed anche a riflettere sulle ricadute dello sviluppo tecnologico,sulle questioni ambientali,è la necessità di evitare la corsa collettiva verso la catastrofe ecologica. In questa congiuntura,inoltre,risulta chiaro quanto l'ambiente naturale e l'ambiente artificiale siano interconnessi e ciò abbia conseguenze sulla possibilità di sopravvivenza dell'essere umano stesso. Tornare a pensare in termini di sopravvivenza conduce ad una riappropriazione del senso della corporeità del vivente come medium e relazione ineludibile con il mondo naturale e artificiale. Il corpo di ogni essere vivente è,seppur in forme differenti,individualità,con un confine essenziale tra interno ed esterno, nonostante la sua vita si fondi su un continuo scambio e trasformazione. Rappresenta in natura una vera sorpresa ontologica:la forma è la causa delle accumulazioni mentali di cui consiste,auto-unifica e auto-integra attivamente una pluralità che si trasforma. Ne risulta in ogni "sinolo" vivente una viva interazione tra forma e materia,che ne confonde i confini in un rapporto che assume le caratteristiche della reciprocità. È caratteristico ad ogni livello evolutivo della forma organica della vita poter procedere al ricambio della materia solo sulla base di ciò che necessariamente trova al di fuori di sé,nell'ambiente esterno,da cui, tuttavia,non può mai rendersi autosufficiente. Si può dire che la vita è rivolta verso l'ambiente in un particolare rapporto di bisogno e nello stesso tempo di capacità di trascendere i suoi stretti limiti puramente meccanici. Tale capacità di trascendere la pura fissità meccanica della materia é evidente nella possibilità implicita del rinnovamento cellulare costante della vita organica e nella procedura della scelta. Quest'ultima a livello istintivo ed emotivo è presente solo dalle forme animali, come sostiene Konrad Lorenz nell' "Etologia. Fondamenti e metodi". Nella biologia contemporanea, tuttavia,nella indeterminatezza della previsione di alcune combinazioni chimiche senza la descrizione storica nel contesto,l'eccezione o scelta alternativa di direzione,rispetto al consueto rapporto causa-effetto,è una possibilità da tenere in conto fin dalla primitive forme di vita e la si legge in chiave probabilistica. Anche la dimensione dell'interiorità o soggettività nasce nella distanziazione dall'ambiente circostante a partire dalla relazione con esso,nella continua dinamica fra tensione al soddisfacimento e frustrazione, capacità di risposta agli stimoli e aspirazione a qualche cosa: in tali processi è evidente la centralità dell'interesse primario dell'organismo alla propria esistenza e continuazione. L'egocentricitá naturale e istintiva del vivente,che si differenzia dall'integrazione senza intenzionalità della pura materia. L'ente vitale,in questo rapporto di dipendenza e superamento insieme della sua base materiale,porta al sé un ambiente-mondo sempre più vasto nel procedere nella scala evolutiva. Nella lotta per la sopravvivenza e nel suo evolversi,l'essere vivente si adatta all'ambiente in modo sempre più dinamico e intenzionale.
L'orizzonte interiore del tempo della vita organica
L'orizzonte interiore del tempo della vita organica si estende oltre l'istante attuale nel futuro per la preoccupazione della continuazione del se e l'anticipazione di quanto è già accaduto e in qualche modo 3