Positivismo e Darwinismo: filosofia, scienza e implicazioni sociali
Documento di Università sul Positivismo, un movimento filosofico e culturale dell'Ottocento. Il Pdf esplora il Positivismo e il Darwinismo, analizzando le loro origini, i concetti chiave e le implicazioni filosofiche e sociali, con un focus sulla Filosofia.
Mostra di più9 pagine
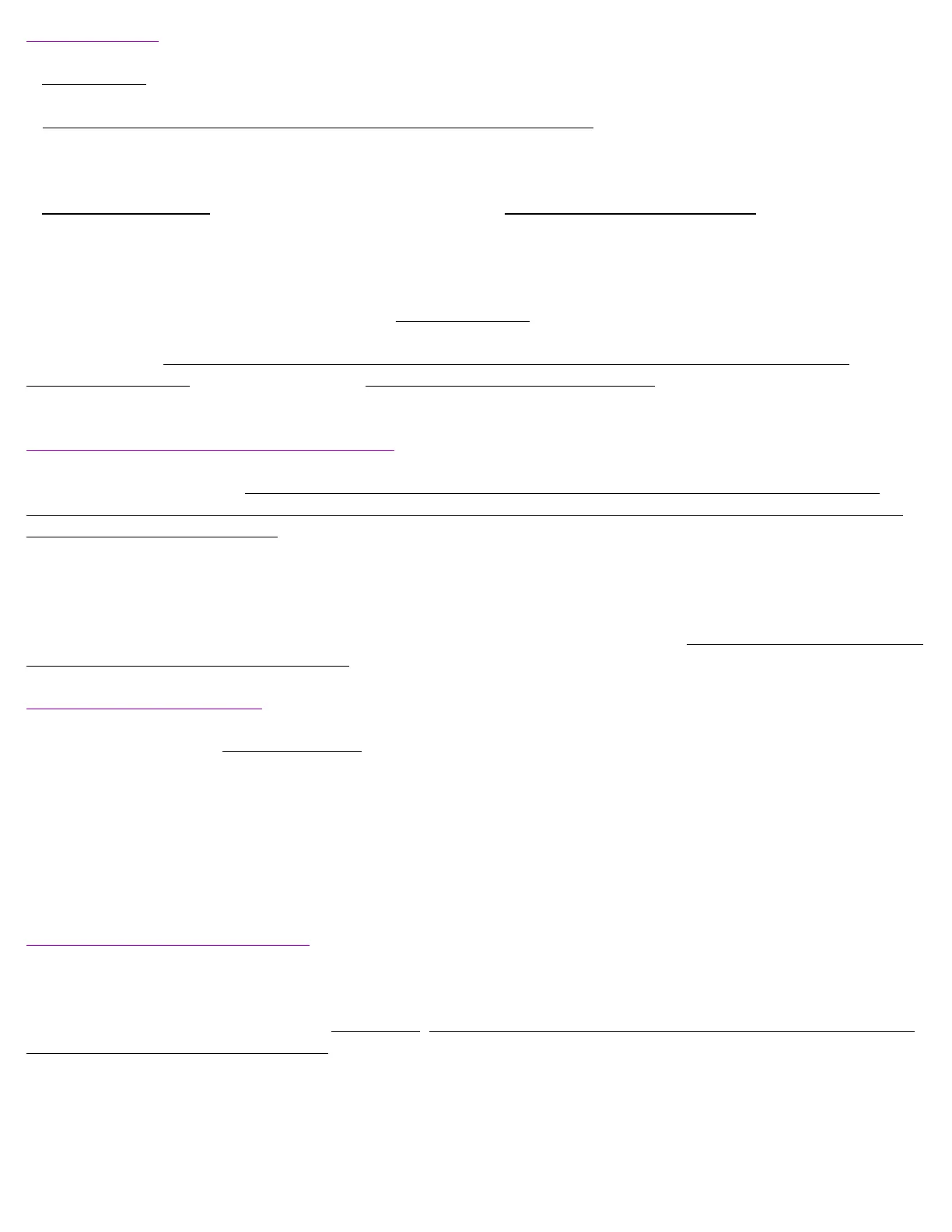
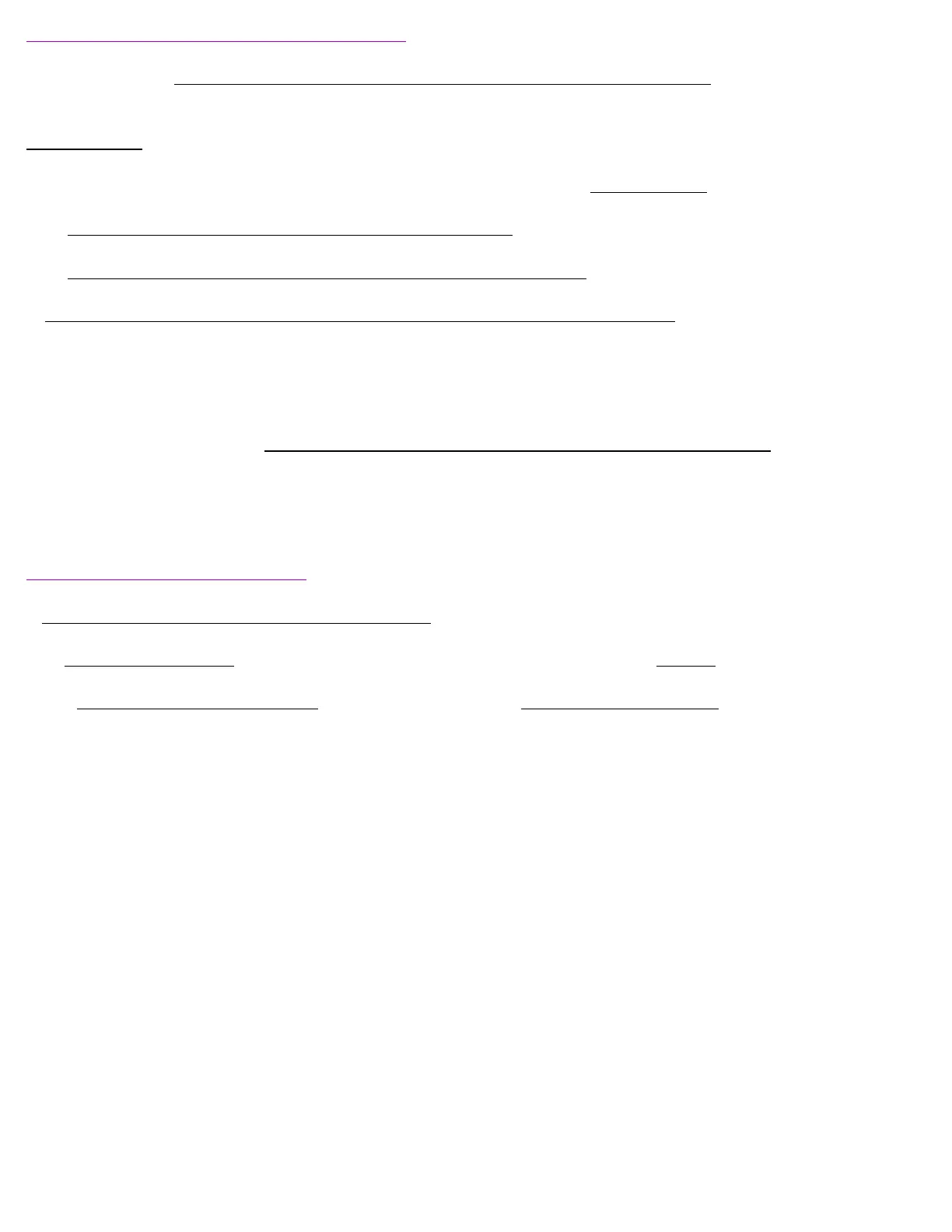
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
POSITIVISMO
Il Positivismo è un movimento filosofico e culturale che nasce in Francia nella prima metà dell'Ottocento, ma si diffonde in tutta Europa e nel mondo soprattutto nella seconda metà del secolo. È caratterizzato dall'esaltazione della scienza e della razionalità, e rappresenta la filosofia della società industriale moderna.
Il termine "positivo", da cui deriva il nome del movimento, ha due significati principali:
- significa ciò che è reale, effettivo, sperimentale, in opposizione a ciò che è astratto o metafisico;
- indica anche ciò che è utile, pratico ed efficace, opposto all'inutile e all'ozioso.
Uno dei padri fondatori del Positivismo è Auguste Comte, che lo sistematizza e lo rende una vera e propria dottrina filosofica.
Per i positivisti, la scienza è l'unica forma di conoscenza valida, e tutto ciò che non è verificabile sperimentalmente - come la metafisica - viene considerato privo di valore. In effetti, uno dei motti fondamentali del movimento era: "Niente più metafisica!".
La funzione della filosofia nel positivismo
Nel pensiero positivista, la filosofia perde il suo carattere speculativo: essa non deve più cercare verità assolute, ma piuttosto riorganizzare e coordinare le scoperte delle varie scienze, creando un sapere unificato e razionale.
Questo approccio viene poi applicato anche alle scienze umane, come la sociologia, considerata "la creatura prediletta" dei positivisti, perché capace di analizzare e migliorare la società usando il metodo scientifico.
Il positivismo nasce anche come risposta a una profonda crisi storica che aveva investito l'Europa dopo le rivoluzioni e l'epoca romantico-idealista: si proponeva quindi come un modo per riorganizzare la società in modo razionale e pacifico.
Le due fasi del positivismo
Possiamo distinguere due grandi fasi:
- nella prima metà dell'Ottocento, il positivismo cerca di superare la crisi culturale e sociale post- rivoluzionaria. È una proposta politica e filosofica organica, anche se a volte antiliberale (come in Comte);
- nella seconda metà del secolo, si presenta come la filosofia del progresso scientifico e industriale già in atto. Qui il positivismo diventa alleato del liberalismo e si diffonde soprattutto nei paesi più avanzati come Francia, Germania e Inghilterra.
Il clima di ottimismo scientifico
In questo periodo c'è un generale entusiasmo per la scienza e la tecnica, viste come strumenti di progresso umano.
Si sviluppa un vero e proprio culto dello scienziato, celebrato come l'eroe moderno, accanto a figure come l'ingegnere, il medico e il maestro.
Rapporti con Illuminismo e Romanticismo
Il Positivismo ha legami stretti sia con l'Illuminismo sia con il Romanticismo:
Illuminismo:
eredita la fiducia nella ragione, nella scienza e nel progresso, ma si differenzia perché:
- gli illuministi avevano una forte carica rivoluzionaria, mentre i positivisti sono riformisti e antirivoluzionari;
- gli illuministi cercavano di fondare la scienza su basi critiche (vedi Kant), mentre i positivisti danno per scontata la validità della scienza, senza problematizzarla;
- l'Illuminismo usava la scienza per distruggere le credenze tradizionali; il Positivismo, soprattutto in Comte, cerca di ricostruire nuove certezze quasi religiose.
Romanticismo:
Con il Romanticismo il rapporto è più complesso. A prima vista sembrano opposti, ma in realtà il positivismo assume lo stesso slancio assolutizzante del Romanticismo, solo che al posto del sentimento e dell'arte, assolutizza la scienza. Per questo, alcuni studiosi parlano del positivismo come del "romanticismo della scienza".
Le diverse forme di positivismo
Il Positivismo non è un movimento monolitico. Si può divide:
- in positivismo sociale (prima metà del secolo), rappresentato da Saint-Simon, Comte e Stuart Mill;
- e in positivismo evoluzionistico (seconda metà del secolo), influenzato da Darwin e rappresentato da Spencer, i materialisti tedeschi e Ardigò in Italia.
COMTE
Auguste Comte - Fondatore del Positivismo
Oggi espongo il pensiero di Auguste Comte, considerato il fondatore del Positivismo, una corrente filosofica dell'Ottocento che attribuisce alla scienza un valore assoluto e vede nel metodo scientifico l'unico strumento valido per conoscere e organizzare la realtà.
1. Vita e contesto biografico
Comte nacque a Montpellier nel 1798. Dopo aver studiato alla Scuola Politecnica di Parigi, iniziò a lavorare come insegnante di matematica. In gioventù fu collaboratore e amico di Saint-Simon, uno dei primi teorici del socialismo, dal quale però si distaccò presto, nel 1822, per elaborare un pensiero autonomo, già espresso nel Piano dei lavori scientifici necessari per riorganizzare la società.
Nel 1826, Comte fu colpito da una grave crisi mentale, durante la quale fu internato in manicomio. Ne uscì un anno dopo, sostenendo che a guarirlo fosse stata la propria forza interiore.
Tra il 1830 e il 1842 pubblicò i sei volumi del Corso di filosofia positiva, la sua opera più importante. L'opera fu mal accolta dall'ambiente accademico, al punto che Comte perse anche un modesto incarico alla Scuola Politecnica.
Nonostante ciò, continuò a scrivere, sostenuto economicamente da amici e discepoli.
Nel 1845 conobbe Clotilde de Vaux, con cui instaurò un rapporto puramente spirituale. Dopo la sua morte, Comte la idealizzò come una sorta di Beatrice dantesca. Morì a Parigi nel 1857.
2. La legge dei tre stadi
La legge dei tre stadi è il cuore della filosofia comtiana. Secondo Comte, ogni sapere umano evolve attraverso tre fasi storiche:
- Stadio teologico o fittizio: l'uomo spiega il mondo tramite esseri sovrannaturali o divinità (come nella mitologia greca o nelle religioni monoteistiche).
- Stadio metafisico o astratto: le divinità vengono sostituite da concetti filosofici astratti (come "forze" o "essenze"), che però restano privi di verifica empirica.
- Stadio positivo o scientifico: l'uomo rinuncia a cercare cause ultime e si limita a descrivere e spiegare i fenomeni secondo leggi regolari, verificabili con osservazione e ragionamento.
Comte vede il Medioevo come età teologica, l'età moderna fino alla Rivoluzione francese come fase metafisica, e identifica il proprio tempo come inizio dell'età positiva. Ma, secondo lui, la transizione non è ancora completata, e proprio questa coesistenza di stili di pensiero è alla base della crisi sociale, politica e morale contemporanea.
3. La classificazione delle scienze
Comte intende costruire una vera e propria enciclopedia delle scienze, classificandole in base al loro grado di complessità e generalità. Le scienze progrediscono in modo storico e gerarchico, partendo da quelle più semplici fino a quelle più complesse:
- Astronomia
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Sociologia
La sociologia è la scienza più recente e complessa, e rappresenta il punto culminante dello sviluppo scientifico. Comte la chiama anche fisica sociale, e sostiene che deve studiare i fenomeni sociali secondo le stesse leggi naturali che regolano il mondo fisico.
Questa scienza si divide in:
- Statica sociale: studia l'ordine e la struttura delle società;
- Dinamica sociale: studia il progresso, cioè l'evoluzione storica continua e graduale dell'umanità.
La storia, per Comte, è progressiva: ogni fase prepara la successiva. Anche gli individui di genio (come Galileo o Newton) sono visti come strumenti di un'evoluzione necessaria, e se non fossero esistiti, il progresso avrebbe comunque trovato altre strade.
4. La filosofia della scienza
Comte concepisce la scienza come conoscenza descrittiva e predittiva, non speculativa. Il suo scopo è individuare leggi che permettano di prevedere i fenomeni, per poi modificarli a vantaggio dell'uomo. La sua formula è: Scienza -> previsione -> azione.
Comte rifiuta ogni metafisica e ogni ricerca di "essenze". Per lui i fenomeni sono tutto ciò che possiamo conoscere, e sotto di essi non esiste nessuna realtà più profonda o "vera". Questo è l'aspetto antiessenzialista del suo pensiero.
Anche se parte da un'impostazione empirista (secondo cui non c'è nulla nell'intelletto che non venga prima dai sensi), Comte riconosce anche l'importanza della ragione, che organizza i dati e scopre le leggi generali. E quindi un pensatore che unisce empirismo e razionalismo.
Altro principio fondamentale è quello di economia del sapere: il numero delle leggi deve essere il più piccolo possibile, ma ciascuna legge deve spiegare un numero molto ampio di fenomeni. È l'esempio della legge della gravitazione universale di Newton, che spiega tanto i moti celesti quanto i fenomeni terrestri.
5. La religione dell'umanità
Nell'ultima fase della sua vita, Comte sviluppa una vera e propria religione laica, chiamata "religione dell'umanità", descritta nel suo Sistema di politica positiva.
Secondo lui, la civiltà ha bisogno di una nuova unità morale e simbolica, dopo la fine del regime teocratico. Propone di divinizzare l'Umanità, intesa come il "Grande Essere" formato da tutti gli esseri umani passati, presenti e futuri.
I simboli della religione positivista sono:
- il Grande Essere: l'Umanità;
- il Grande Feticcio: la Terra;
- il Grande Mezzo: lo Spazio.
Comte arrivò a scrivere un catechismo positivista, un calendario positivista con santi laici (scienziati, filosofi, artisti), e propose rituali alternativi, come toccarsi la fronte, il cuore e la spalla per simboleggiare amore, ordine e progresso.
La morale si basa sull'altruismo: il motto è "vivere per gli altri". Secondo Comte, gli uomini non hanno solo istinti egoistici, ma anche "istinti simpatici" che l'educazione può rafforzare.
DARWIN
1. Il contesto filosofico: il positivismo evoluzionistico
Il positivismo evoluzionistico nasce dall'incontro tra il pensiero scientifico e alcune idee derivate dal Romanticismo. In particolare, assume il concetto di evoluzione non solo come principio biologico, ma come fondamento di una teoria generale della realtà. Secondo questa visione, tutto l'universo è coinvolto in un processo continuo, progressivo e necessario di trasformazione e miglioramento.
Questo modo di pensare si basa sull'idea romantica che il finito sia manifestazione dell'infinito, e si può dire che il positivismo evoluzionistico rappresenti una sorta di "storicizzazione" della natura, esattamente come il Romanticismo idealistico aveva fatto con la storia umana.
2. Le origini del trasformismo biologico
La teoria dell'evoluzione ha radici nel XVIII secolo, con autori come Buffon, Lamarck e Saint-Hilaire, che avevano ipotizzato la trasformazione delle specie. Tuttavia, le loro teorie non ebbero successo scientifico perché prevaleva la dottrina catastrofista di Cuvier, secondo cui le specie si estinguevano per eventi improvvisi e distruttivi.
Il cambiamento decisivo arrivò con Charles Darwin, che grazie anche alle scoperte geologiche di Lyell, fu in grado di proporre una teoria sistematica e fondata su osservazioni concrete.
3. Darwin e la teoria della selezione naturale
Darwin, nipote del naturalista Erasmo Darwin, dedicò la sua vita allo studio della natura. Dopo un viaggio di cinque anni a bordo del Beagle, pubblicò nel 1859 L'origine delle specie, opera rivoluzionaria che ebbe un enorme successo fin dal primo giorno di uscita.
La sua teoria si basa su due principi fondamentali:
- Le variazioni individuali: ogni individuo presenta leggere differenze, alcune delle quali possono risultare vantaggiose per la sopravvivenza.
- La lotta per l'esistenza: derivata dalle idee di Malthus, secondo cui la popolazione tende a crescere più rapidamente delle risorse, creando una competizione naturale.
Da questi presupposti nasce il concetto di selezione naturale: gli individui più adatti sopravvivono e trasmettono le loro caratteristiche ai discendenti. Accumulandosi nel tempo, queste variazioni possono portare alla formazione di nuove specie.
Darwin fa anche un parallelo con la selezione artificiale operata dall'uomo su piante e animali domestici.
4. Le implicazioni della teoria darwiniana
Secondo Darwin, tra le varie specie dovrebbero esistere numerose forme intermedie, molte delle quali sono scomparse ma di cui si trovano tracce nei fossili, negli organi rudimentali e nello sviluppo embrionale.
La sua visione è ottimistica: come il Romanticismo credeva in un progresso spirituale dell'umanità, Darwin crede in un progresso biologico, secondo cui l'evoluzione porta gli esseri viventi a perfezionarsi sempre di più.
5. L'uomo e gli altri animali
Nell'opera La discendenza dell'uomo (1871), Darwin afferma che non esiste una differenza fondamentale tra l'uomo e gli altri mammiferi superiori per quanto riguarda le capacità mentali. La differenza è solo di grado. Inoltre, introduce il concetto di selezione sessuale, che gioca un ruolo importante nell'evoluzione dell'uomo.
Darwin difende con forza la dignità umana, affermando che la nostra discendenza da esseri inferiori non è motivo di vergogna, e che la moralità e il comportamento sono i veri indicatori della nostra umanità.